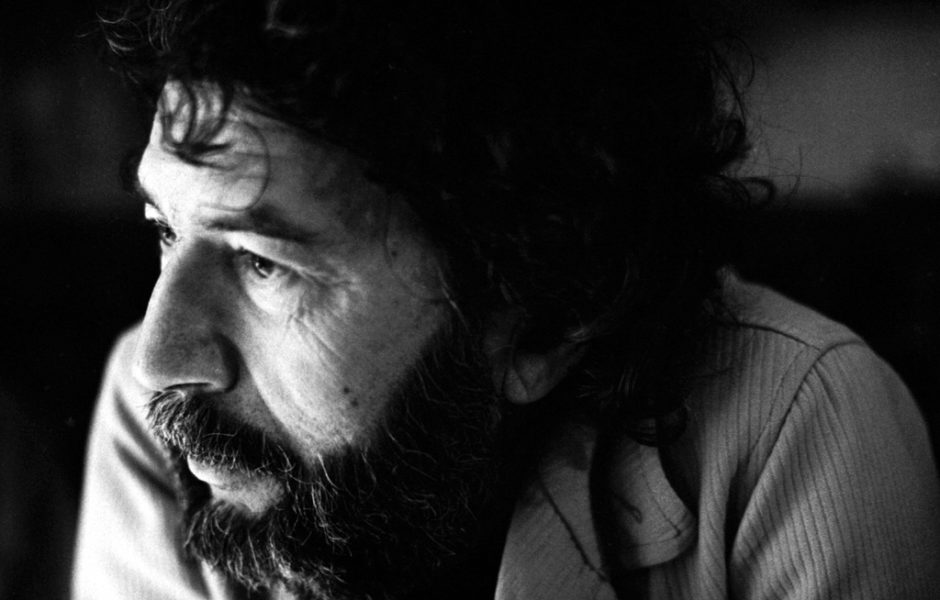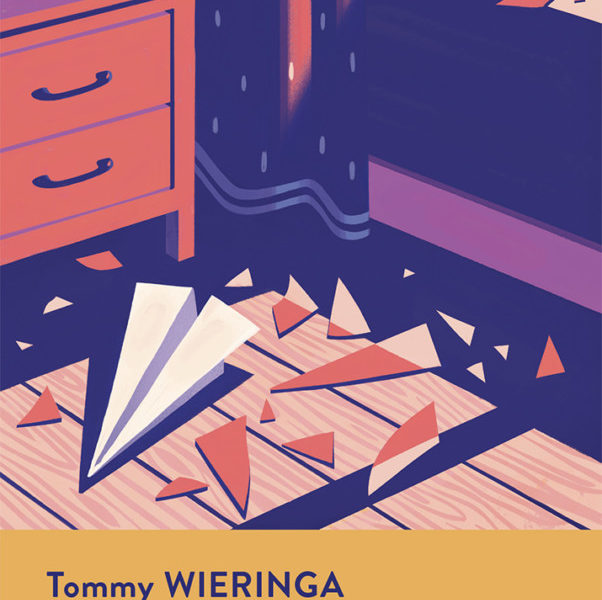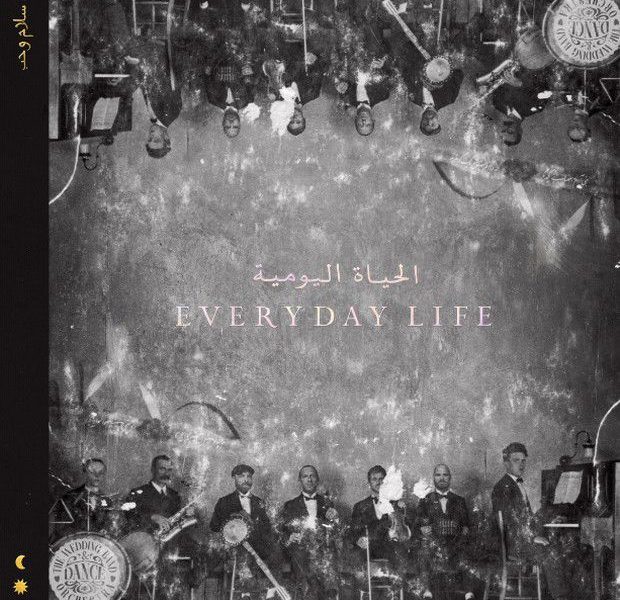«Tutto quel che si può leggere nel Pantarèi a proposito di Céline, di Faulkner e di Robbe-Grillet è farina del sacco di Stern», ovvero del protagonista di ispirazione vagamente autobiografica di questo romanzo. Il pantarèi, scritto ancora negli anni Settanta, pubblicato per la prima volta nel 1985, è stato riedito di recente da TerraRossa (per quanto riguarda la narrativa italiana, a mio avviso una delle case editrici più interessanti del momento). E figura nell’introduzione alla riedizione del volume l’affermazione secondo cui le riflessioni su questi tre scrittori siano «farina del sacco di Stern».
A ben guardare, molti intellettuali italiani erano allora a conoscenza di Robbe-Grillet anche attraverso le edizioni italiane della sua opera (quella del suo primo romanzo, Le gomme, di Franco Lucentini, poi riproposta da Nonostante edizioni, risale al 1961) e avrebbero senz’altro avuto la possibilità di conoscerlo da un punto di vista critico leggendo un po’ di letteratura secondaria. Mi fido ugualmente di quanto Ezio Sinigaglia ci racconta (anche se dovrei domandarlo a Stern) là dove ci confida che si è rapportato allo scrittore francese in un tête-à-tête, senza grandi sovraletture.
Nel Pantarèi, un romanzo acutamente metaletterario, un’intelligente riflessione sugli scrittori modernisti in cui alle parti narrative (in tondo) si alternano gli inserti (in corsivo), Le gomme riveste un ruolo fondamentale verso la fine. Ma già a p. 63, quando Stern dubita dell’efficacia del monologo interiore, si pone delle domande non lontane da quelle a cui i nuovi romanzieri hanno tentato di rispondere:
«Ma posso chiamare, questo, flusso di coscienza? Tanto per cominciare: gli errori di battitura li devo trascrivere? […] Gli spazi fra una parola e l’altra sono come colpi di nocca sul tavolo. E gli oggetti che sono intorno a me? I libri le penne il muro bianco la finestra le mie dita la manica color sabbia del maglione. Non si può dire che li guardi, ma certo li vedo».
Stern sta lavorando a un’enciclopedia. Un’importante casa editrice specializzata in opere divulgative (e di cui si tace il nome) gli ha commissionato la voce “romanzo del Novecento” per una singolare “Enciclopedia della donna”. A proposito di Zeno Cosini, Stern scrive:
«Lo sguardo è puntato sull’uomo, o meglio nell’uomo: argomento del romanzo è proprio, letteralmente, “la coscienza di Zeno”. Con asciutto rigore clinico, Svevo scava nella patologia del suo personaggio: poiché d’una coscienza malata [tondo mio] si tratta, e il romanzo è la storia di questa malattia».

Uno degli interventi di Pour un Nouveau Roman (1963), opera saggistica di Robbe-Grillet, si intitola proprio La conscience malade de Zeno. È un sintagma abbastanza prevedibile, certo, uno spostamento quasi naturale. Ma mi sia concesso di dubitare un po’ del fatto che Stern, un onomaturgo amante della lingua e della letteratura francese, non fosse a conoscenza della rivoluzione epistemologica veicolata dalle sperimentazioni, teoriche oltre che letterarie – i confini tra critica e letteratura sono sempre e comunque labili: sta lì a testimoniarlo anche Il pantarèi –, dei nuovi romanzieri.
Più avanti, alcune descrizioni che ci offre il protagonista, piene di dettagli, potrebbero parzialmente ricordare quelle di Robbe-Grillet, con le quali condividono determinati elementi (per esempio una certa cura della dimensione spaziale, una meticolosa geometria, le linee che si intersecano, la ripetizione di destra e sinistra, la sovrapposizione dei piani). C’è tuttavia una differenza sostanziale: dalla sua storia, Stern non eclissa i personaggi e anzi cerca di descriverli, a volte per sommi capi, altre con maggior precisione:
«Madame Stella, senza dire una parola, fece cenno a Stern di seguirla. Si addentrarono nel corridoio, che era stretto e oscuro, ma si allargava, ogni dieci passi, in ampie e luminose piazzuole circolari. Ne attraversarono tre, tutte identiche fra loro: a destra e a sinistra, due perfetti semicerchi, delimitato ciascuno da una grande vetrata, sotto la quale correva un divano ricoperto di seta rossa cangiante. Anche il quarto salottino, al centro del quale madame si arrestò silenziosamente, era del tutto simile ai precedenti, senonché alla base dell’emiciclo di destra, parallelamente alla direzione del corridoio, era stata disposta un’ottomana sopra la quale, adagiata mollemente su un fianco, la guancia poggiata sul palmo della mano destra, stava distesa Anna. I capelli, tinti di nero, contrastavano vivamente con l’ovale bianchissimo del volto che incorniciavano, mentre il verde intenso degli occhi era sottolineato dall’ampia veste di seta, dello stesso colore, che la copriva fino ai piedi, raccogliendosi in ricchi drappeggi».
Lo sviluppo di questa citazione ha quindi in un certo senso una sua circolarità, o una blanda ricorsività circolare degli elementi; lo sfondo è subordinato ai personaggi, la dimensione spaziale a quella umana: personaggio (Madame Stella), spazio esterno e ancora personaggio (Anna). La descrizione onirica delle piazzole, grazie all’uso di parole come identiche, perfetti, emiciclo e parallelamente, suscita quello che potremmo definire un effetto di geometria. In realtà, si tratta di un sogno del protagonista, una breve parentesi di una narrazione poliedrica e pienissima di riflessioni (meta)letterarie dalla quale si capisce come Sinigaglia (pardon, Stern) non abbia patito nessuna angoscia dell’influenza, almeno da un punto di vista stilistico – molti gli stili interiorizzati, certo (Balestrini, per esempio), ma nessuno di essi prevarica gli altri. Stern non si lascia plagiare neanche scrivendo i paragrafi su Kafka, continuamente interrotti, con effetto comico e straniante, prima dalla registrazione in presa diretta del subbuglio interiore dovuto al ricordo di Carmen, una sua amante giovane e fresca, e poi dall’arrivo del geometra Sambò, un vicino di casa disturbato dal ticchettio della Lettera 22; e che dire delle rocambolesche avventure del ragionier Sperindio? Fantastiche. Mi hanno ricordato Morselli e Wilcock.
Delle Gomme, Stern ricorda in primis la citatissima citazione del pomodoro, descritto a prescindere dalle sue qualità come fosse un semplice oggetto. Forse questo romanzo gli è piaciuto così tanto proprio perché Robbe-Grillet fa tabula rasa e «si propone di detergere la superficie della realtà, e quindi quella della materia narrativa, liberandola di tutti i successivi strati di arbitrarietà che secoli di letteratura vi hanno disteso l’uno sull’altro». La tanto paventata (o auspicata) morte del romanzo, la stessa di cui scrive Sinigaglia introducendo la nuova edizione del Pantarèi, non ha avuto luogo: né negli anni Settanta, né dopo. E per quanto questo genere sopravviva talvolta senza nessuna qualità, in una forma omologante e convenzionale – benché i giudizi di valore vengano ormai demonizzati a prescindere e la critica militante, quella vera e dialettica, sia ormai diventata quasi un tabù –, i romanzi di qualità continuano a esistere.
Come ci spiega Stern, Robbe-Grillet ha saputo allo stesso tempo distruggere e creare, inserendosi nella stessa tradizione che criticava apertamente. Paragonato a Musil, il romanziere francese ha decostruito gli elementi strutturali del romanzo classico (vicende, personaggi, ambiente) per proporre, insieme agli altri nuovi scrittori (e nonostante le differenze), una forma alternativa di letteratura, al di là del personaggio e del soggetto. Debenedetti (Il romanzo del Novecento, 1970) ha parlato di antipersonaggio in relazione ai romanzi di Robbe-Grillet: a differenza di Stern, tuttavia, Debenedetti non apprezzava affatto le derive contemporanee della narrazione sperimentale, né la freddezza disumanizzante della sua prosa.
Il movimento di cui è considerato il caposcuola, tuttavia, si chiama nouveau roman: gli antipersonaggi (ma sarebbe quasi meglio dire: la scomparsa dei personaggi) e la forma del romanzo non entrano in contraddizione. Nel “racconto critico” debenedettiano la narrativa di Robbe-Grillet rappresenta una sorta di tragico punto di non ritorno: il fondatore dell’école du regard è ritenuto responsabile dell’assassinio del personaggio-uomo e quindi, ipso facto, della irreversibile disgregazione della forma-romanzo antropocentrica, e quindi del romanzo tout court.

Non ho resistito alla tentazione di interpellare direttamente l’autore del Pantarèi su questa affinità divergente rispetto a Debenedetti. Sinigaglia spiega così il senso della presenza di Robbe-Grillet nell’economia del suo romanzo: «È vero: Debenedetti non lo ama proprio per via della freddezza disumanizzante della sua prosa, ma a dire il vero non mi sembra voglia ascriverlo alla categoria degli antiromanzieri; in ogni caso, è proprio la sua ‘posizione di confine’ che mi ha attratto, in Robbe-Grillet, convincendomi dell’opportunità di farne il punto d’arrivo paradossale (e non-concludente) del saggio di Stern e del romanzo stesso. Robbe-Grillet vuole destrutturare quel che resta del romanzo, ma vuole scrivere romanzi, non anti-romanzi. Non per niente la scuola da lui fondata si chiama nouveau roman. Si è soliti affermare che questa scuola, detta anche école du regard, è tipicamente anti-romanzesca perché lascia nel mondo tutti gli oggetti che lo compongono, sottraendone l’uomo. Ma lo sguardo dell’uomo, il suo occhio, sono indispensabili alla narrazione: nulla avrebbe senso senza il regard umano. Purtroppo, ma ben comprensibilmente, questa presenza soverchiante dell’occhio ha fatto scivolare Robbe-Grillet dal romanzo nel cinema, con esiti non felicissimi e, soprattutto, controproducenti rispetto alla sua attività di scrittore».
E ancora: Sinigaglia, intervistato su Crapula da Giuseppe Girimonti Greco, ben prima che la riedizione del Pantarèi diventasse un piccolo ‘caso’ editoriale, già cercava di spiegare perché Stern avesse canonizzato Robbe-Grillet, e lo faceva in questi termini:
«Robbe-Grillet, poi, nei suoi libri successivi, a mio parere si perde un po’ per strada, ma la cosa interessante di questo scrittore (la cosa che mi ha indotto a inserirlo nel canone del Pantarèi) è il fatto che abbia anche molto teorizzato sul suo lavoro di scrittore e sul nouveau roman da lui fondato, e questo mi offriva la possibilità di contrastare la sua teorizzazione con un’altra teorizzazione (fondata sulla metodologia del paradosso) per dimostrare non soltanto come il romanzo non sia morto ma addirittura come proprio la posizione di questo autore porti a concludere che è impossibile ucciderlo, il romanzo, perché restano pur sempre, alla fine, un autore, un libro e un lettore».
Così, sul filo dell’ironia, Stern immagina un libro di Robbe-Grillet recensito (in realtà descritto) par lui-même:
«Il libro è un parallelepipedo molto schiacciato e non perfettamente squadrato, in quanto presenta un dorso leggermente convesso cui corrisponde una leggera concavità della faccia opposta. A giudicare dallo spessore, dovrebbe contenere circa cento fogli. La copertina rigida, di colore rosso, nascosta da una sovracoperta bianca e lucida, è visibile solo osservando le due facce laterali più corte. Essa sporge di circa un millimetro oltre il bordo delle pagine ed è rinforzata, in corrispondenza del dorso, da un cordoncino dello stesso colore. Eccetera eccetera».
Verso la fine della sua riflessione sulle Gomme e in generale sull’intera produzione di questo scrittore, il narratore arriva a una conclusione intelligente, benché obbligata: l’unico oggetto che sopravvive incolume alla disumanizzazione della letteratura è il romanzo stesso (perché altrimenti non potremmo leggere Robbe-Grillet, né nient’altro), oltre che naturalmente la parola. L’enciclopedia a cui Stern sta lavorando finisce sul nouveau roman: «La conclusione, meno paradossale di quanto sembri, è che non c’è nessuna conclusione. E con questa frase, che giaceva ironicamente in perfetta solitudine in cima all’ultimo foglio, Stern aveva davvero concluso».
A queste due conclusioni impossibili e paradossali non mi resta che aggiungerne una terza, sicuramente più inutile, perché non è necessario che scriva nient’altro.
PS: Vi assicuro che non è uno spoiler. Leggete Il pantarèi per sapere se vi sto mentendo!