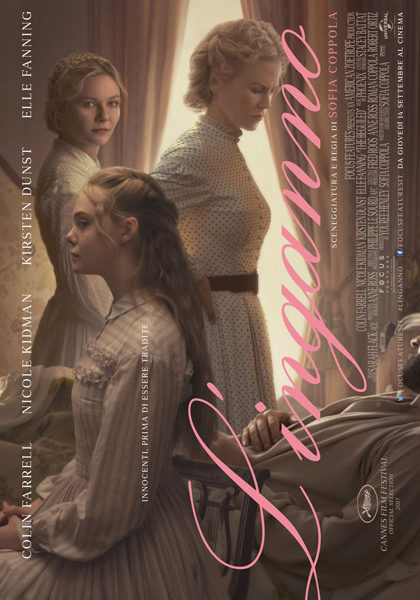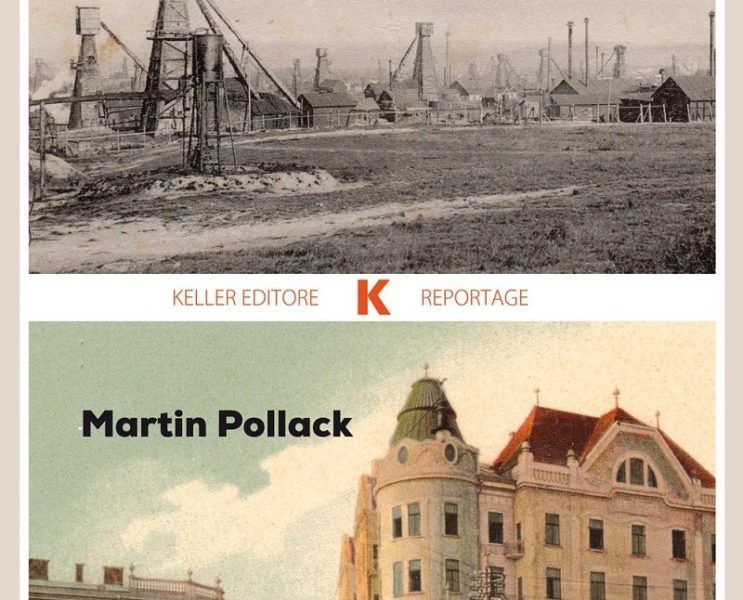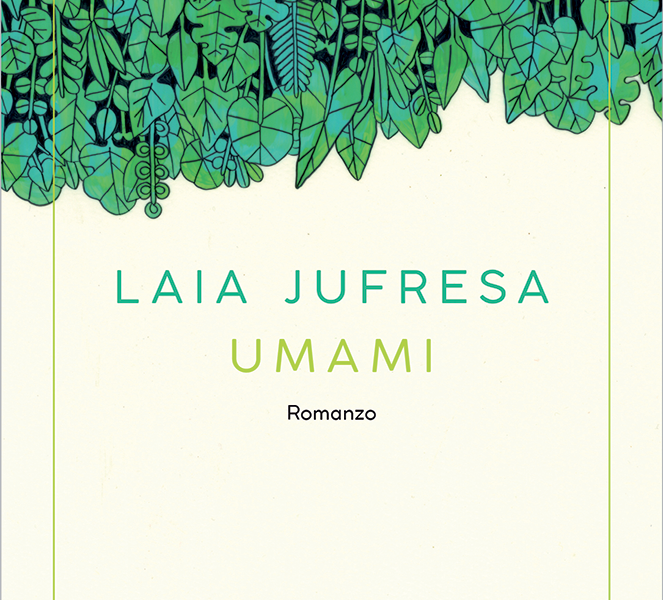Mi sono messo il piumino azzurro, quello che ho preso l’anno scorso, Nadia mi ha visto e ha tentato di fermarmi. Dove stai andando?, mi fa, con due occhi così. Non puoi uscire, mi dice, poi si pianta sulla porta e inizia a spingermi verso il tavolo. Io le dico che non ce la faccio più a stare lì, che non ho alcuna intenzione di rintanarmi in casa come un malato, che prima o poi si deve ricominciare a vivere. Ma lei non sente, dà un’occhiata fuori come se dal quarto piano si vedesse la strada.
Siamo rimasti così per un po’, stretti uno addosso all’altra. Alla fine le ho abbassato le mani. Per quel che mi riguarda, le ho detto, la mia vita ricomincia adesso. L’ho fissata e dovevo avere un’espressione davvero terribile, Sergio, perché lei si è subito ritirata.
Si è seduta in un angolo del divano, ha incrociato le braccia e non ha più detto nulla. Aveva ancora addosso il pigiama, odorava di caldo e comodità, mentre io con il piumino mi sentivo un pagliaccio. Bene, le ho fatto, battendo le mani sul petto, come per togliere la polvere, e sono andato alla porta. Sapevo che qualcos’altro dovevo pur dirle, ma non mi è venuto in mente niente.
Il televisore era acceso, ma senza il volume, così noi potevamo farci compagnia e gli altri non potevano sapere se eravamo in casa. La presentatrice teneva in mano un foglio. Dettava cose a dei tizi vestiti da cuochi dietro a dei tavoli, muoveva le labbra in silenzio verso quei tizi con il grembiule rosso e verde che cucinavano. A un certo punto ha alzato gli occhi e si è messa a ridere. A me è venuto da vomitare.
Sono uscito.
Fuori, sul pianerottolo, ho sentito una porta chiudersi. Vicini di casa. Razza di bastardi, ho pensato. Mi sono tirato la cuffia sulla fronte, ho chiuso la porta e ho fissato l’ascensore. Poi però ho preso le scale.
Il parcheggio era pieno di gente, li vedevo attraverso i vetri dell’ingresso. Si muovevano tutt’attorno come squali, alcuni avevano dei cartelli in mano, tutta roba che riguardava il bambino. Non potevo uscire da lì. Mi sono guardato in tasca, le chiavi dei garage ce le avevo quindi sarei potuto andare giù e risalire dall’altra parte, come una talpa in un cunicolo.
Dal parco, la gente si vedeva ancora. Non si erano accorti di me, mi sembravano tanti piccoli pupazzetti malvagi. Camminavo più in fretta che potevo, un po’ per il freddo e un po’ perché avevo una gran voglia di togliermi dalle scatole. C’era ancora qualche spruzzetto di neve, qua e là, anche se il grosso ormai si era sciolto. Il cielo era grigio, pesante, il campanile del duomo svettava sui tetti e gli alberi del parco. Il resto era un misto di freddo, aria pallida e tutto lo smog di questo mondo. È sporca la mia città, in inverno, si fa fatica persino a respirare.
C’era una mamma con i suoi bambini vicino alle altalene, l’ho guardata appena mentre le passavo accanto. Un sergente, pareva, con due piccoli astronauti, due esserini gonfiati di gomma. Erano buffi. Il maschietto ce la metteva tutta a spingere la sorella, ci dava proprio dentro e si vedeva che faceva una fatica boia. Il risultato però era deprimente.
Ho rialzato la testa, la mamma mi stava osservando. Qualcosa mi è morto sul viso, mi sono stretto nelle spalle e ho allungato il passo. Gli occhi pesanti di quella donna li ho sentiti sulla schiena per tutto il tempo, e anche dopo, quando ormai ero giunto in centro. Lì, almeno, speravo di confondermi con il resto della gente.
Erano tutti in giro a comprare i regali dato che oggi è la Vigilia. Ci sono queste luci appese alle case, per le vie del centro, sono tutte gialle e lampeggianti e i negozi sono tutti in tiro, sembra che vogliano attirarti e poi mangiarti. Come i pesci degli abissi, no? Eppure, lo devo proprio dire, c’era tutta quest’aria di gran felicità. La nauseante accoglienza che può darti una via del centro, in inverno, a Natale. C’era persino un barbone con un sombrero rosso e bianco.
Questa felicità, Sergio, io la percepivo, eccome, ma da lontano. Come quando guardi i colori di un acquario, dentro a una stanza brutta. Sentivo anche tanta indifferenza dietro la superficie di quel mondo dorato. Però va bene così. Mi sono detto, l’indifferenza è proprio ciò di cui ho bisogno.
Ma mi sbagliavo. Ho sentito l’aria che si spostava ancora prima che il colpo mi arrivasse sul collo e il brodo colasse giù, caldo e appiccicoso lungo la pelle della schiena. Devo aver sviluppato una specie di sesto senso, immagino. Mi sono girato e dietro di me c’era un ragazzino che avrà avuto sì e no dieci anni. Teneva il dito sollevato verso di me, per terra un cartoncino vuoto e qualche cappelletto che agonizzava in una pozzanghera di brodo fumante. Cappelletti fast food, la moda del momento. Li mangi mentre vai in giro, te li fanno anche pagare piuttosto bene. Noi qui li chiamiamo galleggianti, i cappelletti, perché stanno a galla come tante boe dentro al loro mare ustionante. I genitori hanno raggiunto il figlio in un attimo, quasi correvano, lo giuro, e il padre aveva un’aria sconvolta. Anzi, no, forse sconvolta è troppo, però sembrava davvero dispiaciuto. L’hanno afferrato che aveva ancora il braccio alzato. La madre ha fatto per dire qualcosa, poi mi ha visto e in un lampo l’ha capito. Le labbra strette come due fessure, tremava di rabbia e i suoi occhi dicevano tutto quello che c’era da dire. Chissà perché le donne ci arrivano sempre prima in queste cose. Sarà l’intuito femminile. Ma a così tanto odio non ci si abitua, Sergio. È impossibile, non riesci proprio a farci i conti.
La gente mi detesta, la città, il paese, forse il mondo intero mi detesta, e gran parte della colpa è di Giusy. Su questo, Sergio, non puoi proprio non darmi ragione.
Ce l’ha messa tutta, Giusy. Prima con gli amici, poi con le autorità, ha persino provato a lanciarmi addosso qualche avvocato pazzoide. E la notte, ti confesso, non riesco più a dormire perché penso che da un momento all’altro qualcuno potrebbe entrare, magari uno zingaro, o qualche altro poco di buono pagato da lei o da Alfonso. Le ha provate tutte, quindi chi può escluderlo? Quando ha visto che con la legge non ce la faceva, che il nostro era un caso eccezionale e che non c’erano precedenti in tutta la storia, Giusy ha fatto l’unica cosa che le rimaneva da fare: si è rivolta ai giornali. E lì la questione ha fatto breccia come un coltello dentro alla carne cruda. Lì, di gente da spremere, Giusy ne ha trovata, eccome. E le cose, per me e per Nadia, non hanno fatto che peggiorare.
Che devo dirti, ormai mancano pochi giorni e una decisione devo pur prenderla. Ormai siamo agli sgoccioli e tra la stampa, la tv e internet qui è diventato un inferno (tanto per rimanere in tema). Mi sento tutte le luci addosso, mi sembra di essere sul fondo di un imbuto con tutta la gente che urla lanciando cose dall’alto. E nonostante questo non riesco a condannarla. Immagino che anche lei debba sentirsi disperata, dico davvero.
Ma una cosa è sicura: io, di lasciare questo mondo, proprio non ne ho voglia. Ho trentadue anni, e la vita aveva appena preso una piega decente. Il progetto a cui stavo lavorando era quasi pronto e un investitore aveva persino deciso di finanziarlo. Uno piccolo, intendiamoci, ma pur sempre meglio di niente. Anche per Nadia le cose si stavano sistemando, stava cambiando lavoro. Capirai quindi che io, di sacrificarmi, non ne ho alcuna intenzione.
Te l’ho scritto, Sergio, voglio prendere di nuovo in mano la mia vita. Mi spiace per Giusy, ma non sono mica un eroe. Sono uno che ha paura, proprio come tutti gli altri. Paura delle cose che fanno paura alla gente normale, che ti credi? La morte, le malattie. La miseria. Cose così, insomma. E quelli che agitano i loro cartelli contro di me, anche loro dovrebbero saperlo, anche loro avranno pur paura di qualcosa. Parla bene, la gente, mica ci sono loro al mio posto. È facile, così. Pronti a puntare il loro dito contro. Che ci si infilino loro nei miei panni, dico io! Che si facciano aiutare dai politici o da qualche santone di turno. Che invochino ancora il Diavolo, o Dio in persona, questa volta. Se gli riesce. Che gli chiedano di farsi sostituire a me, dato che sono così bravi e coraggiosi. Loro, gli eroi. Bambino o mica bambino.
Prima che qualcuno si mettesse a gridare ho girato le spalle e mi sono infilato in un vicolo, mica potevo starmene lì. Ho tirato giù il cappuccio maledicendo la mia stupida idea di mettermi questo piumino azzurro squillante. Peggio di un razzo segnalatore o del triangolino sui calciatori dei videogiochi. Maledetta la mia situazione, maledetta Giusy e maledetto il giorno del battesimo!
È quasi passato un mese, ormai, dal battesimo di Michelino, ma a me sembra soltanto una settimana. Tu non c’eri, Sergio, ma di sicuro hai visto il video. Ora ti racconto come l’ho vissuta io.
Quel giorno Giusy continuava a fare foto, filmini, riprendeva uno per uno tutti gli invitati con in braccio il piccolo Michelino. Non se ne poteva più, non ne poteva più nessuno, compresi quelli che adesso ce l’hanno con me. Manuel, poi, l’ha presa in giro per tutto il tempo. Ci si metteva dietro e faceva certe facce, imitava gli occhi storti del bambino.
Manuel ora non mi risponde più. Lo chiamo e non risponde, è come se non esistessi. Anche gli altri non mi rispondono, mando le mail ma non arriva indietro niente. Nelle chat prima leggevano e basta, poi hanno smesso di fare anche quello. Alla fine si sono tolti, qualcuno ha persino bloccato il mio profilo. Non riesco a comunicare con nessuno, mi trattano come un appestato, uno da cui si deve stare alla larga. Ho provato anche alla vecchia maniera analogica, cioè con la carta, proprio come sto facendo ora con te. E penso sia davvero un’ottima idea perché così nessuno mi può intercettare. Penserai che sono paranoico, forse hai ragione. Comunque, non rispondono nemmeno alle lettere, magari però le leggono.
Tornando al dannato giorno del battesimo. Quel giorno si stava davvero bene. Nonostante Giusy, e nonostante Alfonso che le correva dietro come un cane. Faceva freddo, ma c’era il sole. Io ero con Robertino a giocare sui trattori. Avresti dovuto vederlo, Robertino va matto per i trattori. Come tutti i ragazzini, del resto. La casa di campagna del papà di Giusy dev’essere un posto magico per un ragazzino. Ci sono le anatre, le mucche, i cavalli. Questo per farti capire quanto li amo, io, i bambini, e che tutto quello che dicono e scrivono su di me sono solo stronzate. Quel giorno lì è stato l’ultimo giorno felice della mia vita, e anche della vita di Nadia, puoi starne certo.
Verso sera è arrivata la nebbia. Quando c’è il sole in campagna d’inverno, poi arriva sempre la nebbia, puoi metterci la firma. Ma quella era una nebbia strana, io l’avevo capito. Ho raggiunto gli altri, e poi è successo.
E chi poteva prevederla una cosa simile? Solo nei film accadono certe cose. E quel tipo, quello che ha ripreso tutto con il cellulare. Quello è stato il vero dramma perché i casini sono iniziati tutti da quel video. Solo Dio sa il danno che m’ha fatto. Avrei dovuto prenderlo e sbatterlo contro un albero, il suo cavolo di cellulare, e invece non ho fatto niente. Sono rimasto a bocca aperta come tutti gli altri. In mezzo alla puzza di zolfo, al fumo delle fiaccole, accerchiato dalle luci azzurre dei telefonini, le nostre torce del futuro. E i cani che urlavano come lupi e i cavalli che per poco non tiravano giù le stalle. Dio, che roba.
Alla fine, quando la nebbia s’è diradata, mi sono guardato in giro. Erano tutti lì, fermi a osservarmi. Il perché lo sai anche tu. Lo sanno tutti, ormai.
Poco fa ero davanti a una vetrina. C’erano certe locandine incollate al vetro. Posti esotici, quest’anno pare vada un casino il Messico. Ci sei mai stato Sergio? Non sai quanto li vorrei anch’io, dei regali per le mani. Darei meno nell’occhio. Ma se entro in un negozio è sicuro che mi riconoscono, e allora sì che scoppia un altro casino.
Il bar dove sono adesso sembra tranquillo, si sta bene e al caldo. C’è solo il problema della schiena, me la sento tutta appiccicosa. Per via del brodo, piccola peste. In ogni caso, sto sul chi va là. Come un gatto. Sto attento a qualsiasi movimento. Persino ai respiri.
Sarà una madre e sarà anche disperata, però Giusy è sempre stata un’opportunista. Egocentrica e rompiscatole. Non so come faccia Alfonso a sopravvivere con una così. Che poi, per qualche strano motivo che non so spiegarmi, lei ce l’ha sempre avuta con me. E ora mi chiedo se le due cose non siano collegate, in qualche modo.
Ogni volta che ci sono io e c’è anche lei, Giusy prende nota di tutto quello che faccio. Mi tiene d’occhio, insomma. Guarda se preparo il tavolo, se sparecchio, se tiro l’aspirapolvere, cose così. Se cucino. Che poi lo sanno tutti che non so cucinare. Lei comunque deve sempre farlo notare.
Una volta pure Nadia le ha detto, Giusy, e lascialo un pochino in pace, Cristo santo. Non ne poteva più neanche lei, e sai bene la pazienza che ha la mia Nadia. Che magari è anche così, cavolo, magari è vero che non mi faccio in quattro per gli altri, ma non do neanche fastidio a nessuno. E se mi dicono di fare una cosa, stai pur sicuro che la faccio, e senza lamentarmi. Solo, non sono uno che prende l’iniziativa.
Ma poi, dico io, se agli altri va bene così, a Giusy che gliene frega? Che se vogliamo guardare in casa sua, allora, cosa dobbiamo dire di lei e suo marito? Povero Alfonso, sgobba come un negro tutto il santo giorno e per fortuna che ha un buon stipendio, altrimenti Giusy si scorderebbe lo yoga, le lampade, il personal shopper e il parrucchiere ogni venerdì. Ho anche saputo che quando arriva a casa, poveretto, deve pure ciucciarselo lui, Michelino, perché Giusy deve guardare i programmi alla tv. Ci mancherebbe, pretende la sua libertà.
E poi Giusy è invidiosa. È una di quelle che se le cose non le vanno meglio di tutti allora il mondo può mettersi a girare al contrario, pur di accontentarla. Rode di invidia, dai retta a me.
Prendi la storia dei figli. Quando tutti si sono messi a figliare come conigli lei andava in giro a dire che non aveva tempo perché era una donna in carriera. Poi è arrivato Michelino e la musica è cambiata, Giusy è diventata la madre perfetta. E tutte quelle senza figli, che cosa aspettavano a farli? Che pena, si vede che erano donne vuote e tristi. Nadia non le ha mai detto niente, ma ti assicuro che ci è rimasta davvero molto male.
Ti confesso una cosa, Sergio. A noi andava bene anche così. Noi, a Giusy, credici o no, le volevamo bene, non ti sto mica mentendo. Le persone ci vengono fuori, con i difetti, mica puoi farci niente, ce li abbiamo tutti e quindi le devi prendere come sono. Anche se personalmente ritengo che i lunatici siano i peggiori. Non le sopporto proprio, io, le persone lunatiche. Come quelli che da un giorno all’altro smettono di fumare e allora iniziano a rompere le palle a tutti quelli che fumano perché gli avvelenano l’aria. E per dimostrarti che non conto mica fesserie ti dirò di più, Giusy per me ha anche delle ottime qualità. Sennò che ci stavamo a fare, tutti, con lei? Mica siamo masochisti o coglioni. Giusy, quando vuole, con le persone ci sa davvero fare. E qui, maledizione, arriviamo al fulcro del mio problema. Ho la metà del pianeta contro, senza contare quelli che non hanno internet e la tv. E tutto grazie a quel video, a Giusy e al suo maledetto saperci fare con la gente. Quel video sta facendo il giro del mondo ora che ti scrivo, praticamente è come se fosse in orbita. È Giusy a pomparlo dentro a ogni sito, ogni portale, ogni social network, e Alfonso che rema per accontentarla, le mani su diciotto tastiere diverse, usa persino le dita che non ha.
Navigo in un oceano di merda, Sergio. Solo che in quest’oceano di isole non ce ne sono, e nemmeno navi o salvagente. Qui si può solo affondare, ecco come stanno le cose.
E devo ancora prenderla, la mia decisione. Scegliere tra me e Michelino, intendo.
È così che ha voluto quel coso, quell’essere, non saprei proprio come altro definirlo. Quel demonio sbucato da terra il maledetto giorno del battesimo. L’hanno sentito tutti, uno dei due dev’essere sacrificato e la decisione è soltanto mia.
E in tutto questo vuoi sapere qual è stato il momento peggiore? Quando ho capito come si sarebbero messe le cose, e cioè subito. Dopo che quella creatura ha parlato, dopo la puzza e tutto il resto, quando mi sono sentito tirare per una mano. Erano i genitori di Robertino, mi fissavano in silenzio. Gli occhi spaventati, gli stessi con cui guarderesti uno stupratore o un serial killer. Mi avevano strappato il figlio dalle mani, lo capisci? Come se per il solo fatto di aver giocato con me anche Robertino fosse segnato. Che poi, dico io. Ma con tutti quelli che c’erano alla festa, proprio con me doveva prendersela quell’affare?
Nadia insiste che non devo mollare. Secondo lei, non devo farmi mettere i piedi in testa da questa cosa che il mondo pretende da me, che non mi salti in mente di lasciarmi convincere. Non cascarci, mi dice, tappati gli occhi e le orecchie se proprio non ce la fai. Per lei non è mai stata una questione di età. La morte non guarda in faccia nessuno, mi ha detto. Come pretende la gente di quotare un’anima, in base all’età? Il mondo non va così, guarda in Africa, ne muoiono ogni giorno. Perché nessuno si interessa a quei bambini lì?
In tutta onestà, Sergio, questa cosa dà da pensare anche a me. E poi, se io schiatto, ha minacciato, il giorno dopo si butta anche lei. Sa bene che questo non potrei mai accettarlo, perciò ci fa leva. Ma è comunque una cosa che va considerata, Nadia di bugie non ne dice mai.
Adesso ti dirò come la penso davvero. Sei una persona intelligente quindi cerca di usare qualcuno dei tuoi filtri quando leggerai questa lettera. Io non lo so, amico mio, e questo è quanto. Però c’è una cosa che continua a ronzarmi in testa. Una domanda che fugge e ritorna come un elastico. Può davvero soffrire un bambino di sette mesi? Lo sa, un bambino così piccolo, cos’è la sofferenza? Capisce il concetto di perdita? Secondo me, no. Michelino non può saperne nulla. Non può piangere per qualcosa che non ha mai avuto, non può nemmeno immaginare ciò che si perderebbe.
Prendi il sesso, per esempio. A me mancherebbe un sacco. Ma a Michelino no, non sa neanche cos’è. Non s’è mai fatto un bagno nel mare, magari di notte, e magari con una bella donna. Non ha mai assaggiato un filetto di manzo, non ha mai sofferto per qualcuno. Non si è mai innamorato, Sergio, lo capisci? Non si è mai innamorato, e non è mica poco. E allora sì che in quel caso gli caverei un bel problema. Un bel dente, come si dice. C’era anche un filosofo che la pensava così, credo. Via tutto, via subito, diceva, più o meno il senso era quello.
E poi quell’affare ha detto che sarà una cosa istantanea, praticamente indolore. Puff, via, sparito. L’ha sentita il mondo intero, questa cosa, tutti hanno visto quel video quindi è meglio che la smettano di andare in giro a raccontare cazzate.
Mi fa davvero imbestialire, mi vedo tutto il mondo che corre dietro a Giusy, dietro alla sua biga infuocata e ai suoi cavalli di cenere, lasciandosi alle spalle una scia di odio e menzogne. E poi vedo questa tremenda bilancia dove ci sono io e dall’altra parte c’è Michelino con i suoi sette piccoli mesi. Solo che la decisione è tutta mia, sono la vittima e anche il carnefice, ma se ci fosse stato un sorteggio sarebbe andata meglio. Con un sorteggio, almeno, avrei potuto sedermi e non pensare più a niente, stare lì e aspettare. Tutti mi avrebbero lasciato in pace.
Insomma, Sergio, so solo che Nadia tutti i santi giorni continua a dirmi, Dài, non mollare, ma io credo che abbia semplicemente paura di rimanere sola. Nessuno dovrebbe rimanere solo a questo mondo. Comunque non so se alla fine farebbe ciò che ha detto. Le cose uno le dice, ma poi da lì a farle ce ne passa.
Mia sorella è un altro paio di maniche.
Di lei non saprei proprio cosa dire. Ha già i suoi casini e mi ha detto chiaro e tondo che non ci tiene affatto a entrare in questa cosa, che per lei è solo l’ennesima grana.
La verità è che io e Angelica non siamo mai andati d’accordo. Da piccoli litigavamo sempre, e ora ci comportiamo come perfetti sconosciuti. Due estranei. Ci scambiamo auguri e regali, e tanto basta. Ci vediamo soltanto se ci sono di mezzo gli altri.
È meglio che prendi una decisione e la fai finita, mi ha fatto sapere.
Sai bene che Angelica è un personaggio pubblico, e che questa faccenda è meglio se rimane fuori dalla sua vita. Per telefono mi ha detto, Lo sai già qual è la cosa giusta da fare. Lo sai bene. Poi però ha aggiunto, Se decidessi di farlo, ecco… C’è stata una pausa, poi ha ripreso a parlare, Mi piacerebbe poter dire che ti ho aiutato, far sapere a tutti che ho contribuito. Aspetta un attimo, mi ha detto e dopo qualche secondo ho sentito un click. Parla più forte, adesso, mi fa. Ho messo giù il telefono. Lei non ha richiamato.
Ti sto scrivendo da un altro bar, Sergio, quello dove prendevamo il caffè prima di andare a lezione, ricordi? Vicino al negozio di Alan. Vorrei poter parlare, invece di scrivere, ma so che non è facile. So anche che hai avuto qualche difficoltà e lo capisco, figurati, non te ne faccio mica una colpa se non ti sei ancora fatto vivo. Spero solo che ciò che c’è stato tra noi sia acqua passata, come lo è per me. Cerca di capire, avevo bisogno di confidarmi con qualcuno che fosse lontano anni luce da questa brutta faccenda. Qualcuno che non sentivo da tempo. Un vecchio amico, insomma.
A proposito, come sta tua madre?
Questa non so come mi sia uscita. Che cosa inutile. Queste domande di circostanza, intendo. Sono inutili, che senso hanno?
Ci sono due tizi che hanno preso a fissarmi, credo che tra poco mi alzerò. Anzi, mi alzo subito, mi cerco un altro posto.
Mi sono infilato in biblioteca, quella nuova vicino alle aule. Ho guardato il telefonino mentre venivo qui, era pieno di chiamate e messaggi, sai che novità. Qualcuno ha dato il mio cellulare a un sacco di gente. E la mail. Ho la posta intasata di minacce. Là fuori è pieno di persone che vorrebbero vedermi morto. Mi scrivono che è inutile che sto tanto a pensarci, che comunque andrà a finire la risolveranno loro, la cosa. Come in carcere, no? La giustizia sommaria dei carcerati.
Che poi non è vero che sono un vigliacco. Sai cosa farei, se fossi un vigliacco? Uscirei di qui, anche adesso, in questo preciso istante. Direi a tutti che ho preso una decisione, direi quello che vogliono sentirsi dire da un pezzo e chi s’è visto s’è visto. Che vengano pure a cercarmi in Cina. O sulla Luna, sai che spasso. Non lo saprebbe nessuno. E invece se ne rimane a casa buono e tranquillo, il vigliacco, guarda un po’.
Ma poi, è possibile sparire al giorno d’oggi? Non so, credo sia molto difficile. Queste teste parlanti… Per loro il male dev’essere a tutti i costi esorcizzato. La gente si fissa uno scopo, un obiettivo, e finché non l’ha raggiunto non è contenta. Sicuro, tra un mese succede qualcosa di catastrofico, tipo una guerra, e allora vedi come si scordano di me alla svelta. Finirà così, vedrai, non verrebbe a cercarmi nessuno. Ma ora è tutto così nuovo, così vicino. È come se non dovesse finire mai, avere per sempre tutto il mondo addosso, capisci? C’è un limite, un luogo in cui la paura non può arrivare? Forse no, forse questo posto non esiste. A nessuno interessa quanti orfani ha fatto Rambo, basta che ci abbia liberati dai cattivi. E finché ci sei dentro la pensi come loro, era così anche per me, ma ora è diverso. Comodo, starai dicendo. E magari hai ragione anche stavolta.
Nadia comunque se la caverà benissimo anche da sola. Sopravviverà anche senza di me, non credo farà ciò che ha detto.
Ah, Sergio, ho visto anche il tuo messaggio in mezzo a tutto il marasma. È stata proprio una bella sorpresa, mi ha fatto davvero piacere! Sono contento, in ogni caso questa lettera la finisco. Ormai l’ho scritta e te la voglio lasciare anche se tra poco forse ci rivedremo. Mi hai fatto proprio un bel regalo, sai? Un po’ di luce in mezzo a tutto questo nero. Dopo ti mando la posizione. Tanto tra poco dovrò spostarmi, qui anche i cani ormai mi conoscono. Sono più famoso di Britney Spears e di Madonna. Be’, forse un pochino ho esagerato. Ma gli youtuber, ci scommetto, quelli li ho battuti tutti.
Però l’idea di sparire… Mica male, eh? Andarsene, fine.
Scusa se arrivo al dunque, Sergio, ma il fatto che tra poco ci incontreremo ha cambiato tutto, sono un po’ su di giri. Ho deciso che ti spedirò la lettera. Voglio farlo oggi stesso, prima che qualcosa possa impedirmelo. Non te la do di persona, ti faccio una sorpresa. Così ricambio.
Ti ho appena mandato la posizione. Sono qui, ora, vicino alla statua di gesso, quella a forma di coppa. Sto ridendo perché penso a quando leggerai queste righe. Considerale il mio testamento morale, ti ho scritto queste cose perché nonostante tutto so che di te ci si può fidare. Anche di Nadia, certo, ma lei è troppo coinvolta. Di certi argomenti non vuole nemmeno parlarne. Ma a qualcuno dovevo pur dirlo, no? Cosa ho deciso di fare, intendo.
Be’, in realtà che cosa farò non lo so ancora. E se fuggissi per davvero? Magari in uno di quei posti che c’erano sulle locandine. Magari in Messico. Non ci sono mai stato in Messico. Conosco un sacco di gente che c’è andata, però. Ho persino due amici che laggiù si sono sposati. E poi non fuggono tutti quanti lì, i cattivi dei film? Quelli che vogliono sparire dalla circolazione. E se lo fanno nei film allora forse posso farlo anch’io.
Io il Messico me lo immagino un posto pieno di sole, mare e palme. Con la gente che si gode la vita e non rompe le palle a nessuno. Anche perché in Messico non ti conviene mica. Devi farti gli affari tuoi, c’è solo una regola che ti devi ricordare. Non. Rompere. Ti parcheggi in spiaggia e ti rilassi, punto. La chiamano la siesta, no?
Ah, il Messico… E poi laggiù la vita costa molto meno. Altrimenti perché ci va la gente? Be’, certo, soprattutto per il mare.
Però ho sentito anche certe brutte cose, sul Messico. Anche là c’è un sacco di inquinamento. Una volta ho letto che Città del Messico è una delle metropoli più inquinate del pianeta. E poi il Messico è pieno di gente violenta. Lo si vede anche nei film e nelle serie tv, dev’essere difficile vivere in un posto così pericoloso. Pensa che mi hanno detto di un paesino, sempre in Messico, che ha il più alto numero di omicidi al mondo. Il nome non me lo ricordo, Ciudad qualcosa.
No, secondo me non se la passano tanto bene, in Messico. È per questo, no, che i messicani cercano sempre di espatriare? Scappano dai loro amici e parenti che ce l’hanno fatta, o almeno ci provano. Ti ricordi quanti messicani nelle cucine di New York?
Sergio, ci stai mettendo un po’ troppo a raggiungermi, ma che giro hai fatto?
Che poi, comunque, il problema del Messico è tutto lì, non capisco come mai non ci siano ancora arrivati. Voglio dire, se i cattivi se ne vanno tutti in Messico, e i messicani, quelli buoni, scappano da un’altra parte, allora il Messico non può che restare un’area di guerra. Un ricircolo di cani rabbiosi. E se poi ci aggiungi l’inquiname—
Mattia Frigeri è nato a Parma nel 1981 . Laureato in architettura, lavora come grafico digitale e docente in vari istituti privati. Ha partecipato al percorso Fondamenta della Scuola Holden e all‘Area Letteratura presso Bottega Finzioni, la scuola di Carlo Lucarelli. Le sue storie sono raccolte sulla piattaforma Wattpad, nel tempo libero si diverte a leggerle ad alta voce sul suo canale YouTube.