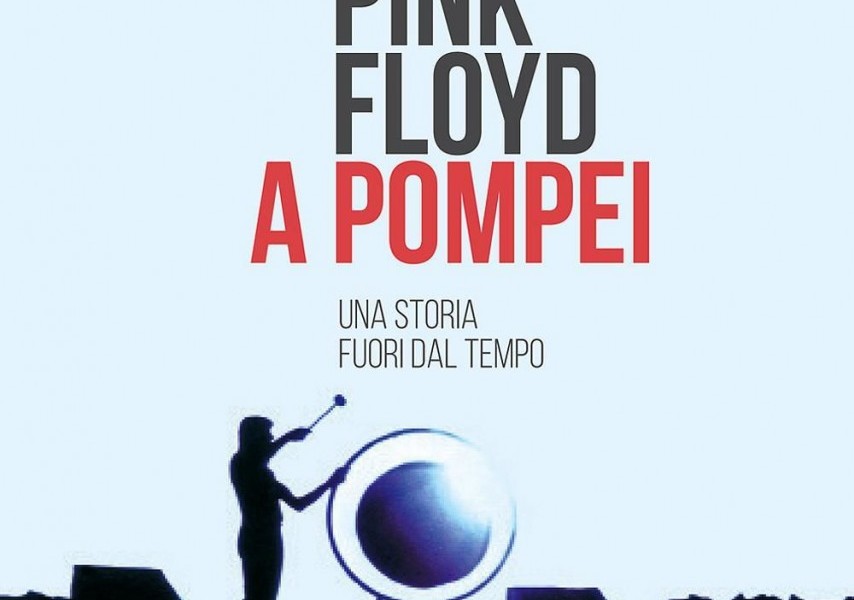Con A casa tutto bene, Brunori ce l’ha fatta. Non che con i precedenti album non si potesse intravedere un cantautore di livello, ma è chiaro come Vol.1, Vol.2 – Poveri Cristi e Vol.3 – Il cammino di Santiago in taxi, ci trovassimo di fronte ai lavori di un artista ancora alla ricerca di un proprio linguaggio. Spesso, infatti, si percepiva uno squilibrio tra testi, interpretazione dei testi e apparato strumentale. Con A casa tutto bene, Brunori è riuscito a fare quel salto di qualità necessario, e quel cantautore di livello che prima si intravedeva, ora si vede.
Brunori ha trovato una chiave interpretativa di se stesso, un modo per riuscire a bilanciare al meglio ogni singola componente delle canzoni, riuscendo a farle brillare come mai prima. Non ci sono dubbi che Brunori sapesse scrivere canzoni che funzionavano – dagli esordi con “Italian Dandy” a “Rosa” ha tirato fuori motivetti che fanno parte di quell’epica ambigua dell’indie italiano -, ma rimaneva sempre un dubbio di fondo su quale potesse essere la sua vera natura. Il lavoro fatto con A casa tutto bene lima i punti acerbi attraverso un diverso modo di congiungere un nuovo approccio strumentale, meno statico e più corale rispetto ai precedenti, a testi e interpretazioni dei testi più raffinati.
La scrittura è indubbiamente più alta, sia per qualità sia per tematiche. Sono cambiati gli orizzonti. Non c’è più solo l’Io che sguazza e si crogiola nel proprio disagio, e che di fatto rimane chiuso a casa. C’è l’Io, ma c’è anche l’altro. C’è il mondo. C’è il pressappochismo della politica e di conseguenza della percezione distorta dei posti in cui si vive, fatta di paure infondate e slogan da bar. Ma c’è anche il timore che quelle paure possano insediarsi anche nella testa di chi quei discorsi non li fa, o quantomeno pensa che non gli appartengano.
«Ed hai notato che l’uomo nero / Semina anche nel mio cervello / Quando piuttosto che aprire la porta / La chiudo a chiave col chiavistello / Quando ho temuto per la mia vita / Seduto su un autobus di Milano / Solo perché un ragazzino arabo / Si è messo a pregare dicendo il corano»: quel meccanismo di auto denuncia che Gaber manifestava dicendo di avere paura non del Berlusconi in sé, ma del Berlusconi in me. C’è Brunori che corregge Battiato che cita Sorrenti, per cui sì, siamo figli delle stelle, siamo sicuramente ancora pronipoti di sua maestà il denaro; ma lo siamo anche della Tv, alla quale Brunori dà tutte le colpe dell’ appiattimento della coscienza sociale rendendola ricettacolo di egoismi: «Ma tu mi parli ancora di pensione e di barconi / Pieni di africani come se fossero problemi tuoi / Come se non c’avessi già i problemi miei» (“Sabato Bestiale”). C’è anche la presa di posizione netta di Brunori nei confronti di Brunori artista, di ciò che sono le sue canzoni, del senso che avevano, ovvero nient’altro che «canzoni troppo poco intelligenti», «canzoni buone per andarci la domenica al mare», «che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti» (“Canzone contro la paura”). Un modo per espiare ciò che è stato e per entrare in una nuova Era.
In A casa tutto bene ci sono momenti ispirati a un modo di fare musica non tipicamente italiana (certi stacchi de “La verità” possono ricordare alcune sospensioni alla Sigur Ros), ma la base rimane fortemente italiana: De Gregori e Gaetano ispirano costantemente la scelta interpretativa delle parole, Fossati è presente in maniera lampante nell’arrangiamento de “L’uomo Nero”. Ma ci sono anche riferimenti a cantautori più giovani, da Gazzè ( “La vita liquida”) a Cremonini ( “Colpo di pistola”). A casa tutto bene, in definitiva, ha il respiro di una tipica cosa italiana fatta bene.
Brunori qui esce di casa, guarda il mondo, si spaventa per poter essere contaminato, e solo dopo torna a casa. Torna a casa, perché comunque l’esistenza necessita di un luogo dove potersi riconoscere. Ma Brunori ora sa che non esiste solo quel posto sicuro e in questo passaggio c’è tutta la differenza su ciò che era Brunori prima di quest’album, e quello che ora. Un artista nel senso più ampio del termine, consapevole di non doversi accontentare solo di essere un Italian Dandy.