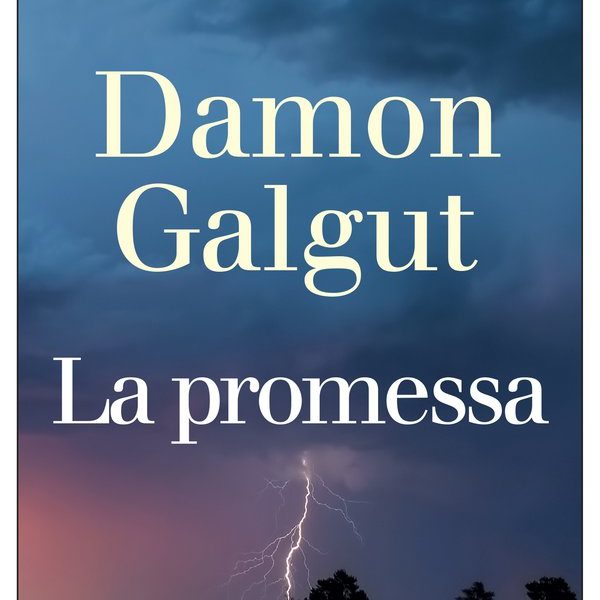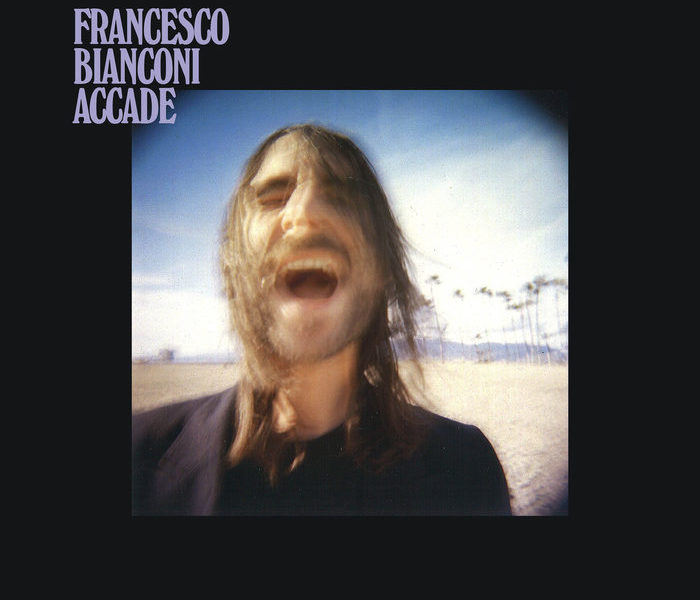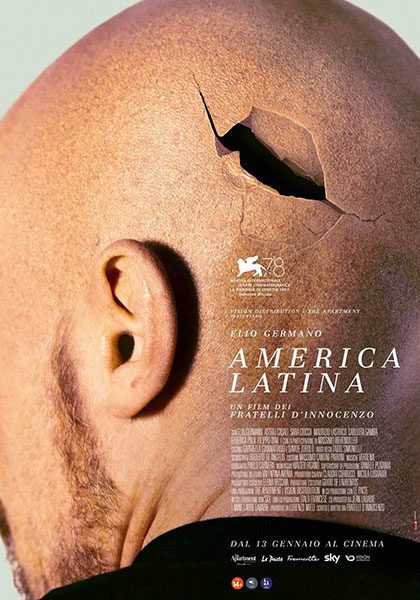L’universo appare come un caos informe, di cui si disconoscono cause e fini. È dunque quasi un istinto quello di ordinare l’informità dell’esistenza, ovvero cercare di trovare un ordine o, addirittura, la formula finale in cui tutto è contenuto e risolto. Ciò che accomuna scienza, religione e pseudoscienze, infatti, è il tentativo di trovare uno schema nel caos della realtà, scorgere il prevedibile nell’ignoto, trarre un filo dallo gnommero dell’esistenza con cui intessere una trama di senso. Gli strumenti utilizzati dall’umanità nel corso dei secoli sono svariati: dall’astrologia che cerca risposte tra gli astri e i movimenti planetari, alla fisica costantemente alla ricerca della teoria del tutto o, ancora, la geometria che tenta di contenere entro le linee severe delle sue figure la materia concreta della natura, così come l’essenza immateriale della vita.
Gli scrittori Max Frisch, Leonardo Sinisgalli e Carlo Emilio Gadda, accanto all’attività letteraria, hanno dedicato parte della loro vita a un’altra professione: architetto il primo, ingegneri gli altri due. Ciò che si scorge nell’opera di tutti e tre gli scrittori – elemento che li accomuna – è il tentativo, tramite l’atto creativo della scrittura, di ordinare la realtà, applicando gli strumenti della loro professione scientifica, per tentare di decodificare e risolvere il garbuglio dell’esistenza.
Il tentativo (impossibile) di dominare la vita con la tecnica
Il protagonista del romanzo Homo Faber (Feltrinelli, 1959) di Max Frisch è Walter Faber (il cognome non è casuale), un ingegnere meccanico, dalla visione razionale del mondo («Non credo al destino o alla Provvidenza. Sono un tecnico e perciò abituato a calcolare le probabilità. […] Per accettare l’improbabile come fatto d’esperienza non ho bisogno della mistica; mi basta la matematica») il cui eccesso di logica – paradossalmente – fa maturare in lui una fede irrazionale per la tecnica. Egli è fermamente convinto che la tecnica possa discernere la realtà e dominare la natura. Il narratore Faber afferma che «la macchina non ha emozioni, non ha paure o speranze, che non fanno altro che disturbare, nessun desiderio riguardo al risultato, lavora secondo la logica pura della probabilità, perciò affermo: il robot riconosce la realtà meglio dell’uomo».
Riducendolo a un mero sistema probabilistico e di causa-effetto, Faber non riesce a comprendere il mondo, che pure egli crede, erroneamente, di poter conoscere. Come gli si fa notare, «la vita non è materia, non può essere dominata con la tecnica» e se ne renderà conto quando rimarrà lui stesso vittima del caso e di quello stesso destino che, sin dal proprio nome – homo faber fortunae suae –, rifiutando la sua esistenza, credeva di poter governare.
Faber potrà pure essere artigiano della tecnica, ma non della vita. In quest’ultima, in particolare, entra in gioco un elemento che Faber nella sua visione non ha considerato perché non appartenente all’universo tecnico, ovvero la morte: «Il mio errore: che noi tecnici cerchiamo di vivere senza la morte». L’errore di calcolo nella visione di Faber è stato, appunto, non tenere in conto la morte e, di conseguenza, l’ignoto, l’irrazionale e la transitorietà della vita, confermando così, ancora una volta, di quest’ultima l’essenza sfuggente ed eversiva, che non si lascia schematizzare tanto meno ordinare.
Il «residuo incalcolabile» dalla logica umana
Nell’opera letteraria di Leonardo Sinisgalli si nota chiaramente l’influenza dei suoi studi di ingegneria: il tentativo di comprendere la realtà con gli strumenti propri delle scienze matematiche dà vita a connessioni di pensiero inedite e ricche visioni.
In un brano presente in Pneumatica (Edizioni 10/17, 2003) l’autore racconta di come prova riverenza e meraviglia di fronte al processo produttivo della fabbrica, che viene metaforicamente paragonato all’atto creativo della natura: «Si parte dalla confusione e si arriva all’ordine. Si parte dal bruco e si arriva alla farfalla».
Eppure, Sinisgalli, in Furor Mathematicus (Urbinati, 1944; Mondadori, 2019), – e diversamente dal narratore dell’opera di Frisch – sembra lasciare spazio alla consapevolezza che pure esistono l’irrazionale e l’ignoto: la sua non è una fiducia assoluta nella tecnica quale mezzo per comprendere la realtà. Traspare l’idea che esista un mondo invisibile, imperscrutabile, che sfugge alle nostre categorizzazioni e non si lascia indagare dagli strumenti della logica: «Ma è ormai pericoloso fissare dei metodi o imporre delle categorie. L’analisi filologica, o storica, o stilistica non basta, come non basta a spiegarci il mistero di un bel verso. C’è un residuo delle nostre misure incalcolabile». Di questo regno imperscrutabile fanno parte, oltre all’essenza della vita stessa, i sogni, onnipresenti nell’opera di Sinisgalli: «Noi fatichiamo a stringerlo nelle categorie che la logica ci ha suggerito per incatenare la materia: ma il sogno scappa via da ogni parte, ci sfugge, trabocca, ci confonde». Il sogno, analogamente a un fluido, è una sostanza invertebrata, priva dei sostegni del senso, e inafferrabile, sia concretamente con le mani sia astrattamente con il pensiero logico umano. Contenere la vita, con la sua inafferrabilità e la sua insondabilità, entro i confini della logica non sembra appannaggio dell’essere umano.
Infine, ricordando un gioco che si faceva da ragazzi con un cerchio di spago con il quale si creavano delle figure chiuse, Sinisgalli metaforicamente vede in esso il modo in cui noi analogamente tendiamo un filo con il quale cerchiamo di collegare gli eventi della vita, per dare loro una trama di senso, e afferma che questo gioco dei fili rivela «un’ansia incontenibile nel cuore dell’uomo: conoscere se veramente una Mano oppure il Caso tiene i capi di questo esile filo della nostra esistenza».

Il «pasticciaccio» del mondo
Proprio districare lo gnommero del reale per trovare il filo che collega totalmente il complesso sistema di cause ed effetti è quello che si prefigge di fare Carlo Emilio Gadda e, per farlo, si serve della scrittura. La scrittura per Gadda diviene lo strumento per indagare e risolvere la realtà.
Ed ecco che quella del dottor Ingravallo in Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana (Garzanti, 1957; Adelphi, 2018) non è semplicemente l’indagine poliziesca di un crimine, ma anche un tentativo conoscitivo della realtà. «Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo».
Sul piano letterario questa indagine avviene tramite un’accurata riproduzione mimetica del mondo: la scrittura di Gadda si serve e si arricchisce di neologismi, mescolanze dialettali, onomatopee. Scrivendo, l’autore/narratore cerca di ordinare il caos informe della realtà, collegando le varie vicende in rapporto di cause e concause fino a risalire alla «causale principe». È un’indagine che però fallisce e non viene portata a termine, sia sul piano filosofico che artistico. L’incompiutezza dell’opera in Gadda non è intenzionale, ma assomiglia piuttosto a una resa di fronte al complesso pasticcio del mondo e dunque all’incapacità, o forse addirittura all’impossibilità, di trovare un ordine nel mondo. L’opera – complessa, divagante, frammentaria – diventa così specchio di quel medesimo complesso garbuglio del reale, che almeno negli intenti, in principio voleva ordinare: si potrebbe osare ad affermare che forse l’opera gaddiana è riuscita almeno nella realizzazione mimetica di questa informità del reale.
Ma perché si cerca ostinatamente e ossessivamente un ordine nel caos? Non è certamente una ricerca fine a sé stessa. Ricercando un ordine, si cerca anche un senso e questi devono rispondere a quell’innata tensione verso la perfezione e la verità. «Il mondo delle cosiddette verità, filosofò, non è che un contesto di favole: di brutti sogni. Talché soltanto la fumea dei sogni e delle favole può aver nome verità. Ed è, su delle povere foglie, la carezza di luce». Verità può essere forse pretesa della favola, di certa letteratura e arte. Per Gadda, invece, il quale concepisce la letteratura quale «indefettibile strumento per la scoperta e la enunciazione della verità», se, tramite la scrittura, non riesce a ordinare l’informità dell’esistenza, districare il groviglio della realtà e ivi a trovare la verità, abbandona ogni aspirazione all’ordine e il «pasticciaccio» del mondo è destinato a rimanere tale. E tale è tuttora.