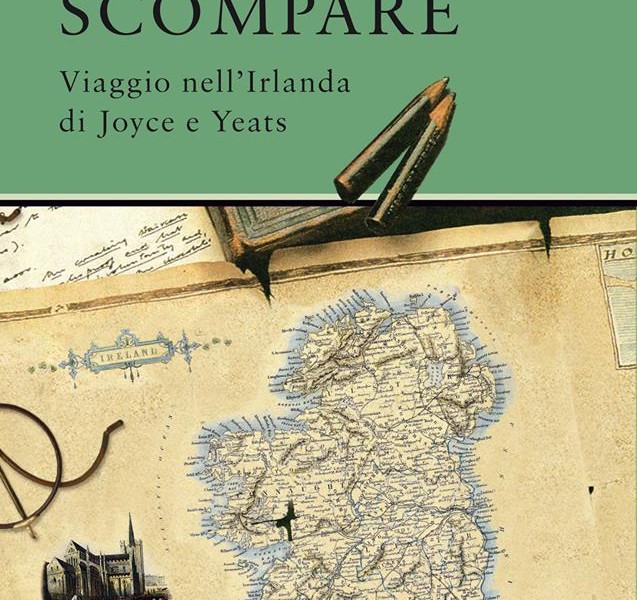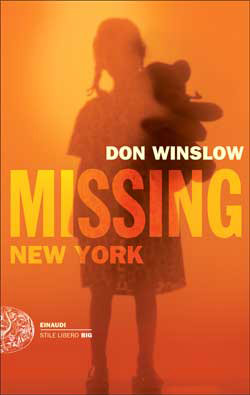Una serie di singolari personaggi, persi nell’enormità di una natura selvaggia e sempre diversa, viaggiano alla ricerca di una terra, intrecciando i loro destini con quelli di un uomo in fuga, di una guaritrice indiana, di un moribondo e di tanti altri, sullo sfondo della sconfinata prateria del selvaggio West. Il romanzo di Céline Minard, Per poco non ci lasco le penne (66thand2nd, 2014), ricrea in maniera magistrale l’atmosfera di un vero western, tessendo una trama ricca di colpi di scena e personaggi memorabili, e destreggiandosi fra tensione e senso dello humor con semplicità ed eleganza, riuscendo ad allontanarsi dai cliché in cui sarebbe stato, forse, molto facile cadere.
Durante Più libri più liberi Céline Minard ha presentato il suo romanzo, pubblicato in Italia da qualche mese, e noi abbiamo approfittato per farle alcune domande.
2014, una scrittrice di Rouen decide di scrivere un romanzo western: qual è il motivo alla base di questa scelta?
Il western è un genere conosciuto da molti, un genere che quasi tutti hanno ben presente, e come tutti i generi ampiamente condivisi permette una riappropriazione da parte dei lettori e degli spettatori. L’idea è appunto quella di ritrovare un grande spazio, un’area estesa nella quale poter far riemergere ciò che caratterizza questo genere e allo stesso tempo farne crollare i cliché.
La tua scrittura è più orientata verso il mito geografico, la documentazione storica oppure ancora verso l’immaginario romanzesco e la pura ispirazione?
Credo che nessun western consista in una mera ricostruzione storica: quando guardiamo un western siamo ben poco coinvolti all’interno dell’aspetto storico. Quello che conta è proprio il “mito” del western. La cosa importante non è solo il modo in cui viene raccontato quel periodo: si parla infatti quasi di una cosmogonia, ed è proprio questo concetto di epopea mitica che ho voluto “rimescolare”, in un certo senso, nella scrittura del mio romanzo.
Quali sono dunque le fonti di ispirazione alla base del romanzo?
Naturalmente i grandi classici del cinema western, i vecchi film, ma anche i western thailandesi e naturalmente gli spaghetti western. Dal punto di vista letterario mi sono orientata verso alcune opere definibili come storiche ma che nel concreto non lo sono mai completamente, ma anche verso i romanzi di grandi autori come Clarke, McCarthy, May, o ancora il grande western Lonesome Dove di McMurtry. Ma ci sono anche alcune opere incentrate sulla natura, cito per esempio Thoreau, oppure ancora i gialli di Hillerman, che dipingono l’evocativo scenario delle riserve indiane.
I personaggi del tuo romanzo sono tutti a dir poco singolari, ma ci sono alcuni personaggi femminili che spiccano per la loro forza, come Acqua-che-scorre-nella-pianura o Sally. Puoi dirci qualcosa in più sulla tua scelta di inserire dei personaggi di questo tipo in un genere spesso caratterizzato da una presenza maschile dominante?
Certamente: questo è uno dei cliché che ho voluto far cadere all’interno del mio romanzo. Il western è sicuramente un genere prettamente maschile, ma questo è vero solo in parte: ci sono state diverse donne che hanno scritto alcune delle più belle storie del genere. Possiamo dunque dire che il western è stato in qualche modo “ripreso” dagli uomini: io ho semplicemente voluto tornare alle origini, e questo è stato per me un modo per muovere il personaggio femminile dalla sua posizione standard all’interno del western. Ed è così che in Per poco non ci lascio le penne troviamo delle donne che sono delle streghe, delle donne d’azione, donne che prendono in mano le situazioni ancora prima degli uomini.
Nonostante la differenza dei loro generi i tuoi libri sono sempre pieni di aventura (per esempio Bastard Battle e Le dernier monde). C’è un filo conduttore che lega le tue scelte letterarie?
Penso che a legare fra loro i miei romanzi sia principalmente l’idea dell’esplorazione, ma più che un’esplorazione in senso “fisico” si tratta di un’esplorazione che passa attraverso la scrittura. Ogni volta, infatti, l’elemento dello spazio assume una grande importanza: non parlo solo dello spazio geografico ma anche di quello “mentale”.
In secondo luogo, saranno l’epoca storica e l’intreccio a subentrare nella scelta linguistica e stilistica, ed è questo che fa sì che i miei libri siano così vari e diversi fra loro. Quello che mi interessa di più non è la semplice voce narrante, ma il percorso, il cammino che porta alla composizione delle mie storie.
(Céline Minard, Per poco non ci lascio le penne, trad. di Elena Sacchini, 66thand2nd, 2014, pp. 245, 18 euro)