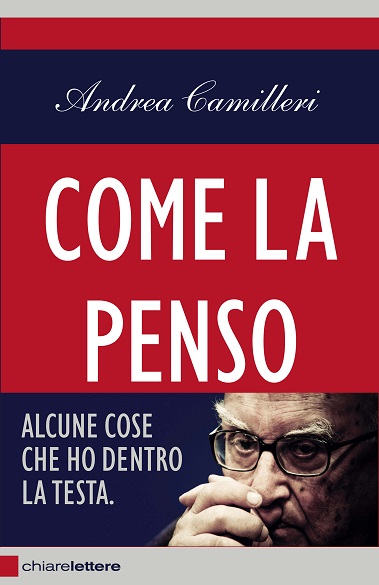Parigi, 2 giugno 1943, Thèâtre de la Cité. È la sera della prima di Le mosche. Nel foyer, durante l’intervallo, Simone de Beauvoir e l’autore Jean-Paul Sartre sono in un angolo a fumare e chiacchierare in attesa del secondo atto. Un giovane straniero di bell’aspetto e dalla pelle scura si avvicina. Porge la mano a Sartre. «Sono Albert Camus», si presenta. Sartre gli stringe la mano. Sa già chi è. È la prima volta che si incontrano di persona ma si conoscono da tempo. Dal 1938, per la precisione dal 20 ottobre, da quando, cioè, un Camus venticinquenne recensisce, per Alger républicain, La nausea.
È una specie di conforto quello che prova Camus leggendo Sartre, la rassicurante sensazione di aver trovato qualcuno con cui condividere il senso dell’assurdo, un modello o piuttosto una conferma per il suo pensiero. «Un romanzo non è mai altro che una filosofia messa in immagini», scrive Camus all’inizio dell’articolo, intuendo e inquadrando subito il senso della scrittura sartriana. Perché letteratura, teatro, critica e filosofia concorrono tutti nell’opera di Sartre a sviluppare un sistema di pensiero, una ricerca ontologica sull’uomo e sul suo senso nel mondo. La nausea non fa eccezione. Più che un romanzo, Camus lo legge come un monologo, un unico flusso in cui Sartre espone la propria teoria sulla contemplazione dell’assurdo della vita umana. L’assurdo non come termine della ricerca, ma come suo inizio. Non è la scoperta a essere rilevante, ma le conseguenze del suo manifestarsi. Secondo Camus, Sartre trova nella Nausea una possibilità di reazione nella scrittura, in un cartesianesimo rivisitato all’insegna dello «Scrivo, dunque sono».
Camus non era un filosofo, nonostante la laurea all’università d’Algeri. Era uno scrittore, un giornalista, un teorico dell’essere umano, ma era sprovvisto di quel rigore accademico proprio di chi fa dello studio e della ricerca il proprio mestiere. Non poté, comunque, fare a meno per tutta la vita di interrogarsi sul senso della vita stessa, sul perché andare avanti dopo aver scoperto l’assurdo del mondo. Non poté fare a meno, in questo, di guardare a Sartre.
«Esiste soltanto un problema filosofico veramente serio, quello del suicidio. Giudicare se la vita vale o meno la pena di essere vissuta significa rispondere alla fondamentale questione della filosofia», inizia così Il mito di Sisifo, il saggio del 1942 in cui Camus formula compiutamente la sua teoria dell’assurdo. È dalla constatazione dell’assenza di razionalità nel mondo, dal silenzio che esso offre come risposta alla domanda continua dell’essere umano, che deriva il sentimento dell’assurdo. L’uomo lucido, che vede con chiarezza tutto ciò che lo circonda, può rendersene conto anche osservando attraverso il vetro di una cabina un altro uomo che parla al telefono, osservando i suoi gesti senza sentirne le parole. «Ti domandi perché sia vivo», scrive Camus. E anche questo sconforto di fronte all’uomo, questa «nausea», come scrive ancora chiamando direttamente in causa Sartre, è l’assurdo.

La scoperta del vuoto di senso dell’umanità rende insopportabile la vita e apre le porte al suicidio. «Perdere la vita è cosa da poco; e quando sarà necessario non me ne mancherà il coraggio; ma che vada sperperato il senso di questa vita stessa e sparisca la nostra ragione di esistere, non si deve tollerare. Non si può vivere senza una ragione di vita», dice Cherea in Caligula che, con Il mito di Sisifo e Lo straniero, completa la trilogia dell’assurdo di Camus (scriveva a cicli: un romanzo, un dramma un saggio, sullo stesso tema. Seguirà la trilogia della rivolta: La peste, L’uomo in rivolta, I giusti). «Pensavo vagamente di sopprimermi, per annientare almeno una di queste esistenze superflue. Ma la mia stessa morte sarebbe stata di troppo. Di troppo il mio cadavere, il mio sangue su quei ciottoli, tra quelle piante, in fondo a quel giardino sorridente. E la carne corrosa sarebbe stata di troppo nella terra che l’avrebbe ricevuta, e le mie ossa, infine, ripulite, scorticate, nette e pulite come denti, sarebbero state anch’esse di troppo: io ero di troppo per l’eternità», scrive invece Sartre nella Nausea, ricollegando la dimensione dell’assurdo anche alla carnalità dell’uomo, alla sua stessa natura biologica, rifiutando il suicidio, quindi, perché anch’esso finirebbe per alimentare l’assurdo del mondo.
Per Camus, al contrario, il suicidio è resa all’assurdo, di cui si deve invece prendere coscienza per impegnarsi a vivere nella maniera più piena possibile. Se ci si arrende all’assurdo, allora tutto diventa possibile ed egualmente valido: «Se Dio non esiste, allora tutto è possibile», scrive Dostoevskij nei Fratelli Karamazov. Il crollo di ogni dimensione di valori ultraterreni, di ogni riferimento morale per la condotta umana lascia l’uomo solo in un mondo abitato esclusivamente da altri uomini, dai loro bisogni, dalle loro paure. Ogni forma di trascendenza viene meno. Il sentimento dell’assurdo in sé può essere usato per giustificare anche l’assassinio. «Se non si crede a nulla […] si è liberi di attizzare i forni crematori o di dedicarsi per tutta la vita alla cura dei lebbrosi», scriverà dieci anni più tardi nell’Uomo in rivolta. L’omicidio, individuale o collettivo, diventa un’opzione lecita come ogni altra, come lo è per Meursault uccidere l’Arabo nello Straniero; un normale gesto dell’uomo. Di fronte all’assurdo deve prevalere la nostalgia dell’unità tra uomo e mondo, rifiutando il suicidio proprio come sconfitta e facendo prevalere la dignità di fronte alla vertigine di vuoto che il senso dell’assurdo comporta.
Nel 1942 sarà Sartre a recensire Lo straniero di Camus in un’analisi basata sulle categorie filosofiche delineate nel Mito di Sisifo, evidenziando la continuità tra le due opere come sviluppo unico di un sistema di pensiero. È un riconoscimento importante, da parte di Sartre, la certificazione di una teoria unica che Camus sviluppa in forme differenti di scrittura.
Sembrano muoversi dagli stessi presupposti, Camus e Sartre, in un mondo privo di valori di riferimento, senza un dio a guidare gli uomini. Eppure pochi anni dopo la fine della guerra si ritroveranno a percorrere strade diverse, finendo sempre più lontano l’uno dall’altro.
Quando Albert Camus si trasferisce definitivamente a Parigi nel 1944 partecipa attivamente alla resistenza con il gruppo clandestino di Combat, scrivendo editoriali politici e prendendo parte ad azioni armate. È «l’ammirevole congiunzione di una persona, di un’azione e di un’opera», come lo definisce Sartre che è invece ancora poco coinvolto nella dimensione politica. Aveva provato, qualche anno prima, a radunare un gruppo di intellettuali nel movimento di resistenza Socialisme et liberté ma il tentativo aveva avuto vita breve. La sua partecipazione alla resistenza si concretizza principalmente nei contenuti simbolici dei suoi lavori teatrali.

È Camus a dargli una nuova occasione per partecipare. Nei giorni in cui gli scontri per la liberazione di Parigi si stanno intensificando, Sartre e De Beauvoir si recano nella redazione/quartier generale di Combat. Ad accoglierli c’è Camus. Sulla scrivania, accanto alla macchina da scrivere, una pistola carica è pronta nel caso in cui i tedeschi dovessero fare irruzione. È entusiasta, nonostante il senso di pericolo costante, e proprio spinto dall’entusiasmo fa una proposta a Sartre: scrivere un reportage per raccontare la città in lotta. Titolo: Un promeneur dans Paris insurgé. E Sartre accetta, entrando nel gruppo.
Camus parlerà poi di Sartre come di «uno scrittore che resisteva e non un resistente che scriveva», per evidenziare come la sua partecipazione sia stata, comunque, marginale. Ma l’esperienza nel gruppo di Combat rappresenta uno dei primi momenti di quella conversione all’impegno che caratterizzerà il Sartre del dopoguerra. Un Sartre che rivede il proprio tessuto filosofico, l’esistenzialismo di L’essere e il nulla, reinterpretandolo nel corso dell’affollatissima conferenza L’esistenzialismo è un umanismo per aprirlo come teoria dell’azione. Il suo pensiero non è un quietismo, come era stato definito da qualcuno, ma una filosofia positiva pronta a trasformarsi in quella teoria dell’engagement che pochi mesi dopo svilupperà nell’articolo di presentazione della rivista Les Temps Modernes che fonderà e dirigerà fino alla morte.
Nella Parigi liberata Sartre e Camus si frequentano nei caffè e nella casa editrice Gallimard. I due più importanti scrittori di Francia, accomunati da tutti sotto l’etichetta dell’esistenzialismo, sembrano più vicini che mai. Ma per Camus c’è qualcosa da capire. Rifiuta il titolo di esistenzialista, non contribuisce a Les Temps Modernes se non con pochi articoli di critica letteraria. Qualcosa nel progetto sartriano non lo convince. Litiga pubblicamente con Maurice Merlau-Ponty, responsabile della redazione politica della rivista, durante una cena a casa di Boris Vian per gli articoli raccolti in Umanesimo e terrore che giustificavano le purghe staliniane, e capisce il motivo della suo allontanarsi da Sartre: il rapporto con il marxismo e la politica comunista.

In gioventù, Camus aveva aderito al partito comunista algerino per poi uscirne. Era di sinistra, ma rifiutava il modello comunista e il blocco sovietico. Sartre, invece, non aderì mai al PCF, ma nel dopoguerra iniziò un confronto tra esistenzialismo e marxismo, vedendo nel comunismo l’unica politica possibile per condurre l’uomo alla salvezza. Il fine è quello dell’assoluta libertà dell’uomo e nei primi anni Cinquanta Sartre arriva ad affermare nei Comunisti e la pace che solo la rivoluzione marxista-leninista guidata dal Partito può garantire all’uomo la piena libertà.
Per Camus è una posizione inaccettabile. Il marxismo, per lui, non è altro che un cristianesimo che ha messo la storia al posto di dio. La libertà non si realizza nella rivoluzione, ma muore con essa. Nell’Uomo in rivolta, Camus rifiuta ogni idea di rivoluzione che tenti di stabilire un ordine basato su valori che non possono essere che illusori, eventuali. Ogni rivoluzione che chieda di sacrificare l’uomo per uno scopo possibile è errata. Il sacrificio di vite in nome di un fine ideale è errato. La storia come ideale astratto è un errore. Il marxismo è un errore. Sulla rivoluzione deve prevalere la rivolta contro valori negativi – oppressione, ingiustizia – per affermarne l’opposto positivo.
È il momento di una rottura insanabile. Francis Jeanson recensisce su Les Temps Modernes, demolendolo, il saggio di Camus, definito «âme révolté». Camus risponde con una lettera pubblica rivolta direttamente a Sartre, chiamato freddamente «directeur», in cui lo critica per le sue posizioni politiche. Si sente attaccato, sa che la recensione di Jeanson è anche un attacco da parte dell’ormai ex amico. Sa che la distanza politica li sta allontanando sempre di più. Sartre risponde con un’altra lettera. Lo chiama per nome, lo indica come responsabile della fine della loro amicizia e procede a una dettagliata critica del suo pensiero e della sua attività politica. È l’ultimo scambio tra i due, la crepa che li allontanerà per sempre.
«Probabilmente Camus è stato l’ultimo caro amico che ho avuto», ricorderà Sartre molti anni dopo. Non si parleranno mai più, dopo quelle lettere. Camus non replicò, non ne aveva bisogno. Vive a Parigi come in trappola, isolato dopo la rottura con Sartre e il suo gruppo. Nel ’57 arriva il Nobel e forse un po’ di serenità. Si trasferisce in Provenza, al sole, più vicino al Mediterraneo che lo fa sentire a casa, in Algeria.
Passano due anni, poi lo schianto, il vuoto, lui e Michel Gallimard costretti tra le lamiere. E una cartellina nera con un’idea, Il primo uomo.



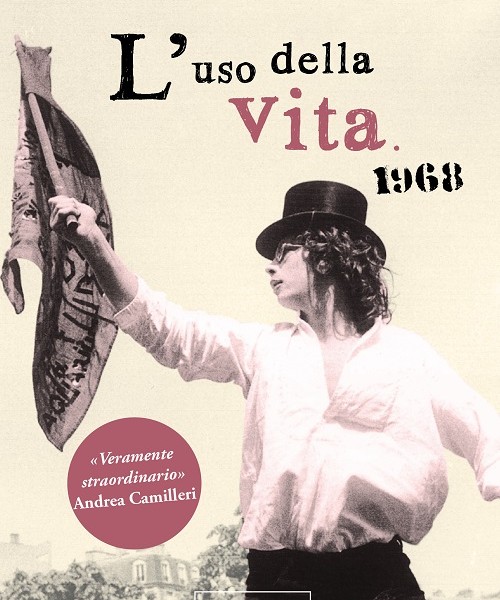

.jpg)