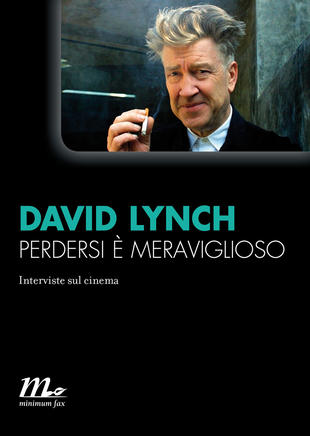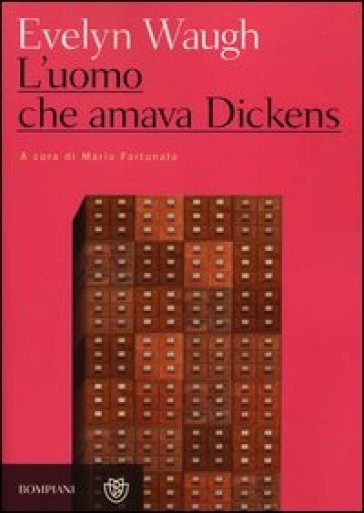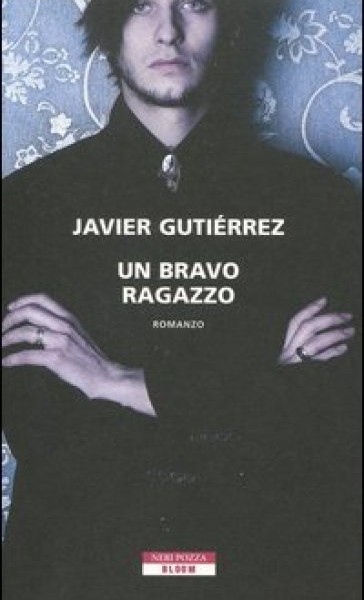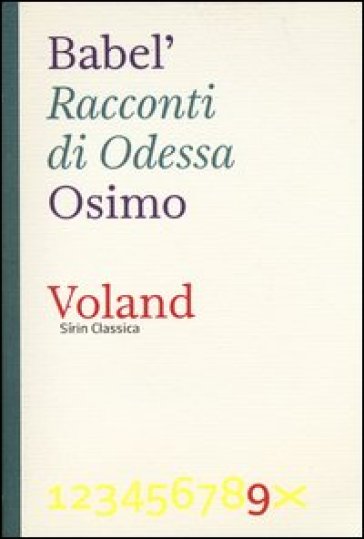Se David Foster Wallace si domandava «cosa David Lynch sembra volere da te, esattamente», le interviste raccolte da Richard Barney in Perdersi è meraviglioso (minimum fax, 2012) mostrano senza dubbio cosa il pubblico sembra volere da Lynch, esattamente: una spiegazione.
Non c’è giornalista (e nel libro si hanno ben ventiquattro esempi) che non tenti di strappare al cineasta più: enigmatico? sfuggente? amato? discusso? ermetico? (difficile definirlo in modo originale), una frase rivelatrice. È interessante notare come l’entusiasmo dei giornalisti si riversi sui significati della trama e molto poco, o comunque molto meno, sugli aspetti tecnici dei film. C’è questa misteriosa (per usare la diffusione dell’aggettivo nel testo) tendenza ad allontanare il dato estetico dal dato tecnico. Ed è singolare che ciò avvenga proprio nei confronti di un regista che ammette di aver votato Reagan soprattutto per un “fattore estetico”. Vorrei domandare a Lynch se per caso l’abbia notato anche lui. Probabilmente la sua risposta sarebbe: «Be’, sì… ma forse in parte no», perché al di là della discussione sul carattere aperto o meno del regista, Perdersi è meraviglioso offre un ritratto dell’intervistato perfetto: ti lascia credere ciò che preferisci. E nel suo silenzio sembra così saggio che avresti voglia di dargli il tuo bancomat.
Le interviste proseguono ripercorrendo la carriera del “cineasta più…” per la gioia di ogni fan (tra cui io), illuminando la tensione artistica di Lynch che è alla base della sua percezione (sorprendentemente intuitiva e istintiva) della realtà.
Non so se sia un limite o un valore aggiunto, ma per seguire il libro in ogni sua parte è necessario conoscere l’opera omnia del regista: i giornalisti accennano di continuo a personaggi e situazioni correndo il rischio di rendere il testo incomprensibile per il fruitore meno esperto. Sembra scontato, ma non lo è. Per esempio quando Truffaut intervistò Hitchcock, ne venne fuori un libro dove questo non accade. Chiusa parentesi.
Il cinema di Lynch è un terreno fertile per la critica perché se i significati sono plurimi, i significanti sono molteplici. Questo probabilmente si lega all’interesse del regista per «la grana della parola letterale».
Durante o dopo la lettura, il libro spinge quindi a domandarsi, quasi in modo naturale, che rapporto intercorra tra il lessico di Lynch e la sintassi del suo testo filmico. Dalle interviste emerge una certa coerenza tra l’evasività e il significato in potenza e ciò implica che nel “finale” del libro tutto resti irrisolto o risolto in tante vie definitive.
I tipi di minimum fax dimostrano che un libro può essere non solo interessante, ma anche piacevole persino quando è privo di frasi a effetto. Un esempio tra i tanti: «L’unico artista che sento come mio fratello […] è Franz Kafka. Lo stimo davvero un sacco». E Lynch va avanti così, per pagine e pagine, tra frasi gergali e riflessioni sulla meditazione. Sta al lettore/spettatore fare la scelta e probabilmente è per questo che a volte risulta antipatico (socialmente, ma soprattutto criticamente, si traduce con “oscuro” o “incomprensibile” o “misterioso”): se pago per vedere un film o leggere un libro, forse mi aspetto che qualcuno abbia già scelto per me.
Infine. Che posizione occupa questo testo (che parla di cinema senza spettacolarizzazioni) rispetto ai mezzi “dell’epoca della riproducibilità” 2.0? Non so se sia possibile che provochi uno scontro o una frattura, ma di certo non avremo il pullulare di citazioni su Facebook. Finalmente.
Nota: l’aggettivo lynchiano è stato volutamente censurato in quanto si adotta in questa sede la definizione data da DFW e purtroppo non c’è nulla di lynchiano nelle mie poche righe, figurarsi se c’è qualcosa di davidfosterwallaceiano…
(David Lynch, Perdersi è meraviglioso, trad. di Francesco Graziosi, minimum fax, 2012, pp. 433, euro 17).