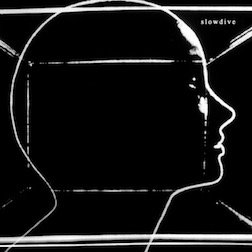1
«Michele, che c’è?»
Il tono della domanda del mio capo non è di quelli da metterti con le spalle al muro, anzi, direi che è persino confidenziale, eppure ho una involontaria contrazione allo stomaco: «Che c’è? Niente. Tutto okay, capo».
«Sbrigati a darmi quelle cavolo di pratiche, così me le tolgo dai piedi».
Le pratiche, già. Sono tre. Non molte, a dire il vero. Ciò vuol dire che gli inefficienti irrecuperabili, in questi ultimi tempi, sono diminuiti in modo considerevole.
Guardo il mio capo come il topo guarda il gatto. Eccolo là: frangetta bionda su volto pacioso, occhi azzurri slavati, percorsi da bagliori inquietanti. E l’immancabile giacca nera, simbolo della sua condizione di efficiente di primissima categoria. È lui che ogni trimestre mi appioppa il temuto voto, il quale, sia pure con valenza tripla, viene assommato a quello assegnato da amici, vicini di casa, negozianti e, novità recentissima, estranei. Anche quest’anno, il giudizio emesso dalla Commissione giudicante è stato di 42/100. Come dire che ci posso sempre mettere una pezza, ma che questa pezza può strapparsi da un momento all’altro, facendomi ritrovare in mutande.
«Mi domandavo…»
Il mio capo sghignazza: «Da quando in qua sei in grado di domandarti qualcosa…»
Faccio orecchie da mercante e cerco di ritardare il momento in cui gli metterò le pratiche in mano, così da permettere all’inefficiente irrecuperabile di cui non conosco il nome e il cui il destino è temporaneamente nelle mie mani, di giocare col suo figliolo ancora una mezz’ora, rinviando l’inevitabile internamento in una delle molte Case per il recupero dell’efficienza, dalla quale difficilmente uscirà col cervello a posto.
«Be’, mi domandavo se questi inefficienti irrecuperabili riusciranno, un domani, ad avere un lavoro, una casa, una famiglia».
«Ma che belle domande ti fai. Gli inefficienti l’hanno avuto un lavoro, una casa, una famiglia. E se non hanno saputo tenerseli, peggio per loro. Abbiamo già affrontato l’argomento mille volte, no?»
Annuisco.
«E cosa ti dico ogni volta?»
Lo so bene cosa mi dice, che gli inefficienti irrecuperabili sono dei malati, come i gay, come coloro che aborrono la famiglia, che non vogliono figli, che non accettano serenamente la morte fra atroci dolori, contravvenendo alle direttive della Chiesa.
«Malati, è chiaro?» Ribadisce con un’occhiata truce. «Su, dammi ’ste pratiche».
Mi alzo e gliele porto.
«Oh, bene. Oggi ho una gran voglia di lavorare. Starei qui tutta la notte, tutta la settimana… Un mese intero starei qui. Mentre tu, Michele, me ne sono accorto che non vedi l’ora di uscire».
«Be’, in effetti sono stanco».
«Sei stanco?» Scuote la testa non riuscendo a celare il suo disprezzo: «Con la disoccupazione che c’è, tu ti permetti di essere stanco. Devi stare molto attento, Michele».
Deglutisco a fatica.
«Togliti dalle palle, adesso».
«Grazie, capo», dico, ed esco dall’ufficio.
Vado a casa, e subito Ness, la nostra dolcissima capra, mi si fa incontro e mi lecca la mano. Questa bestia è l’unico mio affetto. Già, perché con Eleonore le cose non vanno troppo bene.
«Buona, Ness», dico, e vado in cucina, dove trovo Eleonore sprofondata sul divano, tutta presa a guardare il telegiornale, nel quale si parla delle tremende difficoltà in cui si trova la nazione, e degli sforzi inauditi che fanno quei poveracci di ministri per renderci la vita sopportabile.
Mi chiedo perché, nonostante le infinite discussioni e liti, Eleonore si ostini a guardare una simile spazzatura; ma ormai ho rinunciato a capire e a discutere, tanto che a volte mi siedo anch’io davanti al televisore e fingo interesse per compiacerla. Povera Eleonore! Da quando ha avuto quell’incidente alla catena di montaggio… Si è ripresa alla grande, ma è sempre nervosa.
«Ciao Ele», le dico dandole un bacio sulla fronte impiastricciata di creme.
Scommetto che ancora una volta ha provato a fare una torta, ma con i due moncherini che le sono rimasti deve aver avuto qualche problema.
«Ciao», fa lei, lo sguardo incollato allo schermo.
Mi tolgo la cravatta e mi tuffo sul divano, appoggiando la testa sulle cosce di Eleonore.
«Michi, mi dai fastidio».
«È che ho voglia di te, Eleonore».
«E io no».
L’ennesimo rifiuto.
«Ho una certa famuccia», dico alzandomi di scatto e pescando dal frigo la solita anguria.
Eleonore mi guarda storto: «Sempre l’anguria?»
«E cosa vorresti, l’aragosta?»
«Magari».
«Accontentati dell’anguria. Cavolo, Ele. Sono tempi duri, lo sai».
Solo dieci anni fa, prima della catastrofe economica che ha gettato sul lastrico milioni di persone, le cose andavano diversamente. Non dico che fossimo ricchi, ma non eravamo preoccupati.
Col groppo in gola taglio l’anguria a metà, e metto ogni metà nei rispettivi piatti. Dopodiché mangiamo: con la tv accesa, naturalmente. Eleonore sostiene che la televisione la fa stare meglio, che le è necessaria. Le piace un mondo vedere le giacche nere. Le adora tutte, specie se a indossarle sono i nostri rappresentanti governativi. Mentre stiamo finendo di mangiare, sento il mio arnese pulsare di un desiderio che non verrà soddisfatto. L’unica consolazione, oltre a una tazza di caffè, è quella di fumare sigarette da due soldi.
Sono lì che fumo, guardando un programma idiota e pensando che da un momento all’altro correrò in bagno a masturbarmi, quando Eleonore mi si siede vicino vicino: «Michi!»
«Sì?»
«Cosa ne diresti se domani sera invitassimo i Colaianni?»
Trattengo a stento un porca puttana, no, i Colaianni no, lo sai che non mi piacciono per niente. Entrambi scrivono su un giornalucolo locale. Morti di fame come noi, anziché accettare la loro misera sorte, camminano a due spanne da terra, convinti che il loro lavoro sia il più bello e il meglio pagato di questo mondo. Tutt’e due magri da far paura, con le guance scavate, ma con un sorriso talmente largo e falso, che sembra dovuto a due chiodi conficcati ai lati delle labbra.
«Ma, perché proprio i Colaianni?»
«Mah, mi sono simpatici e pensavo che la loro compagnia facesse piacere anche a te».
«Simpatici? Ma quando mai, andiamo!»
«Me l’hai detto più di una volta».
«Ti sbagli di grosso».
«No, non mi sbaglio. Comunque è inutile discutere».
«Infatti».
«Be’, io vado a dormire. Domani devo lavorare».
«Ma domani è domenica».
«Embè, lo sai che vado a lavorare, no?»
«Di’ piuttosto che vuoi andare a lavorare. Per prendere due o tre punti in più sulla scheda di valutazione di fine anno».
«Be’, io voglio arrivare a cinquanta. Non come te, che è una vita che sei inchiodato a quarantadue. Comunque piantiamola lì. Non ho voglia di discutere».
Appena Eleonore va a letto, Ness viene vicino a me.
Le prendo il muso con le mani: «Ness, tesoro. Sei tu il mio unico amore, vero?»
Lei non mi risponde. Io l’accarezzo, poi filo a letto: domani sarà una giornata dura.
2
La domenica non c’è divertimento, per me. Non ci sono partite di calcio, né passeggiate in campagna, né tiro al piattello: c’è solo il mio lavoro. O meglio, la mia missione. In un locale striminzito, privo di finestre, dove l’unica nota di colore è costituita da alcuni poster di Balzac, Brad Pitt, Edward Norton, Gandhi e gli U2, conduco la mia lotta segreta contro le giacche nere. Sto cospirando e questo mi fa sopportare tutte le schifezze e i soprusi del mondo, e le lamentele di Eleonore.
In cosa consiste la mia cospirazione? È presto detto: cerco di salvare quanti più inefficienti possibile dall’internamento in quell’inferno che sono le Case di recupero per l’efficienza. Come ci riesco? Falsifico carte di ogni tipo, mi sbatto per rendere recuperabili gli irrecuperabili, fornisco passaporti per quei paesi del Sudamerica dove l’efficienza non è il credo assoluto della nazione.
Di solito, alla porta del mio bugigattolo si presentano giovani disperati, ma anche donne: casalinghe, disoccupate, imprenditrici in crisi; e poi vecchi, sì, vecchi che sognano di chiudere gli occhi per sempre con un voto che sfiori l’agognata sufficienza. Da qualche anno a questa parte, fra i miei clienti, annovero sempre più ragazzini, che pur di ottenere i miei servigi sono pronti a sfoderarmi sotto al naso un revolver. Io non m’impressiono e falsifico tutto ciò che c’è da falsificare: patenti, carte di identità, licenze di commercio, certificati di laurea, pagelle scolastiche.
Sto per dare inizio al mio lavoro, quando sento bussare alla porta.
Di fronte a me si presenta una bella tipa, poco più che ventenne, fresca, capelli morbidi e due seni poco più grandi di due coppe di champagne. E gambe lunghe, affusolate, di gran lunga più belle di quelle di Eleonore.
«Mi chiamo Ludmilla», si presenta lei. «Sono un’amica di… di Gualtiero».
Fortunatamente Gualtiero è un amico: «Cosa posso fare per te?»
Imbarazzata, si raschia la gola, poi dice che deve falsificare una relazione di condominio. Fisso quei begli occhioni e chiedo se per caso le hanno dato cinquanta su cento.
«Meno», dice lei con un sorriso nervoso. E mi allunga un papiro zeppo di timbri e di firme. Gli do un’occhiata, ma non vedo nemmeno cosa c’è scritto. Il seno di Ludmilla attrae il mio sguardo più di una calamita.
«Puoi fare qualcosa?» mi chiede lei mordicchiandosi un’unghia.
«Certo. Ma devi darmi un paio di giorni. Lasciami il tuo numero, non si sa mai».
Ludmilla segna il numero su un foglietto, poi mi regala il suo sorriso più grato: «Prenditi tutto il tempo che vuoi. Solo, ti prego, fa’ un buon lavoro».
Il solito appello! Come se non fossi il migliore falsificatore di documenti in circolazione! Le dico di non preoccuparsi. Lei mi chiede quando potrà tornare: «La settimana prossima». Restiamo intesi e se ne va.
Ho la forte tentazione di abbracciarla, ma mi ripeto quel che so già: con le clienti è meglio non avere complicazioni sentimentali. Se si cade nella rete di certe complicazioni, si mette a rischio il proprio lavoro, e tanto vale mettere un cartello alla porta con su scritto: scusatemi tanto, ho mancato al mio impegno. Mi vergogno come un cane. Scusatemi ancora, e buone vacanze.
Ma stavolta sarà dura dominarmi.
3
Mi sveglio con un gran mal di testa.
Chiamo Eleonore per chiederle se sa dove sono le aspirine, ma non risponde nessuno. Per forza. Eleonore è già al lavoro. In compenso chi è che si affaccia sulla soglia della stanza? Ness, la nostra capra.
«Buongiorno bella».
Lei attacca a belare, il che non è proprio il rimedio di cui ho bisogno.
Butto giù i piedi dal letto e mi accorgo di essere in ritardo. Che fare?
Telefono al capo per avvisarlo che non posso andare in ufficio. Prende male la mia defezione.
«Fingi, Michele, tu fingi!», sbraita. È invasato: «Tu vuoi fottermi. Ma guarda che con me hai sbagliato indirizzo. Io ti tengo per le palle, hai capito?»
«Vengo oggi pomeriggio, sto male da cani».
«Non ti credo».
Dico che sono a pezzi, che non so se lui può capire.
«Fanculo», dice lui, e chiude la comunicazione.
Torno a sdraiarmi sul letto. Ness mi viene vicino e mi appoggia il muso sul petto. Le do una carezza, poi la prendo per la collottola e la trascino nel bagno, dove comincia a belare. Mi metto i tappi nelle orecchie, e faccio colazione.
Non riesco a non pensare a Ludmilla. Pensando a lei mi eccito subito, ma stavolta non mi sparo una sega. Mi dico che ho una moglie. E Ness. Insomma, una famiglia. Cavolo, come sono depresso. Per riprendermi mi attacco al Penbridge, il modulatore di umore. Metto l’assesta-umore su livello tre, programma Ripresa rapida da cadute di umore.
Per fortuna, dopo qualche minuto i nervi si distendono. Ma Ludmilla non riesco a togliermela dalla testa. Verso mezzogiorno, grazie al Penbridge, ho recuperato quel buonumore sufficiente a farmi alzare dalla sedia per farmi la barba. Vado in bagno e Ness esce come una palla da schioppo. E si allontana da me.
«Che c’è, piccola?»
Lei bela. Deve essersela presa perché l’ho chiusa in bagno. Le passerà.
Mangio un boccone, e corro alla fermata, dove due minuti dopo arriva l’autobus, che mi porta dritto al lavoro.
4
Il capo non mi frusta né mette in atto manovre di ritorsione. Si limita a dire: «Ah, sei qui, finalmente».
La mole di lavoro che c’è all’Ufficio casi disperati deve avergli fatto capire l’importanza della mia presenza. Lavoro come uno schiavo, ma ho la testa da un’altra parte. Spasimo dalla voglia di inviare un messaggio a Ludmilla, di dirle che l’ho amata fin dal primo momento, che sarei pronto a fuggire con lei, anche se non so dove: io sono al verde, come del resto lo sono milioni di miei concittadini, e se andassi con Ludmilla in qualche altro paese non farei altro che arricchire le falangi di disoccupati, facendo dei sit-in davanti agli uffici di collocamento, e strappare un improbabile sussidio.
Mi conviene dominare questo desiderio, se non voglio mettermi nei guai. Qualsiasi mio messaggio potrebbe venire intercettato. E se le giacche nere, o i ministri della Chiesa – che con le giacche nere, si sa, vanno a braccetto – scoprissero che sono un fedifrago, me la passerei maluccio. La mia valutazione crollerebbe sotto i 30/100 e per me si aprirebbero le porte di una clinica.
Quando, dopo sei interminabili ore di lavoro, torno a casa e mi trovo a tavola con Elenore, sono tentato di dirle come stanno le cose, ma siccome lei non mi guarda in faccia, preferisco rimandare. Visto che non sono molto allegro, mi attacco al mio aggiusta-umore, al che Eleonore osserva perfida: «Hai di nuovo tirato fuori quel coso?»
«È un apparecchio di prim’ordine, che ti aiuta a ritrovare il buonumore. Credo che dovresti provarlo anche tu. Saresti meno acida».
«Non cercare di coinvolgermi nei tuoi problemi. Io non ho bisogno di certi marchingegni. Sei tu che non riesci a adattarti alla vita. Pensavo che la presenza di Ness potesse aiutarti, ma sbagliavo».
Nonostante l’influsso benefico del Penbridge, mi altero di brutto.
«Lascia stare Ness. Cosa c’entra lei?»
«C’entra. Se nemmeno lei ti aiuta, vuol dire che sei irrecuperabile».
«Pensa per te. Il mio Penbridge mi aiuta, eccome se mi aiuta. Sopporto meglio la vita».
«Mi fai pena. La vita è meravigliosa e tu non te ne accorgi».
«Vita meravigliosa? Lavorare dodici, quattordici ore al giorno al servizio delle giacche nere, tu la chiami vita meravigliosa?»
«Giacche nere? Ma ti accorgi che stai delirando? Quelle che tu chiami giacche nere sono gli stessi che si stanno facendo un mazzo così per raddrizzare le sorti del nostro paese. Vivono soltanto per rimettere in carreggiata la nostra economia, e non sono certo quei diavoli che tu vuoi vedere».
Sentire mia moglie dire queste falsità così assurde, mi fa male.
«Okay, il visionario sono io. Non voglio più discutere. Parlare con te rende inefficace il lavoro del Penbridge, perciò fammi il favore di farti gli affari tuoi».
«Crepa».
5
Tre giorni d’inferno durante i quali ho dovuto stringere i denti per non cercare Ludmilla. Altri attacchi parossistici di desiderio li ho avuti quando, la sera, sono uscito dall’ufficio e l’idea di tornare a casa, anziché consolarmi, aumentava il mio scontento, accendendo il desiderio di Ludmilla, e insieme a esso i dubbi, le paure.
Il peggio è venuto quando, venerdì sera, arrivo a casa e chi ti trovo? I Colaianni, naturalmente. Faccio buon viso a cattivo gioco. Stringo la mano a Walter, e a Glenda, sua moglie, una biondina niente male, coi capelli a caschetto e le gambe un po’ secche ma sensualmente nervose.
Chiedo a cosa dobbiamo questa bella sorpresa, ma visto che i coniugi Colaianni hanno il solito sorriso inchiodato sulla faccia, interviene una entusiasta Eleonore: «C’è una bella novità».
«Ah sì?»
«Dobbiamo festeggiare l’avanzamento di Walter. Pensa, è stato promosso».
«Cos’è, lo hanno fatto caporedattore?»
«Ma no, gli hanno dato settanta, capisci? Settanta! Ormai, è praticamente un efficiente», sorride maliziosa, «o giacca nera, come dici tu».
La notizia non mi stupisce. È chiaro che Walter Colaianni, essendo un portaborse delle giacche nere, sia stato promosso.
Walter mi stringe ancora una volta la mano. Guardo la maglietta grigia che indossa, e le vistose bretelle blu che servono solo a tenergli su i calzoni, anch’essi grigi e incredibilmente larghi.
«Vedrai che un giorno ce la farai anche tu, anche se per gli impiegati è un tantino più dura. Sai com’è, i dipendenti pubblici non sono visti di buon occhio».
Dico che lo so, e mi chiedo se non sia meglio fingere un malore, dire che devo andare in farmacia e rifugiarmi nel mio covo, dove forse è rimasta ancora una traccia del profumo di Ludmilla. Ma Eleonore mi prende sottobraccio: «Vieni, caro, sediamoci a tavola, ché è pronto».
Ci sediamo. Eleonore ci serve arrosto con bacche fritte.
Subito Ness fa capolino alle mie spalle.
«Michi, da’ una bacca a Ness», dice Eleonore.
«Non ci penso nemmeno. Credo abbia già mangiato, no?»
Eleonore alza gli occhi al cielo: «Sei insopportabile, quando ti ci metti».
«Su, ragazzi, non bisticciate», ci esorta un’amorevole e sorridente Glenda.
«Non è facile, Glenda. Non hai idea di che cosa voglia dire avere a che fare ogni giorno con la negatività fatta persona. È così bello vivere, e lui avvelena la vita».
Ness si prende una bacca dal mio piatto. Al che le do una scoppola fra capo e collo.
«Michi. Ma cosa diavolo fai?» urla Eleonore, che ha deciso di mettere in scena i nostri problemi di convivenza. All’improvviso scoppia a piangere, e intanto bofonchia: «Lo vedete anche voi, no, con che bel tipo ho a che fare. Ma adesso ti avverto, Michi, e lo faccio davanti ai nostri amici: io non ce la faccio più a vivere in questo modo».
«Forse Michi è un po’ esaurito», concede Walter. «Passare le carte è un lavoro duro, Eleonore. Se hai la fortuna di scrivere, come facciamo Glenda e io, dai voce a un mondo tuo, cresci, ti espandi, non so se mi spiego. A passar carte tutto il santo giorno, invece, non partecipi, ti avvilisci. E poi, tieni conto che tuo marito lavora all’Ufficio casi disperati. Dico bene, Michi?»
Annuisco.
«È un lavoro duro», continua Walter: «Io davvero non so come fai a resistere. Dodici ore di lavoro, e tutte quelle pratiche da sbrigare, con quella marea di voti. Tutto per vedere chi è inefficiente e chi no».
«E tu non lo sei più», cinguetta Eleonore. All’improvviso applaude coi suoi moncherini che fanno uno strano rumore, clac clac.
«Sono così felice per te, Walter. Settanta su cento. È meraviglioso. Michi, non trovi che sia meraviglioso?»
No, non lo trovo. Per cui sto zitto.
«A cosa stai pensando, Michi?» Chiede Glenda.
«E secondo te un tipo del genere è capace di pensare?» Sibila Eleonore.
«Abbiamo proprio intenzione di rovinarci la serata?» Chiede un inappuntabile Walter.
Eleonore sfodera un sorriso splendente: «Hai ragione, caro. Scusaci». Guarda Glenda, e le posa il palmo della mano sulla sua: «Scusaci anche tu, Glenda».
«Ma niente. Sono cose che capitano a ogni coppia sposata».
«A… anche a voi?» chiede Eleonore.
«Be’, a noi no. Noi siamo molto felici. Soprattutto dopo la promozione di Walter. Vero, Walter? Fagli vedere cosa ti sei comprato».
Walter sparisce. E dopo un minuto riappare, con indosso una splendida giacca nera, che deve essere costata un occhio della testa.
«Glenda! Chiudi tutte le tende!» Invoca Eleonore, con un tono che potrebbe far pensare che qualcuno di noi si trovi in serio pericolo.
«Perché chiudere le tende?» chiede Glenda, sorpresa.
«Ma per la Giacca Nera, no? Lui, Walter, non lo è ancora, no?»
«Non lo è ancora, ma può portarla tranquillamente», la rassicura Glenda, non senza orgoglio.
Walter è in piedi, con indosso la sua giacca nera, e come d’incanto sulle labbra gli sboccia il solito sorriso ebete delle giacche nere, che è una versione più estasiata e gongolante del suo solito sorriso fissato coi chiodi.
«Se non vado ancora in ufficio con questa, è perché non voglio dare nell’occhio. Ma è vicino il giorno in cui potrò portarla anche per andare allo SpendiMeno».
«È davvero magnifica. Complimenti!» Dice Eleonore, ammirata.
«Adesso valla a rimettere nel sacchetto. L’abbiamo comprata ieri, e volevamo farvela vedere», dice Glenda con lo stesso tono di chi ha appena mostrato un gioiello dal valore inestimabile.
Sono nauseato.
Walter torna fra noi, e proprio in quel momento squilla un cellulare.
«È il mio», dice, e risponde. Subito sul suo volto si disegna un’espressione accigliata. «Ciao capo. A cosa devo questa chiamata? Come? Ma no. Oh santo cielo. Chris, non chiedermi questo adesso. Sono in compagnia di amici. Non puoi mandare qualcun’altro? Tutt’e due? Vuoi dire io e Glenda?»
Walter ci guarda e scuote la testa.
Eleonore mi lancia uno sguardo astioso, come se avessi combinato qualcosa che l’ha fortemente contrariata.
«Chris, lo sai che non dico mai di no, che sono sempre disponibile. Ho come ospiti questi amici molto cari, e che figura farei se… Capisco, capisco. Okay, verremo. Anche Glenda, sì sì. Saremo sul posto fra non più di un quarto d’ora. Avrai un servizio coi fiocchi, Chris. Ci vediamo domattina».
«Che c’è, Walter?» chiede Glenda.
Walter ci guarda contrito: «Cosa ti dicevo, Eleonore? Questo lavoro mi toglierà la vita. Dobbiamo andare subito via. Per un servizio. Una cosa grossa. Un ministro che sosteneva l’insostituibilità della famiglia ha ucciso moglie, figli, suocera, nipoti. Un massacro».
«Non preoccuparti per noi, Walter», dice Eleonore, «il lavoro è lavoro».
«Eh già. Ragazzi, non sapete quanto mi dispiace. Era così bello trascorrere una serata con amici, e invece dobbiamo correre alla svelta. Sono mortificato».
«Scusateci, davvero», dice Glenda, che in fretta e furia s’è infilata un giubbottone tipo missione in Antartide.
Da questo momento in poi tutto si svolge in modo accelerato, come se fossimo i protagonisti di un film muto. Io sono contento che i coniugi Colaianni se ne vadano. Una manna dal cielo questa chiamata improvvisa per Walter e consorte!
Chi è nera invece è Eleonore. Con Walter e Glenda si mostra dispiaciuta, li bacia e li abbraccia, e dice loro pazienza, ragazzi, sarà per un’altra volta, a presto. Ma appena sono usciti mi vomita addosso una sequela di insulti: «Tutta colpa tua, idiota. Ci hanno scaricato, non ne potevano più di noi. Quella che hanno ricevuto era una telefonata fasulla».
«Non essere paranoica, Ele. Era una chiamata di lavoro, lo si capiva benissimo».
Eleonore mi guarda con disprezzo.
«Povero idiota! Ma come fai a stare in questo mondo? I Colaianni non ne potevano più di noi, di te soprattutto, dei tuoi musi. E quando Walter ha tirato fuori la sua splendida giacca nera, l’avrebbe visto anche un cieco che morivi di invidia».
«Ah sì?»
«Sta’ zitto, cretino. I Colaianni non ne potevano più, Glenda lo ha chiamato col suo cellulare, e Walter ha fatto la sceneggiata. Ma non li biasimo. Avrei fatto anch’io la stessa cosa. Ci hanno scaricati. Abbiamo perso gli unici amici che avevamo».
«Ce ne faremo degli altri».
Eleonore lancia uno strillo e guarda il soffitto della cucina: «Chi? Dimmelo! Nessun amico, avremo. E tutto per colpa tua. E adesso ci daranno una votazione che abbasserà la nostra media, capisci? Tu rischi di diventare un inefficiente irrecuperabile, e forse io me la caverò per il rotto della cuffia. E tutto per colpa tua!» E scoppia a piangere.
«Trovo la tua reazione esagerata, faresti bene a usare l’aggiusta-umore», le suggerisco.
«Vaffanculo, idiota».
6
Sono di nuovo nel mio covo. Finalmente. Solo qui, fra le mie scartoffie, mi sento a casa mia. Ancora con l’impermeabile addosso do un’occhiata alle pratiche che ho falsificato, fra le quali c’è quella di Ludmilla. Poi, visto lo sporco che mi assedia da ogni parte – più che altro fuliggine, dovuta all’inceneritore che sorge a non più di cinquecento metri da questa stanzetta – mi tolgo l’impermeabile e passo lo straccio sulle sedie e sulla scrivania, e in ultimo lavo per terra. Sono lì che sfrego quando sento una voce inconfondibile: «Michele», dice.
Mi volto. È lei, Ludmilla. Il viso etereo, gli occhi chiarissimi.
Gesù, quanto mi piace! Per lei metterei a repentaglio ogni cosa. Anche i miei 42/100. Ma sì. Chi se ne frega di tutte le regole sulla famiglia, l’adulterio e compagnia bella. Contengo a fatica il mio desiderio di abbracciarla e le dico che sono felice di vederla.
Lei tace. E con voce afona dice solo: «Michele, io…»
È in quel preciso momento che entrano due tizi che potrei scambiare quasi per modelli divise nere. Ma non c’è alcun dubbio, sono poliziotti.
Afferro per le spalle Ludmilla, e mi metto davanti a lei per proteggerla.
«È lei Michele Cantarella?» mi chiede uno dei due.
Dico di sì: «Perché?»
«Venga con noi, glielo spiegheremo alla centrale, il perché».
Mi volto verso Ludmilla, ma lei evita il mio sguardo. Sembra mortificata.
In testa ho un casino pazzesco. No, non può essere. Balbetto: «Ludmilla, non dirmi…»
In quel momento capisco e mi precipita il mondo addosso. Il mio cuore annaspa in cerca di sangue che chissà dove si è andato a ficcare.
I due uomini dalle divise nere mi portano via come un delinquente qualsiasi.
Alla centrale c’è un’aria di gelo ovunque. Le divise nere hanno modi di fare terrificanti. Vengo trascinato davanti a una scrivania di acciaio, dietro alla quale è seduto un tipo di età indefinibile.
«Ci dica ciò che ha da dirci, così non perdiamo tempo».
Tergiverso, cerco di depistarli. Ma quando mi chiedono del mio lavoro di falsificatore di documenti, di cosa mi proponevo di fare, be’, a quel punto ho la sensazione che se non rispondo mi spaccheranno qualcosa che mi farà molto male.
Dovrei resistere? Sarei in grado di resistere? No, ultimamente mi sono fiaccato parecchio. Non ho più fatto ginnastica, né pesi, né alcun tipo di moto. Ho messo su un po’ di pancetta. E poi le conosco, le divise nere. E so che non avrei scampo. Perciò spiffero tutto.
7
Sono davanti a un giudice.
Strano, ho anche un avvocato: hanno voluto darmelo per forza. Così non potrò lamentarmi che i miei diritti non sono stati rispettati.
Comincia il dibattimento. Prende la parola il piemme che inizia a elencare un’infinita serie di capi di accusa. Alzo un braccio perché vorrei fargli notare che ha sbagliato persona, ma il mio avvocato mi fulmina con un’occhiata e mi chiede se sono pazzo: «Tenga giù quel maledetto braccio, vuole peggiorare la sua situazione?»
Non apro bocca e mi disinteresso del processo. Tanto, faranno di me quello che vogliono.
Dopo una mezz’oretta di dibattimento, il giudice si ritira per pochi minuti, quindi rientra in aula, e legge la sentenza. Contrariamente alle mie previsioni, non mi mandano in una Casa per il recupero dell’efficienza, no. Io, come sottolinea il giudice fissandomi con quei suoi occhi da corvo, sono peggio di un irrecuperabile, io sono un delinquente, un pericolo per la società. Per me c’è solo il carcere duro.
«È stato fortunato, mi creda». Dice l’avvocato, raccogliendo le sue scartoffie. «Sarà una nuova esperienza. E poi ci rimane sempre l’appello».
Capisco, dico, guardandomi intorno, nella speranza di vedere Eleonore. Ma non c’è. Si vede che ha avuto di meglio da fare. E Ness? Cosa farà, Ness? Rimpiango i suoi belati.
Lascio l’aula e raggiungo il carcere.
8
Ho due compagni di cella: solo che non indossano la divisa a strisce. Vestono la camicia nera. La loro presenza qui me l’ha spiegata il direttore del carcere, il dottor Grund, un nanerottolo antipatico che quando parla sputacchia: ho bisogno di una raddrizzata. Saranno quei due a rendermi il carcere più o meno duro. Dipende da me.
Faccio garbatamente notare che devo ancora giocarmi la carta del processo di appello, e il dottor Grund dice: «Ah, lei ci spera? Bravo, fa bene. Sappia che se cambiasse idea, se dimostrasse di essersi pentito, be’, il Processo di appello potrebbe esserci piuttosto alla svelta. In caso contrario…» Mi fa un sorrisetto e se ne va.
I due tizi in camicia nera mi fanno visita un paio di volte la settimana. Ogni mattina, in genere prima di farmi la barba, entrano nella mia cella, mi chiedono un formale come va, e cominciano a malmenarmi, a prendermi a ciabattate in faccia, in modo che non si vedano i segni. «Non meriti altro, bel tomo. Basterebbe che ti ravvedessi, e quelle che tu stupidamente chiami giacche nere mostrerebbero molta comprensione nei tuoi confronti. Il nostro primo ministro è la persona più comprensiva di questa terra. Cosa ne diresti di rilasciare un’intervista al tuo amico Walter Colaianni? Potresti dirgli che cominci ad avere dei dubbi su ciò che hai fatto e detto in passato».
Dico di no. Loro ridacchiano e dicono che sono una testa dura, ma che col tempo mi ammorbidirò.
Hanno ragione loro. A furia di stare a pane e acqua e di prendermi ciabattate in faccia e sulle reni, nel giro di un paio di mesi non sto più in piedi. Poco prima di Natale mi fanno dono di un bastone, a dimostrazione della natura comprensiva dei miei carcerieri. Ricevo una cartolina di auguri del mio capo in cui mi dice che in ufficio si sente la mia mancanza. Ricevo anche una lettera di Walter:
Come va, testone? Perché continui a darti la zappa sui piedi da solo? Quando lo ritieni opportuno fammi un fischio e io farò un salto da te per farti un’intervista che costituirà il primo e decisivo passo verso la liberazione.
Intanto ti faccio i migliori auguri di buon Natale.
Ricevo una lettera anche da Eleonore:
Scusa se ti scrivo dopo parecchi giorni, ma c’è voluto un po’ per digerire la verità che sono venuta a sapere sul tuo conto. E chi se l’aspettava di avere un marito falsificatore di documenti? Essere un nemico giurato delle giacche nere ha un senso? Le giacche nere sono persone fantastiche, superiori a noi che navighiamo fra l’inefficienza recuperabile e quella irrecuperabile. Capisco quanto possa esser dura, per te, accettare questo dato di fatto, dal momento che psicologicamente sei rimasto un ragazzino.
Povero caro, immagino quanto te la passerai male dove sei adesso. Probabilmente uscirai di senno, il che sarà un bene. I poliziotti non mi hanno detto granché sul tuo conto. Mi hanno permesso di scriverti, assicurandomi che in un modo o nell’altro ti faranno pervenire la mia missiva. Se sono stati di parola, non mi è dato sapere. Io mi auguro di sì. Altrimenti cosa scrivo a fare?
Sappi che questa è l’unica lettera che ti scrivo. Voglio il divorzio. Primo perché non accetterei più di vivere accanto a chi mi ha nascosto a lungo la verità, secondo perché adesso ho un altro uomo. Si chiama Enrico, ed è un inefficiente recuperato, ossia un 60/100. Insomma, vale più di te. È una persona cara. Fa il macellaio, mi rispetta, chiava come un dio, non come te che ultimamente stentavi a venire, e credo proprio che avremo quel figlio che tu non hai mai voluto.
Oltre che a me, Enrico vuole molto bene alla nostra Ness. La accarezza e la porta a passeggio. Ness sembra contenta, e penso si sia rassegnata a non vederti più.
Ti auguro di sopravvivere, caro Michi, e, se ci riuscirai, di farti una ragione di com’è questo cavolo di mondo. Mi dispiace che tu non abbia il tuo modulatore di umore: so che ne avresti grande bisogno. Non scrivermi perché non ti risponderei.
Un abbraccio,
Eleonore
Appena finisco di leggere la lettera, provo un po’ di dolore, non tanto perché non rivedrò più Eleonore, o perché si sposerà con un inefficiente recuperato. Che cavolo me ne frega di quello che farà lei? No, il dolore che provo è per Ness: non mi poserà più il muso sulle ginocchia, non mi verrà più fra i piedi per chiedermi di farla uscire. Quell’Enrico la farà fuori, e la darà da mangiare a Eleonore, e la scema lo guarderà sdilinquita e dirà: “Oh, Enrico, erano secoli che non mangiavo una carne così tenera”.
Può darsi che questa lettera sia un trucco, ma io non ce la faccio più. Non mi riconosco più allo specchio per via di tutte le botte che ho preso. Per di più hanno creato un discreto buco anche nella mia memoria.
Dico ai miei compagni carcerieri che accetto le loro condizioni. Si complimentano con me, mi danno delle pacche sulle spalle. Un’ora dopo sono davanti a Walter Colaianni che ha la faccia tosta di dirmi che ho una bella cera.
«Taglia corto», dico. Poi dico che nella mia vita ho sbagliato tutto, che la nostra società è la più bella che si possa desiderare e che sono stato davvero uno stupido a contestarla.
Walter annuisce e guarda quel gioiellino di registratore che ha posato a meno di un metro da me, al che io proseguo dicendo che le giacche nere, contrariamente a quanto ho sempre creduto, sono delle gran brave persone, le quali hanno a cuore non l’accrescimento del loro conto in banca, come uno stolido del mio calibro poteva a prima vista pensare, né il desiderio malato di popolarità, bensì solo e soltanto le sorti del nostro amato paese. Dico poi che la rovina del paese non è dovuta all’evasione fiscale perpetrata a ogni piè sospinto da imprenditori, medici, dentisti, avvocati e compagnia cantante, ma solo e soltanto da quei furbetti che sono i dipendenti pubblici.
Su precisa domanda di Walter rivelo poi i miei gusti in fatto di televisione. Dico che i reality show sono dei programmi necessari, che mettono addosso la voglia di vivere. Confesso poi che, quando ascolto il papa, mi commuovo. Ma che piango addirittura di gioia quando mi capita di vedere o di sentire la giacche nere, a Bruxelles, che vogliono solo e soltanto il nostro bene.
«Per il momento può bastare», dice Walter. «Hai fatto la cosa giusta, amico. Sei ancora giovane, e se anche tua moglie ti ha lasciato, puoi rifarti una vita».
In cella non entra più nessuno a picchiarmi. Adesso mi portano sigarette, whisky e vagoni di tiramisù.
Quando, pochi giorni dopo, mi presento davanti al giudice per il processo di appello, non mi reggo in piedi nemmeno con l’aiuto del bastone.
Il giudice dice che sono libero, che posso essere riconsegnato alla società, ma che il mio vecchio lavoro me lo scordo, visto che ho l’interdizione ai pubblici uffici: «Ah, un’ultima cosa: è necessario che venga controllato da una équipe di psichiatri. Ha qualcosa da dire?»
Scoppio a ridere fino alle lacrime.
Il giudice mi fulmina con un’occhiata, poi si rivolge a due divise nere: «Toglietemelo di torno».
9
Sono fuori. In tutti i sensi. Fuori dal carcere, e fuori di me, fiaccato dagli eventi. Per fortuna ricordo ancora il numero dell’autobus che mi porterà a casa. Mi siedo su uno dei tre sedili di ferro, incastrati nella pensilina, e aspetto. Aspetto un bel po’, e quando finalmente l’autobus arriva, salgo e mi affloscio nel primo posto libero che trovo.
Dopo una quindicina di fermate, arrivo nel mio quartiere. Ma ho un colpo al cuore. La gente, la mia gente, quella che vedevo ogni giorno, quella con cui di tanto in tanto scambiavo qualche parola, mi guarda torva, con malcelato disprezzo. Mi guardo il petto per vedere se per caso sulla maglia che indosso c’è marchiato il numero zero. No, non c’è. Ma è come se ci fosse, lo so.
Di corsa guadagno casa mia. Non c’è nessuno. Sul tavolo di cucina trovo un’altra lettera.
Questa lettera è per te, Michi. Probabilmente non la leggerai mai perché ti avranno fatto fuori. Ma se per caso riuscissi a venire via da quell’inferno dove ti hanno cacciato – so che le tenterai tutte per venir via: nella tua follia paranoica, che ti porta a lottare contro i mulini a vento, sei ostinato: è l’unica virtù che ti riconosco. Per il resto sei un disastro – e ti trovassi a metter piede in questa catapecchia, desidero che tu non stia in ansia per Ness e me. Non cercare Ness: qualcuno l’ha fatta secca. Tu sai che razza di gente circola nel nostro condominio-alveare. Ho sofferto molto per la mancanza di Ness, e so che anche tu ne soffrirai.
Io sono partita col mio adorato Enrico, che si rivela ogni giorno di più un fior d’uomo. Lo amo pazzamente, e quando sono fra le sue braccia dimentico in che mondo viviamo. Per il male che ti voglio, auguro anche a te qualcosa del genere.
Eleonore
10
Povera Ness. Ammazzata da un macellaio. Era chiaro che sarebbe successo, visto la crisi che c’è e il prezzo della carne. E quella cretina di Eleonore non l’ha capito.
Mi guardo intorno e ovunque trovo strati e strati di polvere. Riuscirò a toglierla? Oppure soccomberò a essa? Diavolo, che tristezza! Dritto come un automa vado alla credenza. La apro ed eccolo lì il mio modulatore di umore! Eleonore deve esserselo dimenticato. Un vero colpo di fortuna! Lo prendo, mi ficco gli elettrodi in testa e lo programmo su Recupero rapido di speranza.
11
Ho recuperato un umore discreto, ma mi sento parecchio confuso. Quando incontro una bambina con la mamma, mi intenerisco e, carezzandola sulla testa, le dico: «Ciao Ness, come va?» Chissà perché, la mamma mi guarda inorridita e scappa con la sua figlioletta.
Un paio di mattine alla settimana vado al Centro malati mentali. Non siamo in tanti, per fortuna. Quasi tutti parlano per conto proprio. Io devo ancora stabilire questo particolare legame con me. E, grazie al mio Penbridge, mi auguro di rimandare il più possibile quel giorno.
Quando arriva il medico che si occupa del mio caso, mi chiede il solito come va. Io non parlo, e a volte piango un po’. Il medico scuote la testa e mi rifila una decina di scatolette, che io lascio cadere in un sacchetto di plastica. Quindi ringrazio e lo saluto.
Alcuni giorni fa, la buona sorte ha accarezzato la mia porta. Il postino mi ha consegnato una raccomandata che conteneva un invito a partecipare a un corso di manichino per negozi. Ho aderito. La valutazione della prima settimana è stata: Può fare di meglio. Il che mi inorgoglisce. Sì, posso fare di meglio. Se dirò sempre di sì ai miei istruttori quando mi chiedono di andare a fare la spesa per loro, se dirò in tutti i negozi che il ponte sullo stretto di Messina è un’opera che solo un grandissimo statista può aver pensato, se dichiarerò ai quattro venti che l’eutanasia è una immane sciagura, se andando da un medico non mi opporrò al suo desiderio di non farmi la fattura, se tutte le mattine dirò le preghiere, se proporrò il mio nome come portatore di croci nelle sagre paesane, forse, dico forse, un domani, magari non tanto lontano, un 30/100 riuscirò a strapparlo.
Andrea Guano è nato a Genova nel 1948. Ha svolto un’enormità di lavori. È stato segnalato due volte al Premio Calvino. Ha pubblicato un racconto su Colla, e l’incipit di un romanzo su Cadillac.