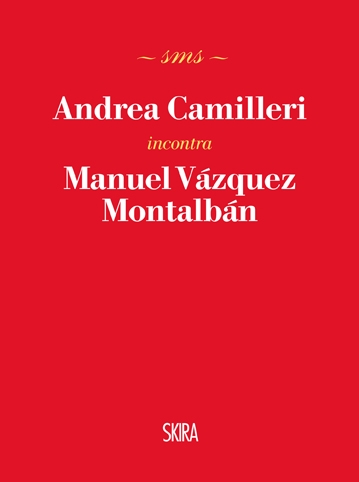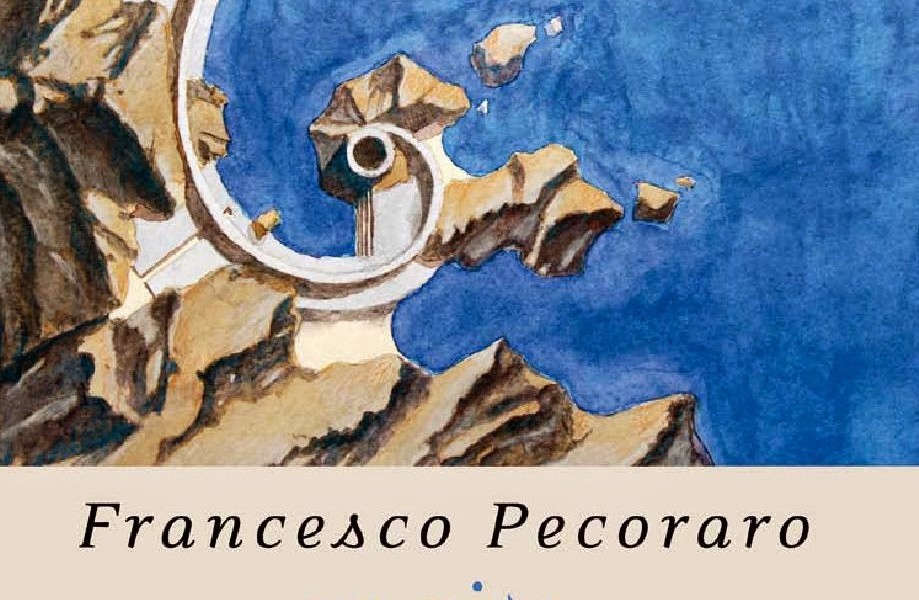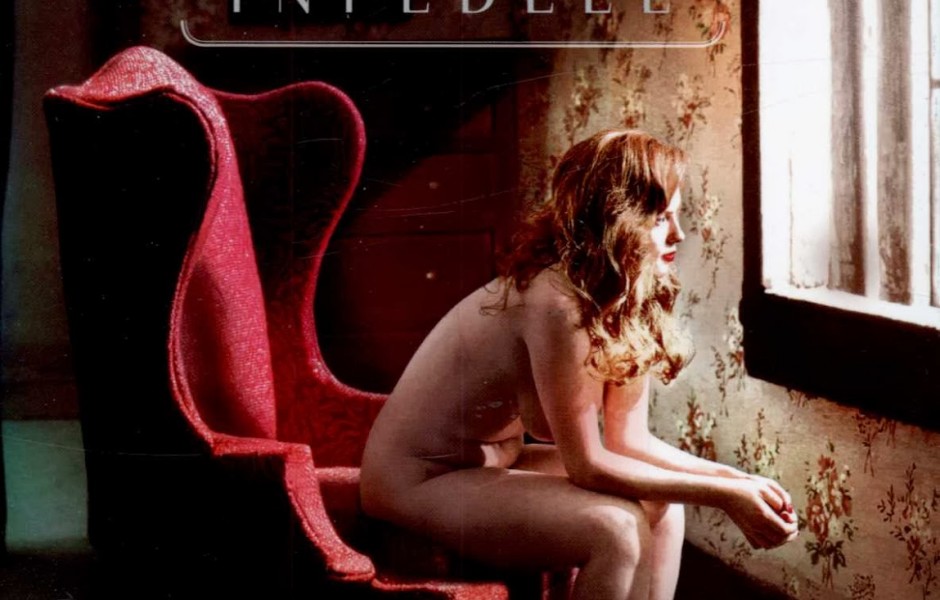Sono mesi che giriamo. Tra sapienti colonie di siti. Villaggi di parole recintati dentro un titolo, lastricati di storie da vendere. Perché è vero, le case editrici si raccontano soprattutto attraverso i testi che scelgono, folgorazioni trasversali per vicende e scritture. Incontri senza uscita sfociati in matrimonio.
Ma oltre all’insieme dei suoi libri, un editore si narra attraverso le sue origini, l’ossatura degli inizi, i nervi delle strade che hanno soffiato il giusto impulso, la profusione di volti e di idee scivolate nel sangue di un preciso progetto. Conoscere come non disseta soltanto un interesse pettegolo, ma consente di capire perché, di costruire un’immagine tutt’altro che epidermica. E non sempre accade di sapere facilmente.
Il caso di e/o, la realtà editoriale di questo mese, fortunatamente, sa dirla lunga. Almeno quanto la sua nascita, quanto i ricami di aneddoti e tappe che hanno istoriato la sua crescita. Quanto una linfa che sa nutrire e nutrirsi di un intorno mai scontato.
Quanto un sito che non sorvola e non nasconde nulla, ma s’impegna a condividere.
L’avventura parte da lontano, nel 1979 a Roma, figlia coraggiosa di una coppia di coniugi, Sandro Ferri e Sandra Ozzola, intenzionata a «creare ponti e aperture nelle frontiere letterarie per stimolare il dialogo tra le diverse culture». E i ponti spesso servono a non lasciare sole zone scomode, dove è facile pascolare tra gli spigoli. Il primo altrove con cui i due fondatori entrano in contatto è l’Est dell’Europa, «teatro da secoli dei giochi tragici e grotteschi della Storia». Terre arroventate, da troppa guerra fredda, da cortine di buio che a quel tempo si ha paura di toccare, anche con gli occhi di una trama. E così, esattamente come il suo popolo, anche le sue letterature all’epoca restano esiliate, tenute a debita distanza, vittime di ostracismo, strumentalizzazioni o abbondante indifferenza.
Aprire un varco diventa vitale, ossigenare pensieri e visioni con un confronto autentico. E finalmente arrivano i nomi giusti, quelli necessari: Milan Kundera che ha diretto la Collana praghese, Bohumil Hrabal, Christa Wolf, Kazimierz Brandys, Christoph Hein. Una schiera di voci pungenti, pronte a testimoniare un quotidiano difficile, uno spazio asfissiante, una finestra su un immenso lottato spicchio di mondo.
«La nostra era una scommessa allegra, ingenua forse, ma anche molto seria, che ci avrebbe portato soddisfazioni […] ma pure fatica, bocconi amari, ostilità. Una scommessa basata su un’intuizione: all’Est, oltre le frontiere; ben controllate, dietro i vuoti discorsi della propaganda comunista, dietro quelli meno colpevoli ma altrettanto fuorvianti degli ideologi dell’anticomunismo che diagnosticavano la desertificazione culturale e umana dell’Europa orientale, dietro a tutto questo c’erano donne e uomini che continuavano a vivere, a leggere, a scrivere, a fare e vedere film, a discutere, a protestare, anche ad amare e divertirsi». I primi volumi pubblicati ne sono la riprova: una monografia di Andrzej Wajda, un romanzo politico di Victor Serge (Memorie di un rivoluzionario) e i racconti di viaggio di Jan Potocki.
Correlare, annettere, offrire corpo alle alternative, come dichiara senza timore la sua identità anagrafica, quella di una doppia congiunzione. Anche e oppure. «Erano i nostri viaggi e soggiorni a Est ad alimentare questa intuizione e a fornire continue verifiche, prima ancora delle letture e prima ancora dei consigli, delle lunghe discussioni con i nostri consulenti. Viaggi e soggiorni, incontri, amicizie, un legame piccolo ma concreto che si creava tra noi (Ovest) e loro (Est), e faceva crescere in noi un senso di disponibilità a favorire il dialogo, a far conoscere l’Est, a superare l’indifferenza del pubblico e della stampa italiani».
L’attenzione si dirige poi in America, “importando” firme come quelle di Thomas Pynchon e Alice Munro; nell’ Africa di Chinua Achebe e Abasse Ndione, padri di dimensioni narrative totalmente sconosciute e infine nell’area prossima di un genere nuovo, quella del Noir mediterraneo di Jean-Claude Izzo e Massimo Carlotto. Creare e incentivare un catalogo plurale, “mulatto”, denso di incroci e punti di snodo.
Sandro Ferri, autore del pamphlet I ferri dell’editore, ha le idee molto nitide: «È nel nostro DNA di lettori alternare generi diversi di letture. Non crediamo quindi alle parrocchie dei puristi della letteratura così come non faremo mai un’editoria esclusivamente popolare».
Ecco quindi, nelle sue collane principali, come si articola il catalogo:
– Assolo, graffi di narrativa, «testi di autori italiani e stranieri che scrivono per incidere nella realtà», tra cui Christa Wolf e Eric-Emmanuel Schmitt
– Bill-Dung-Sroman, dedicata alle trasformazioni sociali della contemporaneità, all’adolescenza e alle sue dilatazioni.
– Collana Praghese
– Dal Mondo, echi da ogni angolo, con autori tra cui Svetlana Aleksievic, Gioconda Belli, Pedro Juan Gutiérrez, Etgar Keret, Yasmina Khadra, Selim Nassib, Joyce Carol Oates e Juan Manuel de Prada
– Gli Intramontabili, riproposizione di titoli ancora importanti come L’uomo di fiducia di Herman Melville
– Il Baleno, riservata ai più piccoli, tra cui segnaliamo Due che si amano di Wolf Erlbruch e Jürg Schubinger e Papà di Svein Nyhus
– Sabot-Age, storie spinose da raccontare, come Trinacria Park di Massimo Maugeri e Undercover di Roberto Riccardi
– Sharq Gharb, zona di contatto tra Europa e universo arabo, con opere italiane tradotte in lingua araba, come Io e te di Niccolò Ammaniti e Un borghese piccolo piccolo di Vincenzo Cerami
– Thriller e/o, fiction del crimine attenta al sociale, in cui campeggiano Jefferson Parker e Deon Meyer.
Affacciarci ai nostri prescelti a questo punto è quasi un obbligo, quello che preferiamo:
– Il minotauro di Benjamin Tammuz. Parabola d’amore assoluto. Un fendente che trapassa a distanza. Spy-story spietata e straordinaria.
– Di notte sotto il ponte di pietra di Leo Perutz. Ventaglio di racconti lirici nella Praga di fine Cinquecento tramati da un cantore della sua magia.
– Il sole dei morenti di Jean-Claude Izzo. La vita sul bordo di Rico, del suo cuore ingiallito, del suo fondo notturno. La nobiltà del dolore di chi abita il margine.
Queste sono solo tracce, suggestioni, indizi. Il resto non prevede esclusioni.