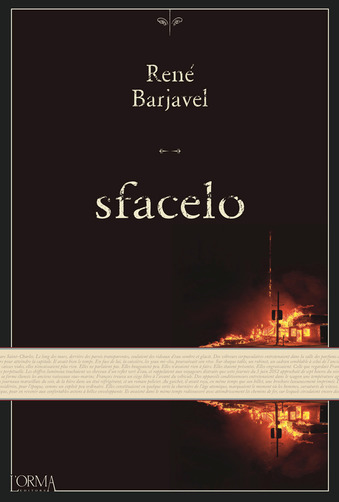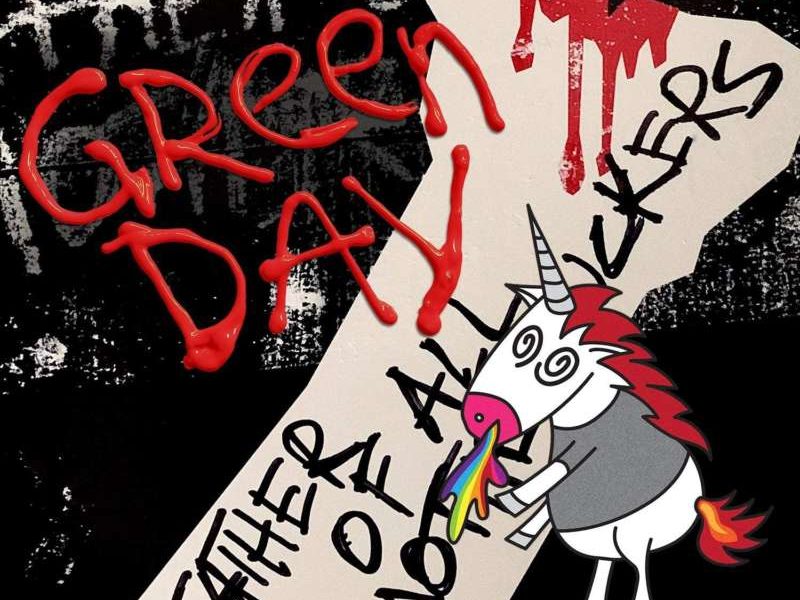Dal Matto al Mondo. Viaggio poetico nei tarocchi (Effequ, 2019), l’ultimo libro di Francesca Matteoni, si inserisce nella collana Saggi Pop e lo fa a buon titolo: si tratta di un testo esaustivo sul tema dei tarocchi caratterizzato da uno stile narrativo scandito da citazioni di testi, che aprono un mondo che va al di là delle carte abbracciando poesia, fiaba e molti altri universi.
Dal Matto al Mondo è un ottimo punto di partenza per avvicinarsi ai tarocchi: 22 capitoli dedicati ai 22 Arcani Maggiori, 4 dedicati a bastoni, coppe, spade e pentacoli e un ultimo capitolo dedicato a re e regine, fanti e paggi. Durante tutta la lettura Francesca Matteoni accompagna il lettore con delicatezza in questo mondo arcaico, avvolto da un fascino che resiste al tempo e alle superstizioni. Alla fine si posa il libro con la voglia di farsi leggere le carte o di imparare a leggerle. A me è anche venuta voglia di parlare ancora un po’ con Francesca di carte, di poesie, di Dante, del potere delle immagini. Se non avete ancora letto il libro, questo è un modo per cominciare a immergervi, oppure per continuare il viaggio.
Perché nascono i tarocchi?
Questa è una domanda complessa e senza risposta definitiva. Una storia diffusa nel Settecento francese grazie ad Antoine Court de Gebelin, esponente di spicco della massoneria, li vuole connessi a Thoth, dio egizio della scrittura, e li definisce un antico libro sapienziale composto di lamine o carte invece che di pagine. La teoria esoterica, seppure tarda, ha una sua ragione intima: di fatto possiamo leggere le immagini attraverso gli archetipi e la tradizione. In origine i tarocchi devono essere stati un gioco di carte nato nelle corti rinascimentali italiane. Certo, la presenza degli Arcani Maggiori ha un fascino che resiste al passare delle stagioni: in questo i tarocchi si comportano come tutte le opere d’arte, offrendosi a varie letture e interpretazioni.
Perché i tarocchi funzionano e resistono al tempo?
Perché hanno la forza e il mistero dell’immagine che precede la parola. Nonostante o in virtù della loro specificità, si possono adattare a contesti diversi. Per esempio, nei mazzi tradizionali abbiamo presenze come il Papa o gli Amanti che possono risultare rigidi, privi di senso, fuori dalla loro tradizione religiosa e culturale, addirittura stonati in un’epoca contemporanea di multiculturalismo, nuove spiritualità, visioni non più asfitticamente binarie dei generi e degli orientamenti. Ma lo sguardo non può fermarsi alla superficie e dietro il sembiante i tarocchi invitano a capire la funzione delle figure.
Allora il Papa diventa il Gerofante, colui che amministra il sacro attraverso la tradizione in cui cresciamo (e da cui ci affranchiamo). Gli Amanti sono la radice dell’amore, cioè la possibilità di riconoscere un altro fuori da sé e di compiere scelte di conseguenza. Ecco quindi che possono nascere mazzi dove trovare due oche canadesi che viaggiano insieme tutta la vita, invece di un uomo e una donna; possiamo avere un Gerofante femminile, arboreo, rappresentato come vecchio maestro o come sciamano ibrido fra bosco e animale.
È ciò di cui si fanno portatori che resiste, perché tutti noi abbiamo sperimentato, o sperimenteremo, l’amore, tutti abitiamo più o meno consapevolmente una tradizione. Funzionano grazie alla loro capacità di rinnovarsi sia in chi li legge che in chi li immagina, attingendo però a una stessa fonte di sentimenti ed esperienze diffuse del vivente.
In Dal Matto al Mondo parli dei tarocchi utilizzando tanta poesia, ma anche favole, saggi e altre fonti. Essendo i tarocchi qualcosa di iconografico, perché la scelta di ricorrere ad altri mezzi per esplicitarne il significato, e in cosa ti sono stati utili?
L’immagine è uno scrigno. È l’animale antico ed evanescente sul muro di una caverna preistorica. È il riflesso in una polla d’acqua dove qualcuno crederà di scorgere un altro universo fino a farne il suo sogno. L’immagine resta se stessa pur aprendosi a molteplici tradizioni, e per questo alle parole. Poiché arriva a noi senza istruzioni per l’uso ci permette un viaggio nella nostra storia e in quelle che ancora non conosciamo, che diviene la seconda vita del racconto. Tutto rimanda sempre a qualcosa d’altro, è così che si lega dentro di noi e che tende alla chiarezza.
Come puoi dire ad altri che una vecchia betulla sente, pensa, conosce e che magari tu l’hai amata, solo mostrandogliela? Molti non vedranno che un tronco bianco, interrotto da crepe scure di corteccia. È già una storia, certo, la più pura, quella che sopravvive nell’occhio e nel corpo, ma per farsi bene diffuso ha bisogno di un rito, di un’evocazione. Potrei dire che quella betulla è la Temperanza e a sua volta la Temperanza è la storia di un angelo compassionevole. Attraverso la storia dell’angelo compassionevole forse qualcuno risalirà fino alla betulla o magari, usando la sua persona, troverà un’altra creatura.
Bisogna partire dall’osservazione: osservo a lungo le carte perché esse si riallaccino ai miei strumenti familiari, quindi la poesia, le fiabe, il linguaggio con cui sono nata. Sono una che a due anni tormentava gli adulti con Cappuccetto Rosso e Buchettino; a sei inchiodai due maestre che sventuratamente mi avevano chiesto se conoscessi una poesia, con le otto poesie che sapevo a memoria. Una rompiscatole. I tarocchi mi ascoltano con pazienza e fluiscono in queste parole svelando altre vie, prendendomi di sorpresa insomma, perché come dei trickster di carta alla fine sono loro e non io a raccontare.
Una delle due citazioni iniziali è di Dante: «Lo duca e io per quel cammino ascoso / intrammo a ritornar nel chiaro mondo». Si tratta del momento in cui Dante e Virgilio risalgono dall’Inferno. Perché la scelta di questo pezzo?
L’ultimo degli Arcani Maggiori è il Mondo. È anche l’Arcano di partenza, se ci pensiamo: nasciamo nel mondo, ma ci vuole tempo per tornarci e riconoscerlo quale compagno. I tarocchi sono un’immersione dentro noi stessi proprio perché spingono e premono verso il fuori, aiutano ad attraversare l’ombra e a dismettere l’idea che la nostra interiorità sia il fine del pellegrinaggio. Il fine è ciò che sta fuori. Il fine è il corpo e le stelle che lo vegliano. Entrare nei tarocchi significa accettare che ogni cosa, perfino la più apparentemente quieta, può scatenare un tumulto. Significa sapere che l’ombra cammina con noi: è quanto non vediamo, quanto ci nascondiamo, ma anche una fedele verità che può rafforzarci. Le carte invitano a non temere l’inferno, insomma. Ma a ricordarci dov’è e che ci siamo stati molte volte – è per questo che vediamo la luce.
Attraverso le citazioni che utilizzi, il libro alla fine sembra quasi il prodotto di un lavoro coreutico, un libro sull’ascolto degli altri per dare una risposta. Applicando questo concetto ai tarocchi, siamo noi ad ascoltare le carte, o viceversa?
Forse ho già un po’ risposto. Siamo noi che ci convinciamo di dire una storia attraverso le carte e invece sono loro a illuminare i punti salienti della narrazione, a tirarne le fila. Si attivano nella nostra attenzione; una volta attivati azzerano l’io, appunto, lo conducono dove il groviglio dei pensieri e dei tormenti si allenta per farci passare. Per questo è utile ricordare che ogni carta non ha una storia sola e che talvolta alcune restano mute, perfino ostili, per lunghi periodi. A oggi ci sono Arcani sia Maggiori che Minori che hanno perso o acquistato nella loro intensità a seconda della vita che ho vissuto e di dove li ho riconosciuti negli anni.
All’inizio spieghi perché hai cominciato a leggere i tarocchi, l’ho trovata un’immagine molto dolce: «per rompere il disagio in certi ambienti dove non conoscevo nessuno». Sembra che le carte siano state per te un ponte d’incontro con l’altro. È forse questa la funzione ultima dei tarocchi? Unirci a qualcosa di sconosciuto?
O forse a qualcosa da cui siamo sempre talmente circondati da darlo per scontato. Hai presente tutte quelle fiabe in cui qualcuno deve superare cinque mari, dieci montagne, quindici giganti, indossare diverse paia di stivali delle sette leghe per trovare che la meta ultima era l’orto dietro casa sua? Ecco, va così, anche con le carte. Sull’usarle come ponte per gli altri, penso di poter aggiungere questo: non sono una persona timida, ma posso isolarmi molto senza sentire la mancanza di nessuno.
Il problema sta nel trasportare verso gli altri, scansando come la peste i facili giudizi, tutto quell’universo che ho sempre abitato e che per molti suona come un guazzabuglio di stramberie. Non è che puoi andare in giro facilmente a intavolare discussioni sugli spiriti, su quello che ti hanno detto i sogni, sulla betulla parlante, su orsi e caprioli che erano bambini e bambini che erano orsi e caprioli – tutto questo, se non ha un filtro, ti fa semplicemente passare per pazza.
Mi consolo dicendomi, con qualche mania di grandezza, che anche molti sciamani artici come antichi e moderni guaritori, sono solo dei pazzi, degli imbroglioni, dei marginali e da questo traggono la loro energia. Allora per veicolare ciò che più mi preme scelgo vari mezzi: le fiabe e il linguaggio diretto con i piccoli; i tarocchi con gli adulti. E sapessi quanti animisti insospettabili si manifestano!
Quando arriviamo alla carta della Forza, dici che forse è la tua carta preferita. Ce n’è una che temi e perché?
Sì, la Giustizia, una carta per cui nutro profondo rispetto. Rischia spesso di passare inosservata, proprio come accade alle cose più difficili. La Giustizia è oltre l’umano, perfino indifferente all’umano, non preannuncia una disfatta come la Torre né un cattivo maestro come il Diavolo o il Gerofante: lei esiste – imperscrutabile, ferma e rigorosa. Situazioni che, dal nostro limitato punto di vista, possono risultare ingiuste e dolorose, si rivelano in lei come un’estrema forma del giusto pre e post-umano. Pensa a quanto abbiamo fatto al pianeta che abitiamo e a come si sta ribellando.
Tanto di quello che accade è ingiusto: la morte degli innocenti (spesso i non umani, ma anche i popoli cosiddetti minoritari, marginalizzati dal sistema capitalista) è ingiusta, eppure è una diretta conseguenza delle azioni della minoranza caucasica e occidentale. A suo modo la Giustizia agisce, impone morte e rovina e non si ferma per raccattare nessuno, non dà spiegazioni. Lei è. Siamo noi a dover essere abbastanza maturi, abbastanza coraggiosi da capirne il messaggio e provare a riparare. È per me l’Arcano implacabile, il più equamente disumano. Se invece dovessi scegliere una carta che non amo per niente (ma non la temo), direi il Re di Coppe e lo dico anche nel libro: quell’adulatore losco e sentimentale.
Siamo all’inizio di un nuovo decennio, con che tarocco rappresenteresti il 2019 e quale carta auguri al 2020?
Il 2019 è stato l’anno in cui per chiunque non sia preda della solita modaiola grettezza è divenuto chiaro che il tempo è scaduto. Se vogliamo salvare il pianeta non si può più rimandare. Questo mentre imperversano minacce di guerre, sovranisti di ogni sorta, piccoli e grandi egoismi, l’incapacità di curarsi perfino degli immediati dintorni. È stato l’anno del Giudizio, senza dubbio. Prendo di questa carta l’aspetto vigoroso di risveglio, di apertura delle tombe, di vocazione. L’anno della chiamata, tenendo a mente che i veri morti non sono i defunti, ma i ciechi.
Perché questa chiamata sia efficace, perché movimenti come Extinction Rebellion o i ragazzi di Fridays For Future trovino sponda fino a costringere la maggioranza della classe politica a divenire responsabile, occorrono saperi, immaginazione, forza creativa, tenacia. Mi immagino quindi una piccola stesa augurale a carte scoperte: si inizia con l’Imperatrice, ovvero madre terra stessa, madre fantasia e cura; si cerca guida nella Stella fissa, la speranza che fa sgorgare l’acqua dalla pietra; si mette in pratica ogni arte con dedizione nell’Otto di Pentacoli mentre con l’Otto di Coppe si cambia strada senza rimpianto.
Infine si evoca la volontà dell’Imperatore, la sua autorevolezza politica per strutture sostenibili che non escludano nessuno. Ho scelto cinque carte, cinque il numero della crisi (anche del Gerofante, ma questo ce lo teniamo per un’altra volta); e il numero del cammino a metà. Forse siamo alla fine di un’epoca e di molte nocive illusioni – ma non siamo finiti. Coraggio.
(Francesca Matteoni, Dal Matto al Mondo. Viaggio poetico nei tarocchi, Effequ, 2019, 320 pp., euro 15, intervista di Giulia Fuisanto)