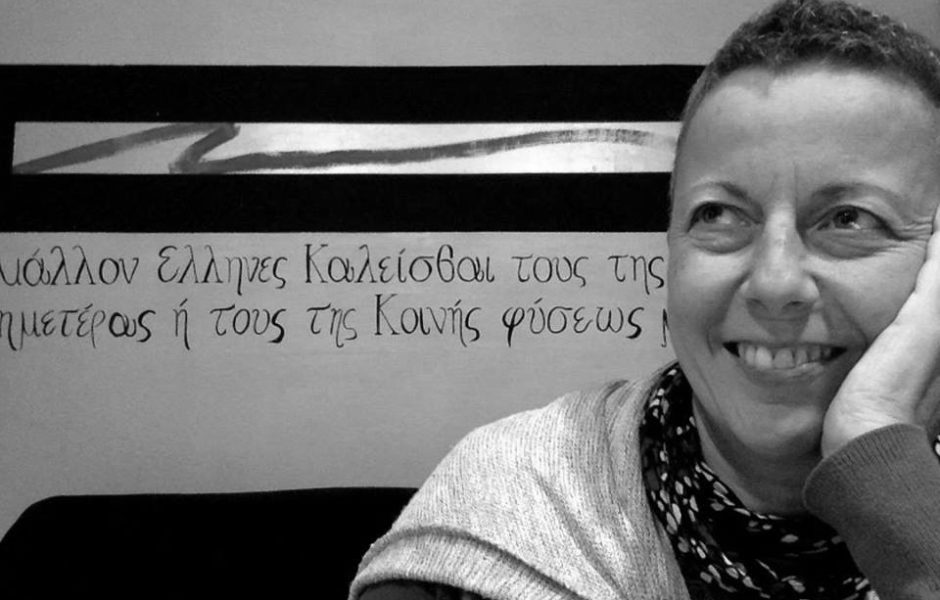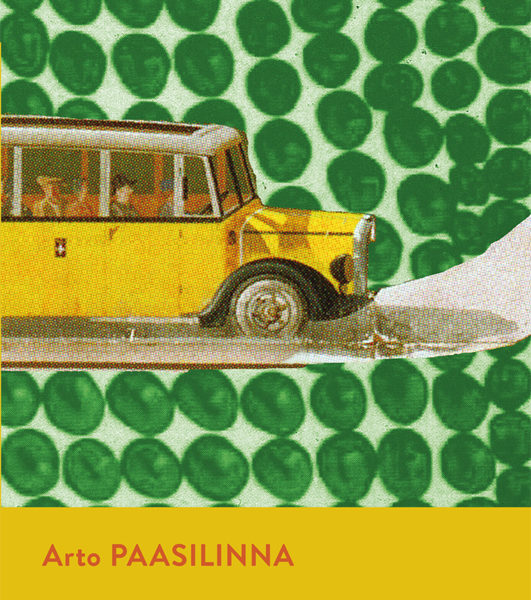Se «è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo» come afferma Mark Fisher nel piccolo pamphlet Realismo capitalista, prenderei per buona anche la visione del nuovo: una realtà bifronte che risponde al vecchio mentre questo cerca di riconfigurarsi. Più complesso è raccontare la fine del mondo dall’intero, pienamente consapevoli e immersi nelle regole del capitalismo fino a diventarne un ingranaggio.
È il caso dei tre protagonisti di La festa nera di Violetta Bellocchio, secondo atto della collana Altrove di Chiarelettere dedicata alle narrazioni che indagano il futuro. Prima che la loro fama si trasformasse nella parabola preferita di hater e troll Ali (la voce narrante del romanzo), Misha (una youtuber volto e voce del progetto) e Nicola (il cameraman compagno di Misha) realizzavano video dove andavano a caccia della stranezza, dello scandalo e del facile commento a vicende incredibili e particolari. A distanza di qualche mese dal video che ha scatenato l’odio del web, i tre decidono di fare un tentativo per recuperare la fama perduta: partono per le terre desolate da epidemie e carestie della Val Trebbia per realizzare un documentario sulle comunità che vi dimorano.
È facile individuare i tre protagonisti all’interno di un meccanismo perfettamente rodato che va dalla creazione di una novità feticcio con uno sguardo al passato – per cui il mezzo audiovisivo perde connotati della poetica implicita e diventa una rappresentazione apodittica – fino all’apice e al declino insiti nel funzionamento stesso del nuovo. E, infine, il successivo ritorno, la riconfigurazione in funzione delle esigenze del mercato: l’ossessione per le storie, poco importanti per l’approfondimento dei contenuti, che vanno alla ricerca dello «shock facile, la ferita di superficie, l’applauso casuale di un pubblico privo di qualsiasi gusto o sensibilità».
Siamo nel 2026 e c’è stata la fine del mondo che, invece di catastrofi ambientali, ha portato solo alla consapevolezza di vivere già «in mezzo alle macerie», dove il perdere tutto diventa una disperata rincorsa alla vendibilità della propria storia. Tra Ali, Misha e Nicola si stabilisce quel legame che fa della convenienza la base della socialità: nelle loro azioni non si riconosce un vero talento o una vera passione, sono individualità disperate alla ricerca di facili sentimentalismi. Alla fine del mondo sopravvive una dualità obbligata: chi sviluppa l’arte del cinismo e chi quella dell’oblio.
«Noi facciamo documentari. Filmiamo il reale in tempo presente. La nostra specialità è tutto quanto sta all’incrocio tra lo strano, il triste e l’oscuro. Andiamo a cercare le vite delle persone diverse da noi, le vite di quelli che fanno cose squallide, bizzarre antisociali e degradanti, ma in fondo anche curiosamente umane, no?»
Reale e presente non sono la stessa cosa. Perché la realtà, persino “dal vivo”, non è mai neutrale e apparterrà sempre a chi guarda. Qui il medium non è il messaggio – perché la riproduzione della realtà non è legata solo alle possibilità tecniche come estensione del corpo umano –, il medium è una mutazione che ha le sue profonde origini nella consapevolezza di essere guardato. Da qui spiegata l’ossessione per le immagini insieme alla loro preparazione («Le immagini hanno tutto il potere. Niente voce fuori campo all’inizio. Punta la telecamera su una persona, non ti muovere, e stai tranquillo che presto o tardi ti racconta cose che non avrebbe pensato mai di dire a voce alta»). Le immagini diventano un simulacro molto vicino alla parabola di una fenice: dalle ceneri di un’immagine distrutta (come quella di Misha umiliata dal popolo del web) si potrà sempre rinascere costruendone una nuova, facendo leva sulla celerità del consumo, sulla dimenticanza e sulla creazione di una nuova confezione che risponda al gusto prevalente. Ma di chi?
La realtà di La festa nera ha la distopia della provincia italiana e l’andamento di un canale YouTube: comunità estremiste che condividono una visione e creano la coda lunga di seguaci. Società-stato con leggi interne stabilite dalla collettività: la libertà o la sua simulazione passa per l’utopia democratica e l’approvazione della maggioranza. C’è la setta dei misogini che ha regolamentato l’odio per la donna, ci sono quelli che rinunciano alla tecnologia, ci sono gli adoratori del dolore perché è «l’unica cosa vera che ci è rimasta».
Un narratore dell’attualità che inserisce continui riferimenti e rimandi alla cultura pop rischia di diventare quello che Wallace ha eloquentemente definito «scrittore guardone» in E Unibus Pluram. Gli scrittori americani e la televisione. «La televisione è diventata capace di inglobare e neutralizzare ogni tentativo di cambiamento o anche di denuncia degli atteggiamenti di passività e di cinismo che la televisione stessa richiede dal Pubblico per poter essere commercialmente e psicologicamente efficace in dosi di parecchie ore al giorno» è chiaro che il saggio di Wallace deve essere letto nell’ottica del tempo in cui è stato scritto, tuttavia, condivide alcuni aspetti comuni col clima di sagace cinismo e di superiorità ai fenomeni popolari del web: un organismo che si autoalimenta continuamente per cui i fatti passano sotto lenti di populismo, scetticismo, passività, aggressività generano a loro volta altrettanti contenuti. Il discorso comunicativo ha raggiunto un nuovo livello di complessità e per questo chi intende scriverne rischia di rappresentare la realtà invece di creare una visione alternativa.
Nel caso della Bellocchio l’appiattimento critico non sussiste. Lo stile si muove tra la velocità di un piano sequenza, l’instabilità del pensiero multitasking, che avvicina il romanzo a un hard-boiled, e lo sforzo immaginifico che elimina la caduta nello sterile commento al mondo dei social network. L’accostamento di battute di film e strofe di canzoni mormorate nella desolazione della fine del mondo crea una sorta di nuova lingua che fa della cultura popolare l’unico baluardo a cui aggrapparsi pe il culto della personalità. È come se l’osservazione ironica fosse andata oltre la ribellione del postmoderno: il processo di «precorporazione» a cui si riferisce Fisher ingloba il «potenziale sovversivo» nel capitalismo in modo da perdere ogni valenza critica o estraneità alla cultura dominante. Il sovversivo nel capitalismo è quasi fisiologico. Eppure, a uno sguardo attento, il romanzo della Bellocchio non vuole porsi nell’ottica della singolarità rivoluzionaria, vuole invece suggerire un’evoluzione in divenire: persino in un mondo dove tutto è ormai perduto i valori futili, delle semplici conseguenze esclusivamente interne al mondo del web, si sono invece diffusi fino a prevalere, fino a regolare la socialità.
Il ritmo sincopato e imprevedibile della voce narrante di Ali è la perfetta rappresentazione della trasformazione in atto: l’adesione incerta all’equazione vita e presenza online, l’importanza dell’immagine, il consumismo delle idee usa e getta («Hai fatto tutto tu, hai fatto quello che volevamo. adesso non ci servi più. Adesso puoi andare»), la priorità di una storia da raccontare per rimanere leggenda e, forse, illudersi di sorvolare tutti i meccanismi di cui si è vittime.