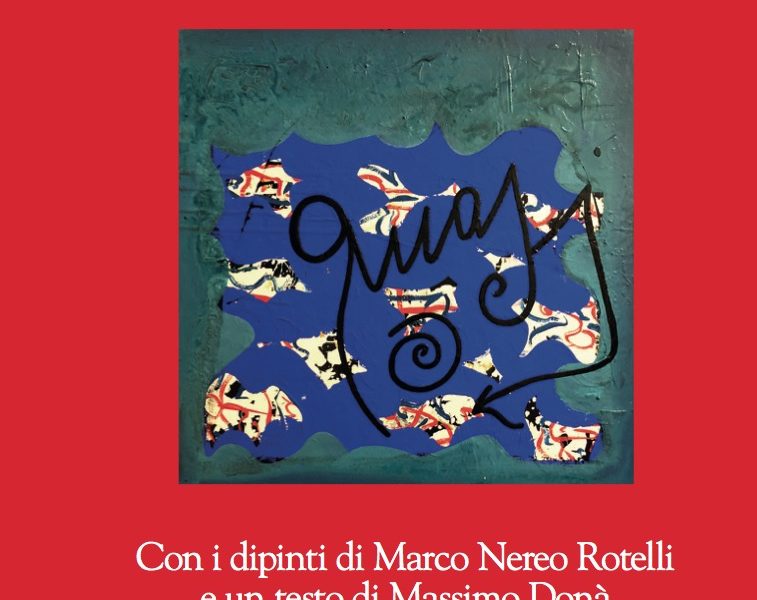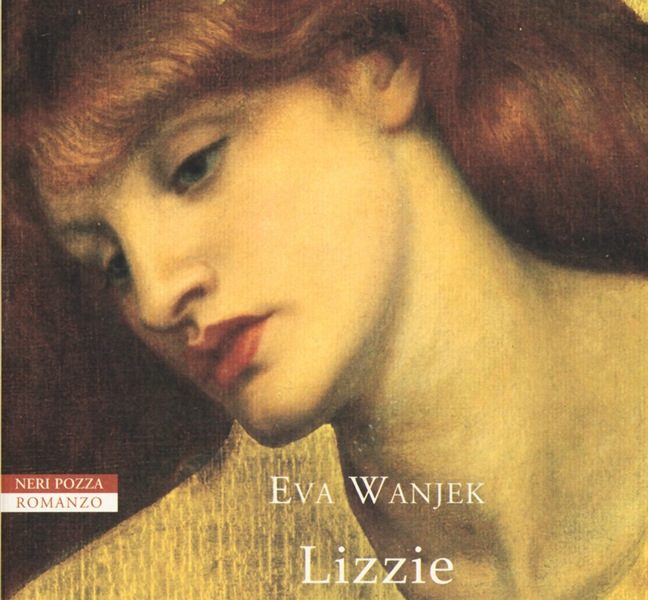Qual è la nostra parte migliore? Come si esprime? Quando riusciamo a esprimerla? E, non da ultimo, siamo proprio sicuri che quella cui pensiamo sia proprio la nostra parte migliore?
Due donne sono una famiglia. Leda, la madre, è una psicologa, una donna forte che lavora con i malati terminali. Laura, sua figlia, è un’adolescente come tanti, scuola, amici, tormenti giovanili, ribellioni acerbe; è intelligente, Laura, ha la passione per la poesia. A incrinare il loro equilibrio è una gravidanza indesiderata: un rapporto occasionale con un coetaneo dopo una serata di festa e Laura rimane incinta. Attorno alla crisi del loro rapporto, attorno al rapporto tra la vita che nasce e la vita che muore, si sviluppa la trama di La parte migliore (Einaudi, 2018), l’ultimo romanzo di Christian Raimo, scrittore, giornalista, editor e politico, attivo da anni sulla scena romana e non solo.
Giuseppe e Riccardo sono le figure maschili. Figure quasi evanescenti, poste a margine della storia, che però premono per tornare a incidere, a contare nell’universo femminile. Giuseppe è il padre di Laura, l’ex marito di Leda: chiamato casualmente in Questura per tirare fuori dai guai sua figlia, cercherà di ricostruire un rapporto con Laura, non tanto di colmare un vuoto scavato negli anni, quanto per seguire l’urgenza di spiegare quel vuoto. Riccardo è il compagno di Leda; lui, reclamando più spazio per la loro vita di coppia, ha il ruolo indisponente del paternalista, del “buonista” a tutti i costi.
Ma altri due personaggi, trascendenti quanto immanenti, arricchiscono la storia. Adriano, figlio di Leda e Giuseppe, morto a cinque in un misterioso incidente e causa diretta della loro separazione, è una presenza stabile nella vita della donna, una sorta di confidente immaginario, uno specchio. E poi infine c’è Roma, non la Roma della Grande bellezza o della Banda della Magliana che in questi anni si è imposta al nostro immaginario, ma la Roma dei quartieri periferici, grigia, quotidiana, la città del parcheggio selvaggio, del pizzicagnolo e del kebabbaro, degli allagamenti e degli autobus che non arrivano mai; una sorta di personaggio che s’impone come scenario imprescindibile, reale.
Questi i principali ingredienti che Raimo intavola per il lettore, in un romanzo che rivela l’intento di porre dubbi, continue domande più che risposte, sulla vita e la morte, sul rapporto contemporaneo tra il mondo femminile e quello maschile, sulla relazione complessa tra generazioni in una società che subisce mutamenti a una velocità mai così rapida. La parte migliore è un romanzo che non colpisce in modo diretto allo stomaco, punta alla mente, è un testo che vuole e che sa far riflettere; soltanto poi torna alla pancia, smuove all’emotività. Ed è una ricetta genuina, quella elaborata da Raimo, come le pietanze fondative, tradizionali che si preparano pazientemente con materie prime semplici alle feste comandate: quei sapori che accompagnano i momenti importanti della nostra vita in famiglia, che costruiscono una parte decisiva della nostra identità, che plasmano le nostre capacità relazionali.
Di come si prepara tale pietanza, di come si amalgamano tanti ingredienti diversi, verso quale esperienza di gusto vuole condurci il romanzo, ne abbiamo discusso al telefono con l’autore.
La parte migliore è, in apparenza, un romanzo semplice, lineare ma che al suo interno tocca invece molti temi, mette a confronto emotività diverse, nonché generazioni, personaggi eterogenei; quando hai iniziato a scriverlo qual era la tua principale urgenza?
Guarda, l’idea fondamentale era di esplorare un tema che negli anni aveva occupato una parte importante della mia riflessione, quello del tempo che sta prima e dopo la vita. E questo sia per ragioni personali, famigliari, sia perché mi continuavo a struggere nel riconoscere un dibattito pubblico che invece spesso è molto polarizzato. Io faccio parte di una generazione che riflette molto sull’idea di fare figli, molti dei miei amici non hanno figli, io non ho figli, e al contempo abbiamo genitori anziani, a volte da accudire, quindi i temi dell’aborto e dell’eutanasia sono cose su cui riflettiamo, ma purtroppo sembrano diventare argomenti da chiacchiera politica. A me è capitato di riflettere molto su questi temi nel periodo in cui mio padre stava male, in ospedale, poi è morto, ed erano gli stessi giorni in cui si discuteva di Eluana Englaro in tv. Mi sembrava che quel modo di discutere, della Englaro, del caso Welby, fossero una forma riduttiva e sciatta di pensare alla condizione umana oggi. Ho pensato quindi di esplorare questi grandi interrogativi attraverso un romanzo per dargli una “polifonia”, per dirla alla Bachtin, in modo da non ridurre questioni tali a temi da sondaggio, da dibattito politico, nel migliore dei casi, ma provando a incarnarlo con degli stati d’animo, con delle situazione personali, con i punti di vista di un prisma fatto di visioni diverse, che poi è quello che accadde alle persone. Mi sembrava giusto occuparmi di cose così grandi restituendo la pluralità e la complessità delle scelte personali. Ci tenevo moltissimo. Le persone spesso sono incagliate in determinazioni sociali, in rappresentazioni, schieramenti, mentre la letteratura è invece lo spazio della libertà, è lo spazio che ci fa da educazione etica. I romanzi ci pongono di fronte a una pluralità di azioni possibili, morali, che determinano poi le nostre emozioni e quindi le nostre scelte.
Le protagoniste Leda e Laura si trovano a confrontarsi, l’una per un verso l’una per l’altro, con la nascita e la morte ed è come se fossero chiamate dagli eventi a essere posseditrici di una risposta se non definitiva, almeno rapida, efficace. Si sta riducendo a una performance il nostro rapporto con la vita?
Penso di sì. In fondo, io prendo una famiglia composta da due donne, una madre e una figlia, poi c’è un padre ma lontano e c’è la figura di questo ragazzino morto in un incidente, all’inizio, non si sa perché. Questa famiglia è cresciuta cercando di superare questo lutto. L’ha fatto in un modo progressista, intelligente, laico. Sia Leda che Laura non sono due personaggi squilibrati, non sono fragili, nella mia idea sono due persone che sanno affrontare bene la morte. Al momento però in cui devo avere a che fare con un problema apparentemente più semplice rispetto al trauma della morte di un bambino, quello, appunto, di una gravidanza indesiderata, sembrano andare nel pallone. Questo per me ha a che fare – ma forse è una mia idea – con una vocazione che noi, come civiltà, abbiamo: cioè il pensare di esserci attrezzati di più nei confronti della morte. Progressivamente le malattie si cronicizzano, i lutti perdono la loro dimensione di mistero e adottiamo pratiche sociali riconoscibili per affrontare la morte. Queste cose per me sono sconvolgenti, superano la mia comprensione umana. Io invece penso che oggi non ci sia una buona educazione alla morte e affrontarla passa attraverso una sorta d’insipienza. Cioè abbiamo una possibilità sempre più ampia di avere a che fare con ciò che riguarda la cronicizzazione della malattia, della vecchiaia, abbiamo delle capacità operative migliori rispetto alla questione della morte, ma al contempo ci formiamo in una cultura che non ha al centro la morte, l’interrogazione sulla morte, che invece è il cuore della civiltà umana. Penso alle cose che scriveva Philippe Ariès o Michel Vovelle, o anche Jankélévitch, Atul Gawande. Di fatto, il tragico oggi è osceno, è fuori dalla scena. Io, in questo libro, ho voluto invece che il tragico entrasse in scena, soltanto così è possibile avere una catarsi, una forma di rielaborazione che porti poi anche a una riflessione sulla condizione umana. Ho voluto provare a rovesciare questa sensazione. In questi anni siamo stati abituati agli attenti in diretta, ai filmati dell’Isis, ai lutti su Facebook, abbiamo aumentato la narrazione delle tragedie, questo però non ha accresciuto una sapienza sulla morte; cosa che per me invece è fondamentale. Rovesciando il piano narrativo ho provato a far sì che un evento meno irrimediabile, come appunto una gravidanza indesiderata, potesse portare a una riflessione più profonda. La vera domanda è: cosa c’è oltre la vita? Da dove vengono i nati e dove vanno le persone quando muoiono?
Papa Francesco di recente ha dichiarato che abortire è «come affittare un sicario». Nei giorni scorsi invece, a Verona, il Consiglio Comunale ha approvato quasi all’unanimità una mozione contro l’aborto. Tu, da cattolico e uomo impegnato in politica, come interpreti questi segnali?
Credo che si discuta di questa questione come si fosse una tifoseria. Io sono convinto che il femminismo, ma anche il cattolicesimo in realtà, condividano una prospettiva: quella di parlare di questioni politiche, cioè di questioni che riguardano tutti, a partire da sé. Io che mi ritengo cattolico e femminista al tempo stesso penso che non si possa ridurre un dibattito del genere a qualcosa di astratto. C’è stato un referendum importante e penso che questi tentativi di ridurre la dottrina cattolica a espressione di una morale tradizionale siano sbagliati. Siamo la prima generazione a non fare più figli. Il vero, nuovo problema è la questione del generare.
Molto spesso si individua la causa nell’individualismo…
Io penso che qualunque spiegazione, la crisi sociale, la mancanza di strutture sociali adeguate, oppure il narcisismo, il prolungamento della vita, la realizzazione delle donne in ambito professionale, non riesca a esaudire la domanda. Sono tutte cose sensate, ma per me sono anche false piste. Le più grandi narrazioni distopiche di questi ultimi anni pongono questo come tema: prendi il film I figli degli uomini di Alfonso Cuarón. Cosa ne facciamo di un mondo in cui non nascono figli? D’altra parte siamo chiamati a scegliere su questa cosa. È una scelta molto strana, per certi versi è contro la condizione umana. Per me ha un che d’inquietante. Ridurre la riflessione sull’aborto, sull’eutanasia, anche attraverso simili esposizioni da parte del Papa, a una diatriba di cattolici contro anticattolici è una cosa che toglie mistero perfino all’interrogazione che mi posso fare da persona credente. Non è più una questione politica per me. L’eutanasia, il testamento biologico, possiamo fare leggi per ogni situazione. Per me la questione è più grave. Cioè, e se veramente Dio non c’è? E se quel grido che fece Welby dal letto di ospedale non lo ascolta nessuno? E anche qui la domanda che mi viene è più ampia: e se davvero stessimo cominciando a far parte di una generazione che non avrà più figli? Se l’umanità intera decidesse di non fare più figli, di autoestinguersi? Questa mi sembra una domanda più vertiginosa. A me interessa questo piano, un piano vertiginoso.
La parte migliore mi è sembrato, anche grazie all’ottimo uso che fai della lingua, una sorta di mappa emotiva e razionale che tenta di orientare il lettore nel complesso rapporto tra la nostra generazione e quella dei “nostri figli”, i millennials. Spesso si parla di incomunicabilità intergenerazionale. Da uomo e professore come vedi, come vivi questo rapporto?
Io vorrei raccontare i ragazzi attraverso il loro linguaggio, dandogli la parola, credo sia il minimo che si possa fare. Hanno diritto a ottenere la parola, hanno diritto al fatto che gli adulti lascino loro la parola. Questo però non accade. Ho scritto un pezzo qualche mese fa su quello che chiamavo “un backlash paternalista”, cioè su una serie di libri usciti quest’anno che raccontano le generazioni, il rapporto tra generazioni, la scuola, a partire però dalla visione da sessantenni, settantenni, benestanti, ricchi, buona famiglia, eterosessuali, che in qualche modo pensano di raccontare la crisi dei giovani. Mettevo nel calderone Cazzullo, Polito, Floris, Battista, Crepet, Galimberti. Io penso che questo sia la cosa peggiore che possa accadere nel rapporto tra generazioni, cioè un affetto paternalista. Il paternalismo non è altro che pensare di sapere quali siano i desideri di qualcun altro o quale sia il bene per lui. In questo libro penso di aver cercato di raccontare il disastro etico e perfino estetico del paternalismo. E l’unico modo per farlo, secondo me, è rovesciando il tavolo, dando la parola direttamente ai ragazzi, che a questo punto facciano pure piazza pulita di qualunque visione che il mondo degli adulti fa su di loro. Quando ascolto Galimberti o leggo un suo libro che dice che i ragazzi di oggi sono tutti nichilisti, ecco, mi viene voglia di parlare con Quentin40.
La Roma, desueta, marginale, profondamente reale, che accoglie la trama del tuo romanzo è un personaggio a tutti gli effetti, hai dichiarato in un’altra intervista. Ma questa “tua Roma” cosa incarna? È metafora della società italiana? Di che cosa vuole parlarci?
Io non sono mai vissuto più di 15-20 giorni consecutivi fuori da Roma. Con Roma ho un rapporto edipico, ed è una realtà che conosco. In questo romanzo ho provato a raccontare due cose che conosco bene, ossia la fragilità del maschile e la mia città, e due cose che volevo andare a esplorare, ossia la complessità del mondo femminile e il mondo giovanile, due realtà diverse da me. Io non sono uno che scrive di viaggi, difficilmente potrei ambientare un romanzo nella Roma antica o in Svezia, perché non sono uno che riesce ad andare nei posti e a interpretarli in maniera immaginifica. Riesco invece a pensare di poter andare in mondi inesplorati che però mi sono molto vicini, per esempio quello femminile o quello di un’altra generazione. Roma a me entusiasma e non piace. Roma è una città che diventa subito museo, cartolina, un simbolo in mano agli scrittori. Negli ultimi anni, appunto, si è lasciato che la Roma periferica diventasse la Roma pasoliniana, oppure la Roma di Moretti, di Verdone, di De Cataldo; non appena c’è uno scrittore che riesce a trovare un’immagine di Roma ecco che subito quell’immagine si stereotipizza, diventa quasi vecchia. E Roma viceversa non ha un immaginario legato alla fantascienza, o un immaginario legato a qualcosa che non si museifica e resta plastico. E allora a me piaceva raccontare una Roma che non fosse estetizzante, che non fosse un fermo immagine. M’interessava una Roma plastica, una Roma ordinaria, una Roma che assomiglia a tante altre città del mondo, potrebbe essere Mumbai, Il Cairo, ma anche Madrid, Città del Messico, cioè una Roma informale, indifferente, non la Roma che una volta è stata l’Impero, una volta è stata Repubblica, la Roma del Palazzo. E questa cosa, secondo me, Roma ce l’ha perché è una città in cui si vive difficilmente e si sopravvive facilmente.
La passione di Laura è comporre sonetti. Sonetti privati, impregnati di dolore, rabbia, dubbi. Cosa rappresenta per lei la poesia? Cosa nella logica di La parte migliore? Quale spazio ha la poesia nella vita così social dei giovani d’oggi?
Per me la poesia è il luogo dell’ambivalenza. Oggi abbiamo una letteratura piena di esplicitezza, penso per esempio al grandissimo successo del noir, dei romanzi di denuncia, dei romanzi di non fiction. Per me sono l’annullamento di una delle grandi prerogative che ha la letteratura, cioè essere un grande inno all’ambivalenza. Noi siamo immersi in una produzione che continuamente sa quale effetto emotivo vuole produrre. Le serie tv sono fatte apposta per produrre certi effetti nello spettatore. Quindi, diciamo, noi siamo abituati a un consumo narrativo. La poesia questa cosa la impedisce perché, di fatto, lascia uno spazio di libertà totale all’interpretazione del lettore, rompe quell’idea merceologica della letteratura, quella categorizzazione che troviamo per esempio su Netflix, dove sono presenti narrazioni “per fare una serata tra amici”, “per ridere”, “per commuoversi”: ti è piaciuto quello e allora puoi vedere quest’altro. Fare questo con la poesia sarebbe insensato. Ti è piaciuto Paul Celan che parla della morte e allora forse devo leggere Grünbein che parla della malattia? Come facciamo a catalogare quella roba lì? E quindi questo spazio di ambivalenza, di assoluta apertura all’interpretazione personale, e anche di una relazione vera in un territorio che viene costruito insieme, questa è la cosa che mi interessa della poesia. Poi sono d’accordo con il personaggio la Laura che a un certo punto dice «dalle elementari fino all’ultimo anno del liceo noi leggiamo tantissima poesia, ci formiamo come esseri umani attraverso la poesia e dopo, finita la scuola, la cosa non esiste più». Di fatto, se tu chiedi a delle persone che scrivono, a degli intellettuali, quale libro di poesia italiana recente hanno letto, non ti sanno citare un poeta italiano vivente, spesso. E questo per me è un grande buco, è un grande problema, perché credo che la poesia sia lo spazio centrale di una relazione dell’intimità.
È uno spazio centrale, anche nella logica di La parte migliore, nella costruzione dell’identità e quindi della libertà.
Sì, esatto. Cioè, come dire, per me il romanzo umilia la libertà dell’uomo. E la libertà passa, appunto, dalla possibilità dell’interpretazione, di emozione che noi diamo alla letteratura. Come diceva Nabokov – adesso sono uscite le sue meravigliose Lezioni di letteratura –, a proposito del messaggio contenuto nei romanzi: «Se avessi voluto mandare un messaggio, avrei fatto il postino», non scrivevo un romanzo. Ecco per me l’idea che la letteratura si possa ridurre all’espressione di un messaggio è il male assoluto.