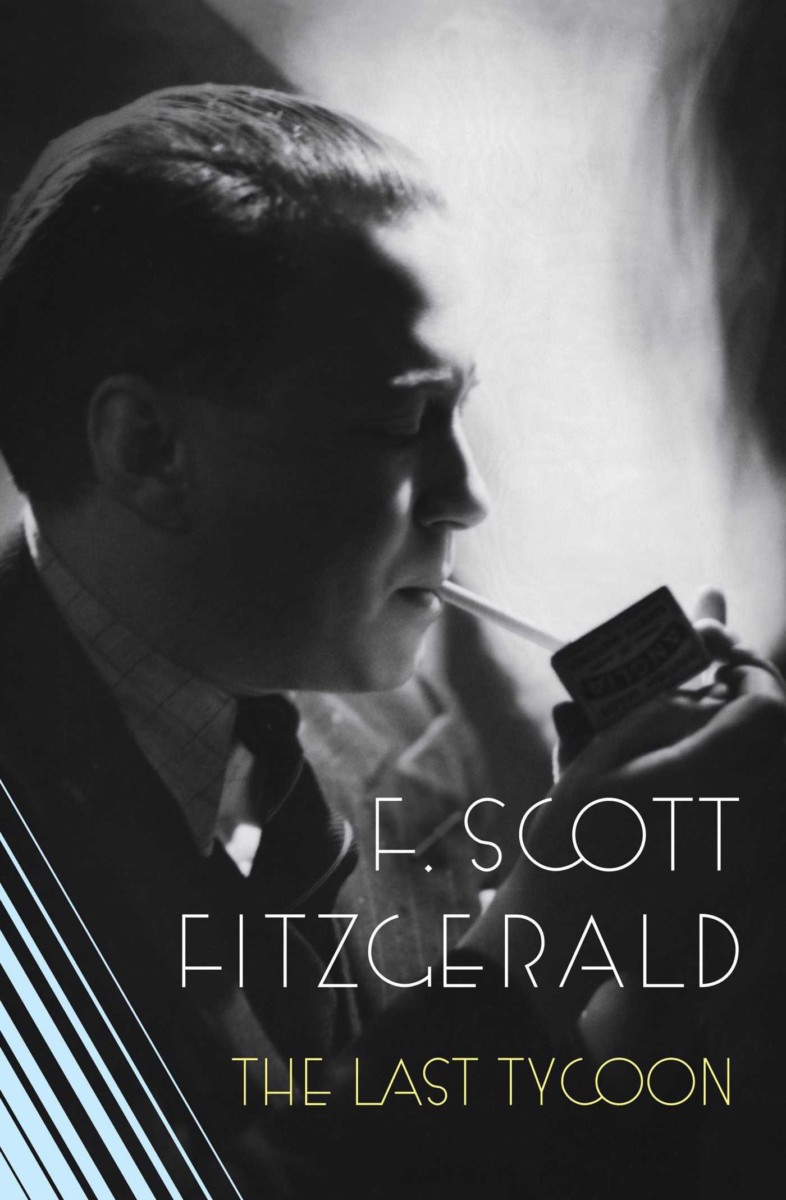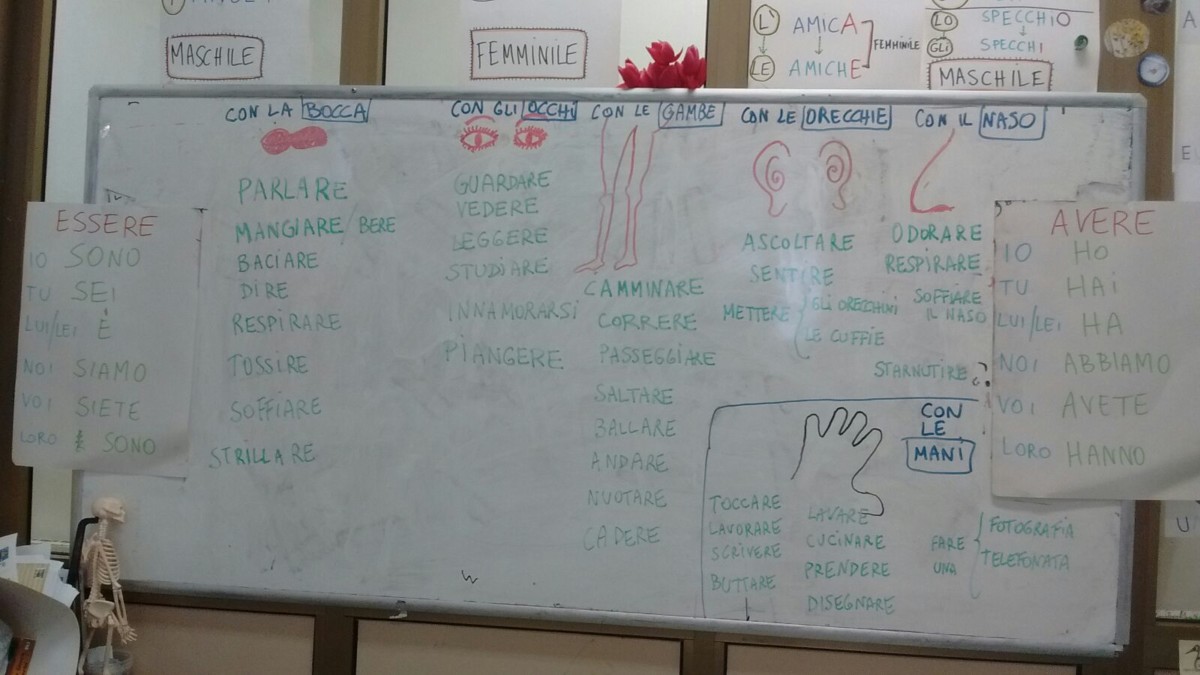I consigli di lettura funzionano solo se sono veri consigli, quelli che uno darebbe a un amico davanti a una birra, quelli che vengono in mente all’improvviso come letture del passato da recuperare, quelli che durante l’anno fanno parte delle liste di libri da acquistare in un futuro prossimo che si chiama luglio o agosto.
Di seguito ne trovate di vario genere, direttamente dalla nostra “amichevole” redazione.
Alessio Belli
Per il periodo estivo, fatto di viaggi e scoperte verso posti nuovi, in maniera più o meno inconscia alla fine scelgo sempre libri che parlano di casa, di Roma. Il primo è una novità, il secondo un recupero doveroso. Arsenale di Roma distrutta di Aurelio Picca (Einaudi Stile Libero) evoca con una prosa potente e suggestiva la bellezza di una Roma del passato da usare come arma per difendere la città dalle problematiche del presente: tra De Pedis, il Califfo, Emanuela Orlandi e Pasolini, uno scorrere clamoroso tra luoghi e protagonisti della Capitale.
La scuola cattolica di Edoardo Albinati (Rizzoli) ha vinto il Premio Strega e partendo dal quartiere Trieste arriva ai drammatici fatti del delitto del Circeo. 1300 pagine che molto probabilmente dureranno più del periodo estivo.
Claudia Cautillo
Quest’agosto, tra i libri che per primi metterò in valigia, ci saranno: Sogno di una notte di mezz’estate di Shakespeare e il romanzo immaginifico – in cui saggio e narrazione si fondono in un brillante omaggio alla grande letteratura – che Filippo Tuena ne ha tratto, tessendo dal testo originale un’armonia fiabesca e a tratti perturbante di riprese, alternanze e mutazioni: Com’è trascorsa la notte (il Saggiatore). Il primo, tra le commedie del passato che più hanno inciso sull’immaginario contemporaneo – basti solo pensare al serbatoio di ispirazioni di cui si è giovato perfino l’universo dei fumetti, da Dylan Dog a Corto Maltese – serve da traccia al secondo, che ne trasfigura la notte incantata, popolata di fate e folletti, nell’emblema di una superiore condizione universale in cui bellezza, amore e morte tornano a farci sentire “finalmente, non una parte ma un tutto”.
Per contiguità, bellezza, amore e morte mi fanno venir voglia di tornare a leggere l’ipnotico Lolita di Nabokov, forse l’ultima, folgorante apparizione del mito nel mondo moderno, dove ninfe e satiri rimettono in gioco le nostre categorie morali e di giudizio. Non ultimo, porterò con me Il principe di Giulio Leoni (Nord), romanzo seducente in cui finzione narrativa e attenta ricostruzione storica ci spingono a interrogarci, senza alcuna affettazione, su due apparentemente opposte concezioni della bellezza: quella di Cesare Borgia, nella forma di un grandioso progetto politico di unificazione dell’Italia, e quella di Leonardo da Vinci, nell’incessante ricerca della perfezione artistica. Due facce di una stessa medaglia, paradigma di una fenomenologia delle passioni quanto mai attuale. Buona estate e buone letture.
Alessandro Chiappanuvoli
Da qualche mese sto cercando di essere sincero, con me stesso non con gli altri. Ho cavato dalla libreria i libri che ho comprato e mai letto, quelli iniziati e mai finiti, quelli che ho abbandonato per mancanza d’interesse. Eccezion fatta per questi ultimi, è da quella pila che continuerò ad attingere. In ordine di priorità ci sono: Luce d’agosto di William Faulkner (comprato circa cinque anni fa), Dalia Nera di James Ellroy (regalo di una cara amica e mai aperto), Exit strategy di Walter Siti (preso in prima edizione e lì rimasto), Parigi è un desiderio di Andrea Inglese (che vergogna se penso al mio amico Andrea…) e Città distrutte. Sei biografie infedeli di Davide Orecchio (edizione Gaffi di cui non lessi le ultime due biografie). Così dovrebbe andare la mia estate. Spero. Perché giusto ieri ho fatto un ordine online di altri dieci libri. Sincerità, dicevo. Ne ho bisogno.
Davide Coltri
Il mio proposito per l’estate è uno solo: sopravvivere al traffico di Beirut. Meglio: al traffico e al caldo. D’altro canto, sono due buoni incentivi a uscire di casa il meno possibile e dedicare le sere alla lettura. Nelle prossime settimane ho in programma cinque percorsi: una graphic novel, una guida, un libro di interviste, la rilettura di un romanzo scoperto durante l’adolescenza e una raccolta di racconti che sto centellinando da più di un anno.
La mia cosa preferita sono i mostri: vol. I, di Emil Ferris, traduzione di Michele Foschini (Bao Publishing).
Questione di virgole. Punteggiare rapido e accorto di Leonardo G. Luccone (Laterza).
Perdersi è meraviglioso. Interviste sul cinema, di David Lynch, a cura di Richard A. Barney, traduzione di Francesco Graziosi (minimum fax).
Pian della Tortilla di John Steinbeck, traduzione di Elio Vittorini.
The complete short stories of Hernest Hemingway: The Finca Vigía Edition.
Dario De Cristofaro
Non provo simpatia per i preamboli né per agosto quindi sarò diretto: Cina e altri Orienti di Giorgio Manganelli (Adelphi), che mi consigliò Carla Vasio qualche anno fa. L’incipit è magnetico: «L’uomo è un animale viaggiante; mi pare che codesta peculiarità sia più bizzarramente significativa, più specifica di molte altre, raramente nobili, qualità che l’animale uomo è in grado di sfoggiare».
Uomini e cani di Omar Di Monopoli (Adelphi) – l’esergo tratto da Arcipelago Gulag di Solženicyn fa ben sperare: «Quando si vive in un cimitero non si può piangere su tutti» –, perché è uno degli italiani su cui sta puntando Adelphi e non avendolo letto prima pubblicato da Isbn edizioni, mi rimetto in pari.
Le mille luci di New York di Jay McInerney (Bompiani) invece per la tecnica della narrazione in seconda persona, che trovo molto interessante.
Porto con me anche Città distrutte di Davide Orecchio nella nuova edizione pubblicata da il Saggiatore e Change di Watzlawick, Weakland e Fish (Casa Editrice Astrolabio).
Veronica Giuffré
«Ogni estate, i preparativi più laboriosi prima della partenza per il mare, erano quelli della pesante valigia dei libri»: come per Amedeo – in L’avventura di un lettore di Italo Calvino – che pregusta una vacanza da trascorrere appollaiato sopra uno scoglio a leggere, così per ogni lettore torna puntuale al congedo dalla città il dilemma dei libri da portare in viaggio.
È vero che la tecnologia ha semplificato il problema degli ingombri, eppure occorre sempre ponderare le scelte perché il tempo dell’ozio libresco non ci sfugga via prima ancora di essere arrivato. Cercando un compromesso tra il bisogno di riposare e il desiderio di stimoli, ecco qualche titolo che non può mancare nella valigia delle vacanze:
Un libro per staccare la spina: Il mastino di Baskerville di Arthur Conan Doyle, il classico intramontabile del mistero da risolvere. Imprescindibile in doppietta con l’alter ego moderno di Sherlock, se – come me – siete abbastanza in ritardo sulle cose da averla appena scoperta.
Un libro per andare lontano: Sabbie bianche di Geoff Dyer, un’esplorazione degli spazi del mondo nella dimensione incantatrice della parola, in una forma che sfugge a qualsiasi definizione.
Un libro sul potere dei libri: L’educazione di Tara Westover, una storia incredibile nella sua autenticità, sui legami familiari e le possibilità di riscatto attraverso il dono salvifico della conoscenza.
Un antidoto al luogo comune: Questione di virgole di Leonardo G. Luccone, un manifesto in difesa della punteggiatura e uno strumento per imparare ad affinare lo stile, senza tralasciare il piacere della letteratura.
Un libro per le grandi ambizioni: Gödel, Escher, Bach. Un’eterna ghirlanda brillante di Douglas R. Hofstadter, un’immersione tra arte, scienza e linguaggio musicale. Perché non c’è niente di meglio che tenere sveglia la mente quando si è sopito il brusio fastidioso delle sciocchezze di tutti i giorni.
Ulderico Iorillo
Di sicuro, Tiro al piccione di Giose Rimanelli, in una vecchia edizione Einaudi. Perché: ha una storia editoriale controversa che chiama in causa grandi nomi della letteratura italiana del dopoguerra; è scritto da un mio corregionale emigrato morto di recente; descrive la seconda guerra mondiale da un punto di vista poco trattato in letteratura. Poi c’è un libro Edizioni Italo Svevo, Praz, su Mario Praz scritto da Raffaele Manica. Conosco la figura di Praz marginalmente, più per i suoi interessi che per la sua produzione saggistica, e vorrei saperne qualcosa in più. Mi piacerebbe mettere le mani su Il cielo è rosso di Giuseppe Berto – non è facile da reperire – perché ne ha parlato un mio amico in un suo libro in cui indaga alcuni casi editoriali del Novecento. Lo stesso amico mi ha consigliato Il giudice e il suo boia di Friedrich Dürrenmatt e spero di riuscire a leggere anche questo, ma in fondo un mese passa in fretta e «…ci sono delle biciclette da inforcare, marciapiedi da passeggiare e tramonti da godere» e, soprattutto, divani da dormire e caciocavalli da mangiare.
Luigi Ippoliti
In quel che resta di quest’estate non esagererò: il progetto di cosa e quanto leggere sarà bilanciato e fattibile. Dopo Le nostre ore contate di Marco Amerighi (Mondadori), mi sposterò per un paio di tappe in Cina: prima sarà il turno di Città di confine di Shen Congwen (Stampa Alternativa), poi inizierò la serie dell’ispettore Chen Cao scritta da Qiu Xiaolong, La misteriosa morte della compagna Guan (Marsilio). Infine tornerò in Italia, andando ad attingere dalla scapigliatura milanese: con Vita di Alberto Pisani (Garzanti) dovrei concretizzare le mie ambizioni.
Martina Mantovan
La parentesi estiva si apre con un testo dal titolo rivelatore e perfettamente calzante: Il tempo concesso di Rodrigo Rey Rosa (Mondadori). Parto dal Guatemala con questo testo composto da due racconti lunghi di rara luminosità. Nel primo racconto, Carcere di alberi, l’autore ricrea tra le fronde tropicali un esperimento parascientifico di coercizione e violenza, una parabola sull’obbedienza e la natura del linguaggio che lascia cicatrici profonde. Nel secondo racconto, Il salvatore di navi, militarismo e follia sono il terreno su sui costruire un sistema di efficienza e impeccabile funzionalità. Accettando il classico adagio di non cambiare spiaggia o mare, resto fedele al mio continente d’elezione e proseguo verso sud facendo tappa in Cile e in Uruguay: sulle tracce di detective e manoscritti a me assai cari, mi immergo in Lascia fare a me di Mario Levrero (laNuovafrontiera), il quale, con la prosa ipnotica di sempre ci mette sulle tracce di un autore dall’identità misteriosa. Niente di meglio da chiedere per bolañani assetati. Per concludere, un salto doveroso in Cile dove mi aspetta Francisco Ovando con Tutta la luce del campo aperto (Edicola ediciones): un correttore di bozze è il personaggio attorno a cui l’autore costruisce un caleidoscopico romanzo fatto di frammenti colorati e cangianti come gli indizi che semina lungo la narrazione, tra riti divinatori ornitologici e pittori avanguardisti e bistrattati.
Antonio Merola
Una volta, si diceva, l’estate era il tempo per i cruciverba. Ora, anche se mi ha chiesto di rimanere anonimo per ragioni del tutto evidenti, il vecchietto della piazza di Passoscuro ci tiene a dirmi che niente è cambiato: lui però usa Google, così le risposte diventano solo il pretesto per prendere dimestichezza con ciò che cambia. Visto che mi chiede che cosa stia facendo, gli spiego che devo suggerire un libro per la bella stagione: Il sarto di San Valentino di Iuri Lombardi (Ensemble – questo non gliel’ho mica detto). Che ha di speciale? Glielo racconto, ci provo almeno. Pensa, gli faccio, che c’è anche una sezione in cui le poesie sono dei cruciverba. Mica scherzo, leggi: «DIO ALLA FINE – IO […] INIZIO DELLA FINE – FI», e via dicendo. Non c’è solo questo, sia chiaro: Iuri Lombardi viene da Firenze, lì ora fa un caldo bestiale. Però nella raccolta, Firenze è una città avvolta dalla nebbia… diventa la Lucania, poi torna a essere una città. Hai presente le leggende che raccontano i pescatori di Passoscuro? Esatto, Lombardi ha una nostalgia simile. Si è messo sulle sue tracce, poi si è preso e si è gettato in un cestino – o nel mare, fa lo stesso. Ma ci sta su Google?, mi fa lui. Dovrebbe esserci, certo. Chissà a che gli serve saperlo. Glielo chiedo, senza remora: perché lo hai cercato su Google? Giovane, hai visto una stronza di libreria da queste parti per caso? Me lo faccio spedire, aggiunge: per una volta, preferisco cominciare dalle risposte.
Federico Musardo
Cerco sempre contemporaneamente di leggere almeno un libro di narrativa e uno di saggistica. Questa estate ho incominciato La protesta silenziosa. Evoluzione e significati dell’astensionismo elettorale di Ferrarotti, una raccolta di saggi per capire cos’è che ci porta alla solitudine sociale che mi ha incuriosito anche per il vago ricordo del Discorso sulla lucidità di Saramago, perché ora, come d’altronde sempre, per non dimenticare l’umanità che ci contraddistingue, bisognerebbe pensare criticamente, coltivare la propria agentività e abitare il mondo senza tacere verso le cose con cui non siamo d’accordo. Leggerò ancora Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale di Foscolo , una conversazione radiofonica di Carlo Emilio Gadda, uno dei miei scrittori preferiti, soprattutto perché seppe interpretare l’autore dei Sepolcri attraverso il filtro della sua critica salace, cercando di secolarizzare quella che nella nostra storia letteraria fu una vera e propria religione foscoliana, dove la virilità dell’eroe romantico e intrepido viene degradata a frivola e pettegola chiacchiera da salotto. Leggerò poi Handke, credo I calabroni, oppure i Racconti di Dürrenmatt, perché sono entrambi maestri della prosa breve (per giunta di lingua tedesca). Le loro sono quasi sempre storie che vale la pena di conoscere. Leggerò infine, ormai alla vigilia del periodo autunnale, credo, Gli animali che amiamo di Antoine Volodine (66thand2nd) , perché di suo mesi fa ho quasi finito Terminus radioso e ancora non ho capito se mi piace. Pennac, in un suo pensiero abusato tratto da Come un romanzo, ci spiega che ogni lettore ha il diritto di interrompere la lettura di un libro, forse anche di un autore, se finisce la pazienza e non entra nel cuore della storia che gli viene raccontata. Perciò voglio accertarmi delle mie perplessità prima di salutare Volodine, prematuramente, ancora una volta.
Matteo Pascoletti
Ero finora riuscito a evitare la faccenda dei libri da consigliare, anche con delle tecniche abbastanza elaborate che solo uno sguardo superficiale ed estraneo alla bolla editoriale potrebbe catalogare alla voce “misantropia”. Poi però qualcuno di Flanerí mi ha inviato a giro mail alcune foto abbastanza imbarazzanti che mi ritraggono in diverse violazioni del codice penale; la consapevolezza che a nulla sarebbe servito contestare il palese e grossolano ricorso a Photoshop mi ha portato a guardare tra i libri letti di recente, scegliendone alcuni che, alla fine, valgono tutto il tempo che dedicherete loro.
Sangue giusto di Francesca Melandri (Rizzoli). Le vicende di una famiglia diventano allegoria del rapporto tra un popolo – il nostro – e un passato che preferiamo reprimere collettivamente e rimuovere privatamente – le leggi raziali, l’Italia coloniale, i suoi orrori e crimini. Melandri, come in Eva dorme e Più alto del mare non solo sa scegliere temi importanti, ma li affronta con un accurato lavoro di ricerca a monte; mentre sulla pagina li tratteggia con uno stile in cui, per esempio, negli aggettivi, in come rivelano aspetti e sfumature quasi nascoste dei sostantivi, o nell’espansione cognitiva offerta dalle similitudini, si coglie il passo della grande scrittrice, la capacità di sintetizzare squarci su quella complessità che le retoriche quotidiane livellano o cercano di azzerare. Il tutto cementato da un’empatia che si rivela una forma di elevata, preziosa intelligenza.
L’inferno è vuoto di Giuliano Pesce (Marcos y Marcos). Siccome ogni tanto, dall’università ai dibattiti estivi (quando non c’è il nuovo capolavoro italiano o l’ennesimo romanzo dell’anno da incensare), esce fuori un qualche dibattito sul “genere”, e sul valore della “letteratura di genere”, la cosa più sensata a riguardo (a parte ignorare tali dibattiti) è consigliare un libro di genere a mo’ di esempio. Il romanzo di Pesce inizia col il suicidio del Papa, per cui il lettore si trova di fronte a due possibilità: o l’autore punta alto perché è consapevole dei propri mezzi, o cerca la partenza a effetto perché deve mostrare a tutti i costi quanto è bravo, alzando fin troppo fumo da un arrosto che sarebbe stato meglio non addentare. Pesce si rivela della prima caratura: padroneggia i generi senza scadere nel metanarrativo o nel citazionismo, tratteggiando una storia pulp e un’umanità grottesca, irredimibile. Costruisce un congegno narrativo preciso, modellato con brevità e concisione, e non sbava di una virgola. E scusate se è poco.
Quando siete felici, fateci caso di Kurt Vonnegut (minumum fax). Il libro raccoglie i commencement speeches – i discorsi ai laureandi alla fine dell’anno accademico – di Kurt Vonnegut, e niente: mentre lo leggevo non potevo fare a meno di immaginare la faccia del pedante professore che aveva invitato lo scrittore famoso, e già verso metà discorso si era pentito, o il benestante genitore repubblicano intento a strabuzzare nevroticamente. gli Alla fine del libro, invece, ho avuto quell’epifania salingeriana per cui vorresti che l’autore fosse tuo amico e chiamarlo al telefono e berci qualche volta un whisky insieme (ok, l’ultima non c’era nell’originale). Vonnegut nei suoi discorsi condensa verità semplici ma potenti, animato da una saggezza folle e un umorismo folgorante, e non c’è dubbio che per quegli studenti abbia rappresentato ogni volta il momento più alto del periodo universitario.
Gabriele Sabatini
Cerco sempre di trovare nell’estate un momento di riconciliazione, con la vita, con il lavoro, con sé stessi e, en passant, con Dio. E allora, quando qualche settimana fa mi hanno suggerito A Dio per la parete nord di Hervé Clerc (Adelphi), non ho avuto molti dubbi di metterlo in valigia. Promette di essere un libro in cui il lato meno accogliente di un eventuale Signore viene scalato attingendo da diverse tradizioni religiose. Insomma, me l’ha suggerito una persona di cui mi fido; è pubblicato da un editore che seguo; Emmanuel Carrère lo rilegge spesso: proviamoci. Sono certo che preparerò la mia vacanza istriana e quarnerina leggendo La miglior vita di Fulvio Tomizza, in cui si parla di un’Italia di frontiera e della rimodulazione di confini geografici e culturali. Ma poi, chissà, magari entrambe queste letture vanno male e mi sconforto. Allora tengo a portata di mano un Simenon: lo considero, un bene rifugio, o se vogliamo un Polase letterario. Quest’anno tocca a La casa dei Krull, in cui una minoranza diventa capro espiatorio…
Cristiana Saporito
Non importa molto. Per cosa stiate partendo o in cosa stiate restando. Se le secchiate di sole vi inabissano dove avete sperato o dove non potete fare a meno di essere. Esistono sempre, e voi lo sapete, viaggi che sopravvivono ai nostri vorrei. Pulsazioni di storie possibili, distanze indifferenti alle miglia. E titoli pronti a salvarci, scivolando nelle crepe. O riparando qualche ustione. Questa scorta di trame è il corredo che proponiamo per ogni tipo di vacanza. Anche quella a km 0.
Storie di alberi e bonsai di Alejandro Zambra (Sellerio). Due romanzi stretti in un pugno. Essenziali e vastissimi. Nel primo, un uomo aspetta il ritorno della sua compagna. La notte si allunga, la bimba si addormenta e la porta resta chiusa, mai varcata. Nel buio diluviante la sua assenza si fa macchia. Contagiosa, affamata. Lei non c’è, lei non ha avvisato, e la mente di chi attende si avvita nei ricordi. Ondeggia, ipotizza, e poi raggiunge il futuro. In Bonsai, mentre aiuta un anziano autore a trascrivere il suo racconto, Julio rievoca un primo amore d’incastro assoluto, nato all’età della scuola. E in quelle stesse righe ritrova i semi di un mondo mai sfiorito. Scrittura nodale, capace di costruzioni illuminanti e sortilegi inconsapevoli.
I formidabili Frank di Michael Frank (Einaudi). Autobiografia in forma altamente letteraria. Michael è figlio di quattro persone. I suoi genitori e i suoi zii, coppia di sceneggiatori della più prospera Los Angeles. Tra i due la zia Hank, sorella del padre, accentra e assorbe qualunque sua attenzione. Bella, colta ed egoista, incorpora il nipote nella sua sfera affettiva, indottrinandolo su bene e male di ogni scelta, artistica e vitale. A dispetto di qualsiasi intromissione. Maestra e carnefice. Ipnotica e ingabbiante. Michael cresce sotto il suo influsso, come il più forte dei pianeti e ne racconta le schegge e le ossessioni. Un’esistenza che si legge come un copione.
L’estate del ’78 di Roberto Alajmo (Sellerio). Un libro per rovesciarsi dentro. Alajmo comincia da un addio inavvertito, quello a sua madre, che incontra per strada durante l’estate della maturità, una volta fuggevole, imbarazzata . Una volta che sarà l’ultima, anche se lui lo ignora. Da quella pietra di memoria, l’autore tratteggia il suo ruolo di figlio e di padre. Dell’entropia di emozioni durante il passaggio. Con una lingua nitida e sincera, che sa concedersi intimità e ironia. E che in quell’autoanalisi restituisce abilmente uno specchio molto più ampio.
Anime Inquiete di Isabella Cesarini (Haze). Un arcipelago di creature sul filo. Turbate e perturbanti. Da Diane Arbus a Bruno Lauzi, da Leonor Fini ad Ágota Kristóf, Isabella Cesarini attraversa un giardino di piante rare e dolenti. Con un approccio insolito, che scavalca la critica o il semplice ritratto, ci offre una visione poetica e raffinatissima del loro modo di scalfirsi nel mondo, di incarnare il travaglio e trasformarlo in arte.
A questo punto, non c’è altro da aggiungere. Oltre alla vostra scelta.
Francesco Vannutelli
Nel corso di questa estate ho già avuto modo di leggere alcune cose interessanti, ma è per agosto che conservo la parte più nutrita della mia ambizione da lettore. Ho messo da parte un bel po’ di titoli, l’obiettivo è leggerli tutti, conto sui treni che dovrò prendere . Sto recuperando alcuni autori del Novecento della letteratura italiana. Dopo aver letto Paesi tuoi di Cesare Pavese e Racconto d’autunno di Tommaso Landolfi punto a Lessico famigliare di Natalia Ginzburg e Una spina nel cuore di Piero Chiara. Da anni più recenti ho pescato I segnalati di Giordano Tedoldi, La futura classe dirigente di Peppe Fiore e Le attenuanti sentimentali di Antonio Pascale. Sempre di autore contemporaneo, Ballard e Il condominio. In mezzo ci infilerò un po’ di letture di quei gialli rassicuranti di cui in Sellerio sono dei grandi esperti: L’anello mancante di Antonio Manzini, Il metodo Catalanotti di Camilleri e Come una famiglia di Giampaolo Simi. Non possono mancare dei racconti, e quindi recupererò L’amore sporco di Andre Dubus III.