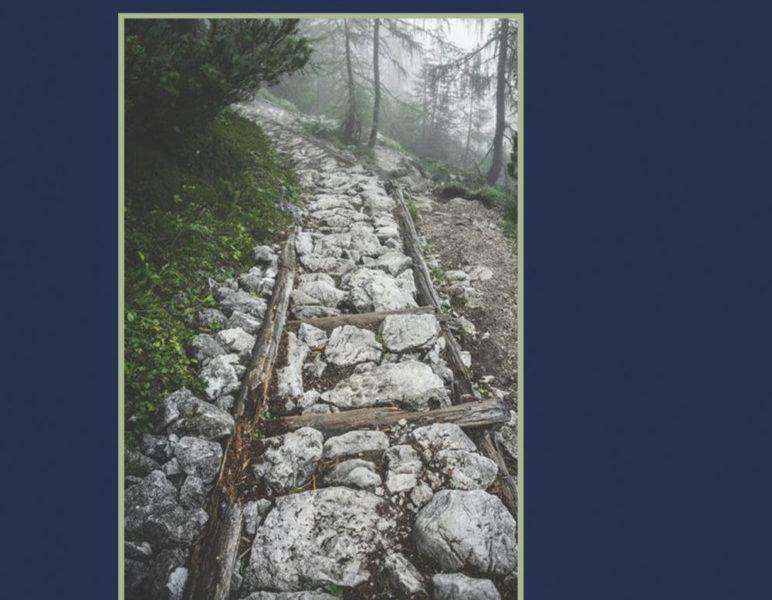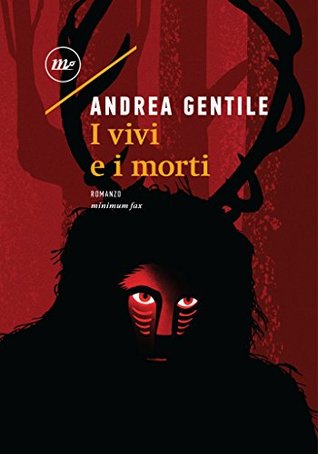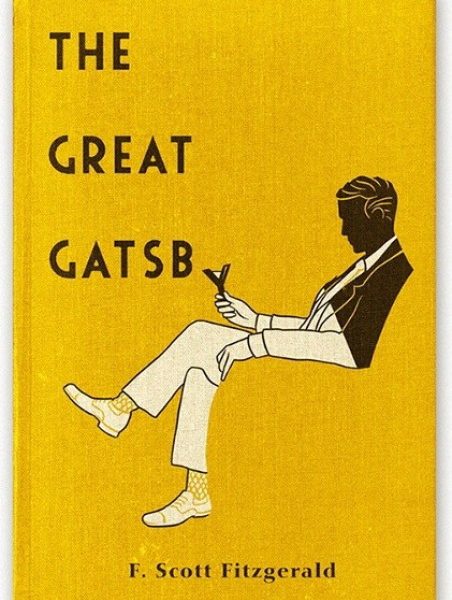In questo e nei prossimi articoli cercheremo di spiegare, con parole semplici e con esempi ancorati alla realtà, come funziona l’accoglienza in Italia, che cos’è il diritto di asilo e quali possibilità sono previste per uno straniero che richiede protezione. Lo faremo da un punto di vista “umano”, evitando posizioni ideologiche, numeri, statistiche o articoli di legge (facilmente reperibili in rete). Ovviamente la semplificazione non vuole in nessun modo sminuire i patimenti di tante persone costrette a migrare, solo rendere più accessibile un mondo di cui si parla tanto ma che molti non conoscono del dettaglio, diventando così facile preda di generalizzazioni e populismi.
La prima cosa da chiarire è che non c’è e non ci può essere un diritto di asilo in base al paese di provenienza. La storia delle persone è, appunto, personale. Posso venire da un paese non in guerra ma non è detto che io non abbia subito persecuzioni o io possa avere specifiche fragilità che non consentono il mio ritorno nel paese di origine. Inoltre, come vedremo poi in seguito, la legge non prevede solo il diritto di asilo politico e la protezione sussidiaria (5 anni), ma c’è un’altra possibilità che si chiama permesso umanitario (2 anni).
Ma partiamo dall’inizio, dal viaggio. La traversata in mare è l’esempio più classico, e nella maggior parte dei casi l’ultima fase di un difficile percorso che dura già da settimane, se non da mesi, lungo strade dissestate, montagne e deserti. Se parti da un qualsiasi Stato dell’Africa la destinazione è sempre quella, la Libia, in qualche caso la Tunisia. Per arrivare ad esempio dal Congo alle coste libiche bisogna percorrere più di settemila chilometri, da Lagos a Tripoli quasi cinquemila, e di certo non con l’aereo. Se vi fate poi una chiacchierata con le ragazze e i ragazzi che sono ospiti nelle strutture di accoglienza scoprirete che una schiacciante maggioranza prima di riuscire a imbarcarsi ha subito violenze, torture o è stato detenuto nelle carceri libiche. Quindi bisognerebbe partire dall’assunto che chi riesce a salire su un cosiddetto “barcone” porta già con sé un bagaglio di traumi piuttosto pesante.
Il “mito” dello scafista è nella maggior parte dei casi, appunto, un mito. Chi si occupa di organizzare la traversata è molto difficile che poi imbarchi insieme ai passeggeri. I trafficanti restano sulla terraferma o lasciano il comando della barca a qualcuno dei passeggeri al quale viene scorporata la quota di viaggio o, più frequentemente, abbandonano relitto e passeggeri al largo della Libia facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei soccorsi di Guardia costiera o navi Ong. (Parentesi drammatica, quella troppo spesso dimenticata, di barche alla deriva, naufragi, morti dei quali abbiamo avuto notizia e tanti di cui non si saprà mai nulla).
Una volta attraccati su suolo italiano (chiusura dei porti permettendo), i passeggeri vengono raccolti nei cosiddetti hotspot, strutture “di smistamento” dove vengono soccorsi, identificati ed entro quarantotto ore trasferiti presso altra struttura di accoglienza, o in un Cie (Centro di identificazione ed espulsione) nella rara eventualità che la persona non richieda protezione. Dentro un hotspot, le possibilità sono le seguenti:
Se sei un minore straniero non accompagnato, evidente o con un documento che lo attesti, hai diritto subito all’accoglienza, il tutore diventa nell’immediato il sindaco, o chi per lui, della località di sbarco (in attesa della decisione di un giudice tutelare) e dovrai essere trasferito quanto prima in una struttura di accoglienza per minori.
Se dichiari di essere un minore straniero non accompagnato ma non puoi dimostrarlo e l’autorità del paese di sbarco nutre dei dubbi (anche nei casi in cui, viceversa, non dichiari di essere minore ma sussistono fondati dubbi), dovrebbe comunque valere il principio di presunzione. Tuttavia viene attivato dal giudice tutelare l’iter per l’accertamento dell’età, che dovrebbe essere quanto più possibile multidisciplinare, prevedendo così colloquio sociale, valutazione psicologica alla presenza di un mediatore culturale che tenga conto dell’origine etnica e culturale dell’interessato e un’attenta visita pediatrica. In ogni caso, anche nei casi di dubbio, come detto in precedenza, fino all’accertamento dell’età deve essere valida la presunzione, e garantire l’accoglienza immediata al presunto minore.
Nel caso in cui tu non sia un minore non accompagnato esistono tre possibilità:
Prima. Richiedere protezione internazionale. L’iter dovrà essere interamente gestito dal paese di identificazione: il famoso regolamento di Dublino di cui si parla tanto. In sostanza se sbarchi (e vieni identificato) a Catania, la procedura (e la relativa accoglienza) per la richiesta di protezione deve avvenire in Italia. Se vuoi andare in Germania lo potrai fare solo dopo aver ottenuto lo status (protezione sussidiaria o asilo politico, con l’umanitario non si può espatriare). Ma si deve tener presente che da quando viene avviato l’iter all’ottenimento dello status passano almeno sei mesi (anche se in genere sono molti di più).
Seconda. Evitare l’identificazione e fuggire. Darti alla clandestinità con la speranza di raggiungere magari un altro paese europeo. Ma i controlli sono molto stretti e le possibilità di scappare (senza considerare che dopo la pesante traversata e l’arrivo stremati a pochi verrebbe in mente di darsi alla fuga) sono molto limitate.
Terza. Non richiedere protezione internazionale e di fatto condannarsi alla reclusione in un Cie prima dell’espulsione.
Ovviamente quasi tutti, se non tutti, optano per la prima possibilità diventando, di fatto, richiedenti asilo e accedendo così al circuito di accoglienza. Dunque, è importante precisarlo, non sono clandestini.
Come funziona una richiesta di asilo? Entro sei mesi dall’avvio della procedura la persona dovrà comparire davanti a una commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Le commissioni distribuite sul territorio nazionale attualmente sono venti. Ognuna è composta da quattro membri: un funzionario della prefettura come presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale, e un rappresentante UNHCR; tutti i membri hanno diritto di voto e la decisione sui casi individuali può essere adottata a maggioranza, o con il voto favorevole di almeno tre membri.
Mentre vi scriviamo la composizione delle commissioni è in fase di cambiamento. Un recente concorso del Ministero dell’Interno è stato volto ad assumere più di duecento funzionari con l’obiettivo di far diventare le commissioni territoriali quasi totalmente ministeriali. Vedremo gli sviluppi e cosa tutto ciò comporterà.
L’audizione in commissione prevede un colloquio alla presenza di un mediatore (a meno che il richiedente non decida di sua spontanea volontà di sostenere l’audizione senza il mediatore) in cui la persona racconta la sua storia personale e le motivazioni che lo hanno indotto alla migrazione (producendo documentazione laddove presente). Si tratta di una fase piuttosto delicata e che andrebbe preparata quanto più possibile con un operatore legale (che generalmente non è un avvocato ma un operatore specializzato del centro di accoglienza preposto alla preparazione della commissione assieme all’ospite). L’operatore legale svolge un ruolo fondamentale, perché è colui che spiega al richiedente, con l’aiuto del mediatore, tutta la procedura per la richiesta di protezione. Non solo, di concerto con l’ospite imposta il colloquio in commissione, stabilisce come dovrà essere raccontata la storia e suggerisce tutti i passi da compiere, compresi i colloqui con medici, psicologi e psichiatri necessari nei casi di traumi pregressi o torture subite (e sono tanti, spesso non manifesti). L’operatore legale porta su di sé una grande responsabilità: una commissione preparata male significa pregiudicare il futuro di una persona compromettendogli, di fatto, il diritto di protezione.
Dopo l’audizione, la commissione può emettere i seguenti verdetti:
Diniego: il richiedente non ha i requisiti per richiedere protezione. Di fatto se la persona non ricorre in tribunale viene raggiunta da un decreto d’espulsione.
Riconoscimento dell’asilo politico. Il richiedente ha subito atti di persecuzione, fisici o psicologici, per motivi politici, religiosi, razziali (o gli è stata impedita la libera scelta dell’orientamento sessuale). Ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato (il rifugiato è, secondo l’articolo 1 della Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati – e qui facciamo una piccola deroga al nostro proposito di non citare articoli di legge – «chiunque, nel timore fondato di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato». Ha diritto a un permesso di soggiorno di cinque anni, a un titolo di viaggio per rifugiato (un passaporto che gli consenta di potersi recare all’estero) e al ricongiungimento familiare.
Riconoscimento della protezione sussidiaria. Il richiedente non possiede i requisiti per ottenere lo status di rifugiato ma sussistono fondati motivi secondo cui in caso di un rientro nel proprio paese potrebbe subire danno: l’esecuzione di una condanna a morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia di conflitto armato. Anche in questo caso si ha diritto a un permesso di soggiorno di cinque anni, al titolo di viaggio e al ricongiungimento familiare.
Riconoscimento della protezione umanitaria. Il richiedente non ha diritto alla protezione internazionale ma la commissione raccomanda al questore il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Possono essere tanti i motivi umanitari: dalla fragilità psicologica o fisica a un comprovato impegno (oltre ai meriti particolari) di volersi integrare nel paese ospitante. Il permesso ha una durata di due anni e non dà diritto all’espatrio e al ricongiungimento familiare.
A seguito dell’esito della commissione il richiedente ha comunque diritto al ricorso. Generalmente ricorrono tutti i diniegati ma anche chi ha ottenuto un permesso umanitario ma ritiene di aver diritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria.
Il ricorso va presentato al tribunale competente e dunque il pronunciamento sarà affidato a un giudice. Quindi non sarà più sufficiente un operatore legale ma dovrà entrare necessariamente in gioco un avvocato (non si parla più di commissione ma di udienza). Anche in questo caso, l’avvocato ha una grossa responsabilità perché ha il compito e il dovere di capire i motivi del diniego e integrare alla storia raccontata in commissione ulteriore documentazione a supporto della richiesta di protezione.
Qualora anche il ricorso dia esito negativo, secondo il recente decreto Minniti non è più possibile un secondo grado di giudizio ed entro trenta giorni il richiedente può fare ricorso in Cassazione (ma è davvero molto raro che un ricorso in Cassazione ribalti la precedente sentenza di un altro giudice).
L’altra possibilità è presentare una nuova richiesta di asilo, la cosiddetta reiterata. Il richiedente potrà così comparire dinanzi a una nuova commissione per sostenere un’altra audizione (ovviamente la storia precedente non dovrà essere stravolta) apportando nuova documentazione a supporto della stessa. In questo caso però il richiedente non ha più diritto all’accoglienza (che è infatti spendibile una sola volta).
Nel prossimo articolo analizzeremo come funziona, questa accoglienza. Vi racconteremo quali e quanti tipi di centri di accoglienza esistono, quali servizi devono garantire, le persone che ci lavorano e chiariremo determinati aspetti sui quali c’è parecchia confusione (per esempio non tutti sanno che un richiedente asilo ospite in una struttura di accoglienza non ha accesso nell’immediato al mercato del lavoro, o a cosa servono effettivamente quei quarantacinque euro di cui tanto si parla). I centri di accoglienza vengono spesso associati esclusivamente a processi speculativi, ma raramente viene messo in luce l’operato serio e professionale di molti addetti ai lavori (dagli insegnanti di italiano, agli operatori, agli educatori, agli psicologi). Noi cercheremo di farlo, senza però nascondere le problematiche connesse al sistema.