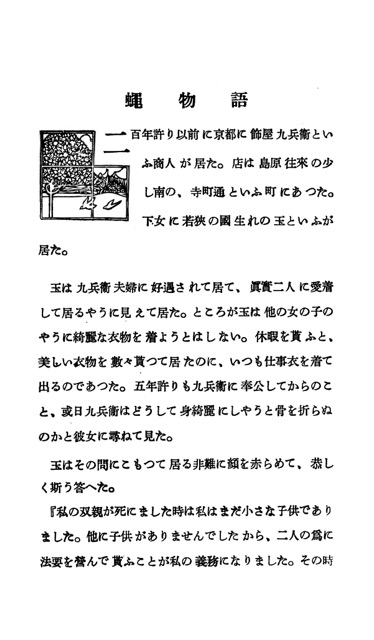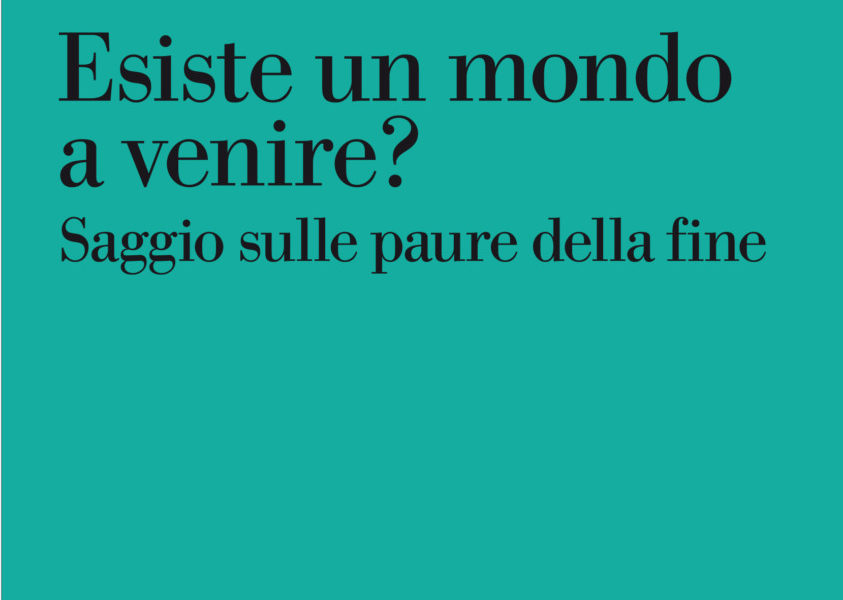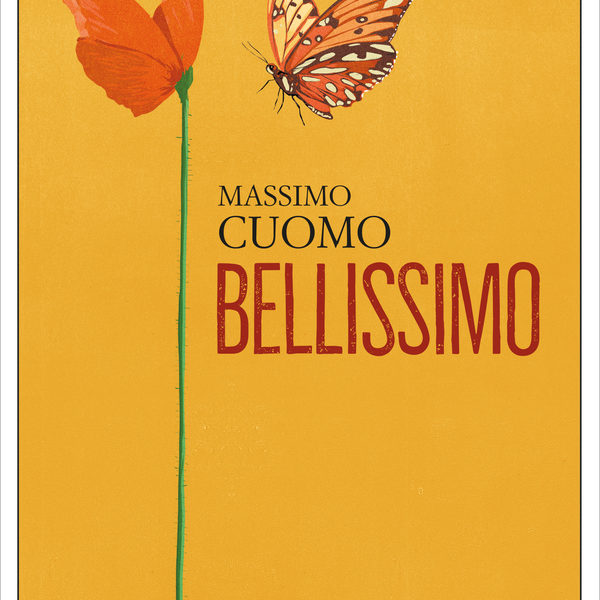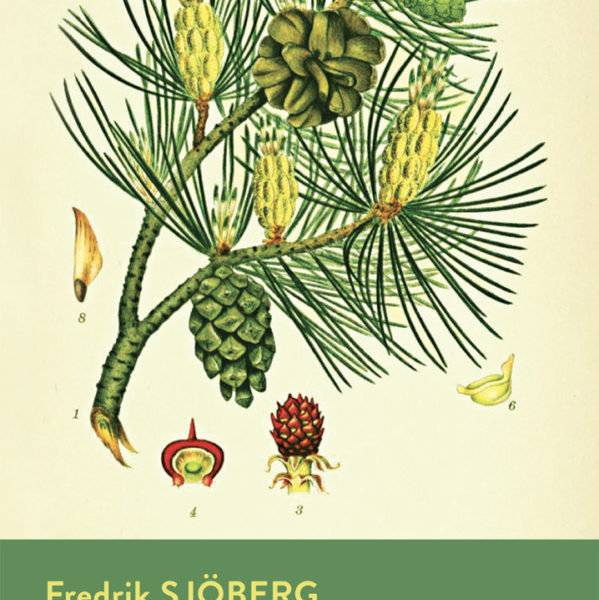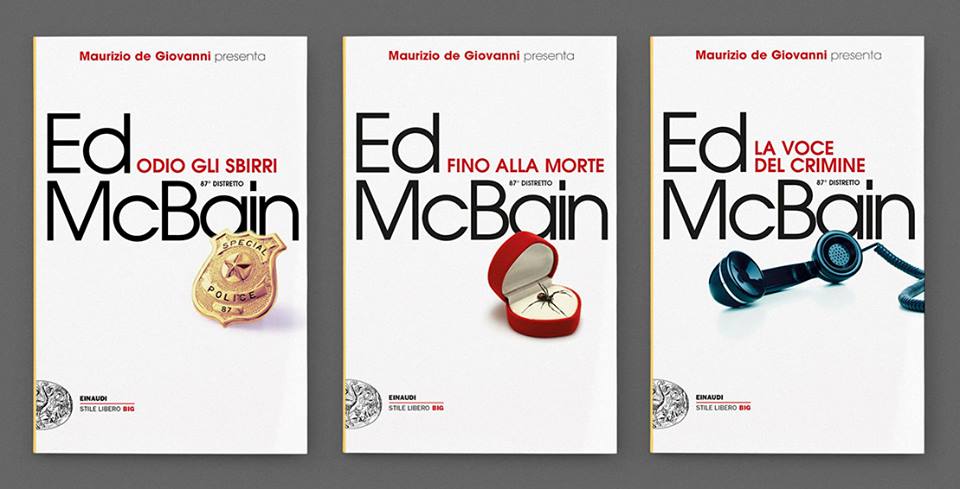Pedalo, pedalo, pedalo sempre più forte. Sterzo dentro via Pirandello. Pedalo ancora, e ancora, e ancora. Il sole alto batte sulle spalle, sulla testa. Una Fiat Panda 30, marrone, esce di colpo dall’incrocio, mi viene addosso, il pedale sinistro della mia Bmx tocca la gomma destra posteriore di quel cassone pieno di merda.
«Bastardo di Budu bastardo» urlo al tossico alla guida. Prendo il bivio a destra e imbocco la discesa verso via Udine. Mi alzo in piedi sui pedali. Sono velocissimo. Velocissimo. Le Case Rosse, alte trenta metri, lunghe un chilometro, larghe tanto basta da tenerci dentro fiumi di famiglie e famiglie e famiglie; le Case Rosse nemmeno oggi mi mangeranno. Io lì dentro mica ci finirò mai. Io.
Tiro un’inchiodata di dieci metri davanti al bar Corso e lancio la Bmx sopra le bici degli altri. Sono già tutti qui.
Mi volto a guardare il segno nero del copertone Michelin sull’asfalto: un campione, mi dico. A quattordici cazzo di anni, son davvero robe da campioni di motocross. Avrò mai i soldi per il Ktm Gs125, magari anche dell’82? Ma che me ne fotte. Fanculo anche il Ktm.
«Frenata da record!» urlo spalancando la porta.
«Cazzo sbatti la porta, cazzo hai da urlare bocia?» ribatte Luca alzando un vassoio stracarico di Moretti chiare da mezzo.
Oggi è sabato e come ogni sabato il bar Corso esplode. Ci sono facce su facce, due mai viste prima, di tipi scuri, negri; da dove cazzo saranno arrivati?
Attorno c’è gente con jeans sbregati, magliette con scritte e teschi: Metallica, Iron Maiden, Il Blasco, pantaloni tagliati. Una tipa ha le tette così grandi che cercano di scappare dalla maglietta nera stretta. E sarebbe un bel vedere. Sono gli stessi di ieri sera alla Perseo, che li guardavo da dietro il Pacman, che poi, cazzo, ho perso ancora proprio all’ultimo livello.
Di sabato cantano, alzano bicchieri al soffitto, si abbracciano, brindano, qualche bicchiere si spacca e ridono. Invece per tutta la settimana nemmeno li vedi: sono a lavorare in fabbrica, in catena, dicono proprio così: in catena diocàne. All’inizio non capivo cosa c’entrasse dio. Poi mi sono abituato anche a dio: il tiro a segno delle besteme, come lo chiama Uanch, da tirargli frecce in mezzo al muso, continua a dire urlando al soffitto del bar Corso.
Anche i vecchi il sabato stanno meglio: mettono gli occhi bavosi sulle tette delle ragazze, ché proprio gli sbavano le pupille, a quelli. Chissà se le hanno mai toccate, loro, le tette. Più che altro: chissà quando le toccherò io, le tette.
Il barista corre. Porta Moretti, bottiglie di Merlot, mezzi litri di Tocai, e ride, prepara panini, pizzette, pezzi di salame e di pane vecchio, e ride. Ride sempre, Luca, di sabato.
Vicino al biliardo, seduti al solito tavolo verde acqua dove abbiamo inciso col taglierino Troia Claudia Troia Sara Troia Monica Troia Luisa, ci sono Caio, Kiki e Ringhy.
Mi faccio largo in mezzo a culi, capelli, schiene, fumo e puzza di sudore, sbatto sulla faccia di Vasco che mi fissa da dietro gli occhiali scuri, sgomito per farmi spazio, e finalmente riesco a raggiungerli.
«Ciao bastardi», dico sorridendo.
«Ho il fumo» avverte Caio a bassa voce.
Si alzano di scatto e siamo già in marcia.
Sul retro del bar Corso ci sono tre ragazze. Se ne stanno a parlare di chissà cosa, appoggiate al muro rosso scrostato, in fondo, tra le siepi e l’inizio dei giardini della scuola media dove la notte i tipi in auto vanno a scopare e noi gli pisciamo sopra i finestrini, dal tetto dell’edificio. Le tipe hanno il sole sopra le teste. Le tette fanno ombra sulle magliette attillate, una rosa, una rossa, una celeste. Toccherei le tette celesti, oggi. Però nemmeno ci guardano. Fisso che parlano del Manzo, o della sua Clio sedici valvole di merda. Allora che vadano a farsi sbattere dai tipi, dico senza aprire bocca.
Caio tira fuori dalla tasca il pezzetto di fumo oleoso, marrone. Lo sgrana metà sulle dita. Kiki fa cenno di passarglielo e lo mischia al tabacco di una Camel recuperata di scrocco dal Baffo. A sua volta passa tutto a Ringhy, il migliore a tirare su un cannone preciso. Mica facile. Io ne ho sprecati tre in quindici giorni, facendoli grossi che neanche tiravi niente.
Viene fuori da dio. Ringhy accende. Tira. Poi passa a Caio. Tira. Poi arriva a me. Tiro. Poi lo giro a Kiki. Tira. Ringhy attacca a dire che è roba buona, resinosa, buona e resinosa, resinosa, e buona. Tanto buona. Tanto resinosa. Quando si fissa con le para diventa peggio di Umberto Smaila con i culi delle Ragazze CinCin. Ringhy ha quindici anni e da tre fuma botti. Caio dice ovvio, ovvio, ovvio, e ride, me l’ha passato mio fratello, ché gli ho lavato cinque volte la Fiat Ritmo Abarth 130, ché va a scoparsi dietro la Zanussi Samantha e torna strasmerdato di fango. Kiki tace. Io penso che toccherei anche le tette rosse, ma anche quelle rosa, ma prima quelle celesti. O prima le rosa. O prima le rosse.
Boh.
Rientriamo al bar Corso come un plotone di stonati.
Se ci mandano in guerra duriamo cinque minuti. Ci spariamo sui piedi, cristodiddio.
Però qui si dice che Villanova è già in guerra e io sono durato quattordici anni, penso gonfiando i bicipiti come Rocky 4.
Recuperiamo il nostro tavolo. Mi viene da ridere e da vomitare. Non so quale di più. Mi sforzo a ridere, per un cazzo di niente. Tengo duro, io, ché resisto più forte di Rocky 1, io.
Ringhy si volta, mi fissa.
«Stai muto, cazzo, non ridere, cazzo, stai muto» ripete stringendo i denti.
Caio mi prende la faccia e me la gira verso il fondo del salone.
A soli due tavoli c’è il Bubu, uno dei vecchi del bar Corso. Ha trentacinque anni, comanda tutti. Questione di esperienze, di pessime storie, cioè si parla di Pere. Mica stronzate. È seduto con il suo amico Faccia Tagliata.
Oggi ci sarà spettacolo, col Bubu nei paraggi succede abbomba qualcosa. Così si dice. E si dice anche che grazie al Bubu, Villanova di Pordenone, cioè le Case Rosse, è secondo in Friuli per disastri e casini, appena dietro la zona del porto di Trieste. Siamo famosi, andiamo sui giornali. Nell’ultimo mese Piscina, che si piscia ogni giorno nei pantaloni per via del problema che non gli regge il cazzo quando beve, ha accoltellato Lo Zingaro; Pasin ha rubato l’auto della pula, ma è stato beccato dopo due curve stampato sul platano, con le luci blu della volante accese che urlava Viva Udinese, Viva Udinese, Viva Udinese; Ioio Coltello ha steso tre dell’est a cazzotti in faccia, e senza coltello, e uno c’è rimasto secco peggio che se rimaneva coi comunisti slavi come lui; Bisturi invece è stato arrestato mentre inseguiva una pensionata a pochi metri dalla Friuladria di Madonna delle Grazie, giù per la discesa del Tuttosconto che porta ai garage delle case popolari, la vecchia gli dava giù in testa con l’ombrello e lui tirava la borsetta finché ha mollato la presa che lo hanno beccato come un idiota due vigili usciti dalle siepi del campo di tennis abbandonato da anni e anni. Ogni volta la prima pagina del Gazzettino.
Il Bubu usa il bar Corso come ufficio. Qui incontra gente, qui vende e compra fumo, cocaina, eroina, lsd, ecstasy, qui è casa sua. Lo si trova sempre sulla solita sedia, la mia cadrega d’oro, la chiama. Manca solo se va a curarsi. Sparisce per settimane, e allora si sa che è all’ospedale dei drogati a urlare ai muri delle stanze imbottite di cuscini e lui imbottito di calmanti.
Il Bubu e Faccia Tagliata sono intenti a discutere. Si fissano, parlano occhi negli occhi. Sopra le loro teste, attaccati al muro rosso scuro, ci sono i poster di Carmen Russo e Pamela Prati. Quattro tette enormi che sembrano cadergli addosso da un momento all’altro.
Sopra il tavolo ci stanno dodici bicchieri, vuoti. Tutti con un alone arancione. Segno che dentro c’era il Ciuccio, una roba di aperol, vino bianco e qualche avanzo di superalcolico aggiunto a caso. Ogni tanto lo mandiamo giù anche noi, ce lo passa Luca guardandosi attorno. Mi son sempre chiesto cazzo gli frega, che paranoie si fa, abbiamo quasi quattordici anni. Fa schifo ma ubriaca subito, e per noi che andiamo avanti a spiccioli va più che bene. Il Ciuccio è il divertimento dei fegati giovani, urlano i vecchi che bevono vino bianco, a bottiglie.
Abbassiamo la voce, tiriamo le orecchie.
«È ora di far basta con questa vita di merda» attacca il Bubu. «Vita schifosa e inutile. Da domani mattina si cambia registro. Cazzo, capisci? Qui bisogna prendere in mano il progetto. Quella storia del negozio che mi gira in testa da anni. Roba grossa, capisci? Che io ci ho le idee. Cazzo! Qui dobbiamo muovere il culo».
Io, Caio, Kiki e Ringhy ci mettiamo subito le mani alla bocca, per non scoppiare a ridere.
Abbiamo capito bene. Il Bubu vuole aprire un’attività, mettersi in affari con Faccia Tagliata.
«È semplice, amico, basta aver fiuto per i soldi e io, modestamente, di fiuto ne ho. Soldi no, cazzo. Ma sono un imprenditore nato. Io mica vengo da una famiglia di merda. Io ci sono abituato a queste robe qua del far girare soldoni. Se mi dai soldoni, io ti moltiplico soldoni. Io sono il dio del denaro. In famiglia siamo geni dell’economia. Gran testoni. Cazzo».
Al bar Corso tutti sanno che i parenti del Bubu sono come lui. Una volta il fratello maggiore ha aperto un bar nel quartiere qui vicino, poi un’officina meccanica in centro, poi un negozio di frutta e verdura nella zona nord, poi un’impresa di pulizie. Il padre aveva un negozio di ferramenta, poi ha messo su un’azienda di costruzioni, poi ha fatto l’idraulico. Poi è scappato assieme all’altro figlio, nessuno sa dove. È rimasta solo la madre a fare il lavoro più antico del mondo, anche oggi che è vecchia.
«Cazzo, amico» riattacca a sbraitare il Bubu, «apriamo il negozio di vestiti per giovani più giusto in circolazione, mettiamo dentro roba alternativa, inglese, costosa, roba buona. Capisci? Ci vuole solo il locale in centro, la licenza, chi ci porta la roba, il nome giusto, i manifesti, i cataloghi, dopo prendiamo quello che ci tiene i conti, la cassa per i soldi che butta fuori lo scontrino, e poi vai liscio che ci arrivano un mare di clienti con la pubblicità nel giornale».
Il Bubu si ferma, butta giù un altro giro di Ciuccio per scrollarsi di dosso i brividi e riprende: «le grandi idee hanno bisogno di lunghi pensieri e di gente con i coglioni, di gente come me e te, mi capisci?»
Faccia Tagliata risponde eccitato, elettrico: «È una figata, è una figa figata, è una gran fighissima figata. Ci sto dentro alla grande, amico! Alla grandissima. Dio mio, proprio una figata galattica. Posso fare il commesso, amico. Io, commesso per mezza giornata. Ogni giorno. Tutte le mattine. Così il pomeriggio tiro avanti anche in fabbrica. Doppio lavoro, fratello. Soldi a manetta, fratello. Una figata tremenda, fratello».
Il Bubu tiene la bocca spalancata. In un istante diventa prima pallido e poi bianco, come un cadavere. Comincia a tremare. Gli parte uno scossone lungo la schiena. Si contorce e torna dritto. Ha la fronte lucida. Gli occhi bianchi, spariscono le pupille. Poi tornano.
Piegati, lenti come due zombie, si alzano dal tavolo, percorrono lo stanzone del bar Corso barcollando ed escono nel piazzale.
Io, Caio, Kiki e Ringhy ci guardiamo. Non serve dire nulla. Gli siamo dietro.
Il Bubu e Faccia Tagliata salgono a fatica sul Ciao giallo, il primo alla guida e l’altro buttato sul portapacchi dietro. Partono zigzagando a destra e sinistra. Che manco Capirossi cazzo! Sfilano accanto alla Uno turbo del Vez, che se gliela toccano gli sfonda a pugni il cranio e gli mangia le ossa. Si sbilanciano. Capirossi si sarebbe sicuro stampato. Appoggiano i piedi a terra e riprendono la corsa. Fanno altre schivanelle che sfidano la forza di gravità. Infine girano verso la strada di sassi che costeggia la ferrovia e passa dietro lo stadio.
Li seguiamo a distanza.
«Cosa stracazzo andranno a fare laggiù?» chiede Ringhy.
«Secondo me a spararsi seghe» risponde Caio ridendo.
«Sicuro che vanno a beccare qualche scemo per rifilargli roba rubata» dice Kiki sfregandosi le mani.
«Dai raga, andiamo, veloci che li perdiamo!» insisto, mentre faccio strada.
Il Bubu e Faccia Tagliata percorrono altri cento metri e si imbucano sotto le scalinate dello stadio, nella zona in ombra. Come le pantegane dei fossi.
Noi passiamo dall’altra parte e gli arriviamo alle spalle. Senza farci sentire ci nascondiamo dietro i piloni delle scalinate. A cinque metri.
Visti da qui sono peggio delle pantegane, più sporchi, più puzzolenti, e più morti che vivi. Girano in tondo, inciampano ogni due passi, si inginocchiano vicino al Ciao per cercare qualcosa che devono aver perso dalle tasche, si rialzano barcollando, si abbracciano per non cadere. Poi di colpo il Bubu si irrigidisce, dritto come un bastone, spalanca la bocca senza denti, gli viene su un conato e butta fuori un getto di vomito marrone, tipo sangue marcio. Si sbilancia ancora di più e la brodaglia gli impregna la canotta bianca dal collo allo stomaco.
«Diocàn de to mare troia», attacca a urlare alzando la testa verso il cemento nero, crepato, pieno di muffa dello stadio, «To mare troia del dio del fiol del diocàn».
Faccia Tagliata lo afferra e lo raddrizza come fosse un manichino. Il Bubu si ripulisce la canotta dai resti di vino, quelli che sembrano fagioli marci e sangue e riprende a trafficare con le mani nella tasca del marsupio. Tira fuori un pacchettino di carta stagnola, un cucchiaio annerito, una siringa sporca e un pezzetto di limone flaccido. Faccia Tagliata gli passa l’accendino giallo con le stelle rosse. Si siedono a terra, uno accanto all’altro, e iniziano…
Guardo finché l’ago di acciaio si appoggia alla pelle del braccio.
Guardo finché la punta entra nella pelle.
Guardo finché la siringa si riempie di sangue e poi si svuota dentro. Nelle vene.
Poi chiudo gli occhi.
E nessuno apre più bocca.
Un istante dopo sentiamo la voce del Bubu, persa nella penombra, lì sotto il ponte: «Il negozio ci aspetta, amico, dobbiamo fare basta con questa merda, amico, dobbiamo attaccare il progetto, amico. Da domani, amico. Domani».
Io, Caio, Kiki e Ringhy ci allontaniamo in silenzio, riprendendo la strada del bar Corso.
Siamo quasi arrivati quando Ringhy sussurra: «Noi no, noi non finiamo così, come i tossici. Noi con la roba no».
Nessuno risponde.
Sulla strada principale ci sono tre gruppi di ragazzi che ridono, corrono, si buttano acqua addosso, le ragazze tolgono le magliette, restano in reggiseno, i ragazzi urlano, saltano. Vanno verso il parco Galvani. Stasera canta Vasco.
Li osservo. Non mi viene da ridere.
Nel parcheggio del bar Corso ci guardiamo senza dire niente.
Saliamo sulle biciclette.
Stringo forte le manopole gialle della mia Bmx.
È ora di tornare a casa.
Il pranzo della domenica è in tavola.
“Figli d’asfalto” di Massimiliano Santarossa è tratto dalla raccolta Gli Stonati. Manifesto letterario per la legalizzazione della cannabis, dal 28 settembre in libreria per NEO Edizioni.
Massimiliano Santarossa è nato nel 1974 a Villanova (Pordenone). Ha pubblicato i romanzi Storie dal fondo, Gioventù d’asfalto (Biblioteca dell’Immagine); Viaggio nella notte, Il male (Hacca edizioni), Hai mai fatto parte della nostra gioventù?, Cosa succede in città, Metropoli (Baldini&Castoldi). Il suo ultimo romanzo è Padania (Biblioteca dell’Immagine).
Gli Stonati. Manifesto letterario per la legalizzazione della cannabis include i racconti di Alessandro Berselli, Francesca Bertuzzi, Stefano Bonazzi, Romano De Marco, Federica De Paolis, Barbara Di Gregorio, Marco Drago, Corrado Fortuna, Simone Gambacorta, Yasmin Incretolli, Gianluca Morozzi, Melissa Panarello, Alberto Petrelli, Renzo Paris, Piergiorgio Pulixi, Massimiliano Santarossa, Luca Scarlini, Carlo Vanin, Paolo Zardi, con la partecipazione straordinaria di Gaetano Cappelli, Sandro Veronesi, Marco Vichi.