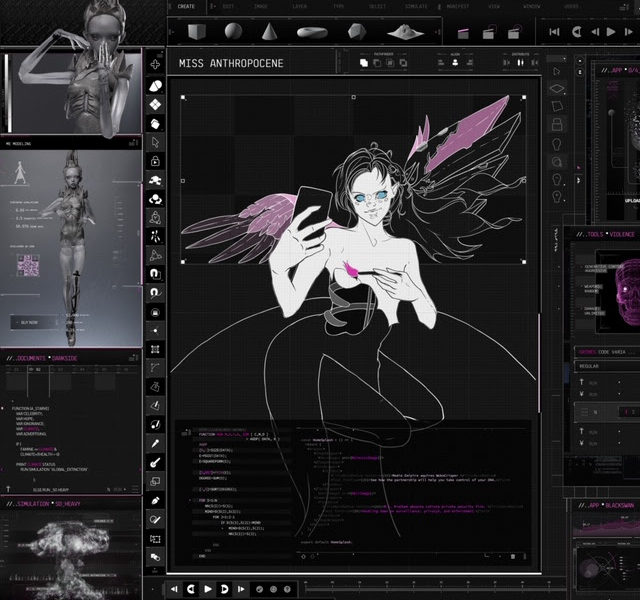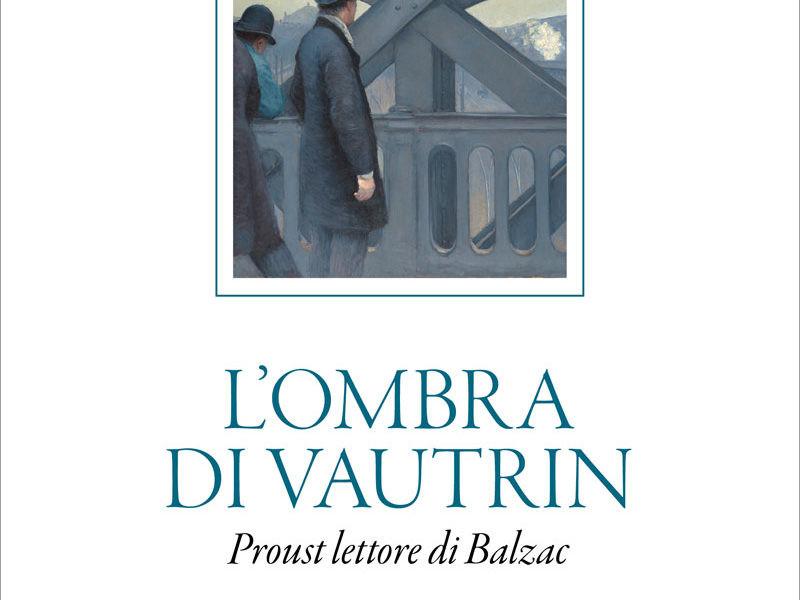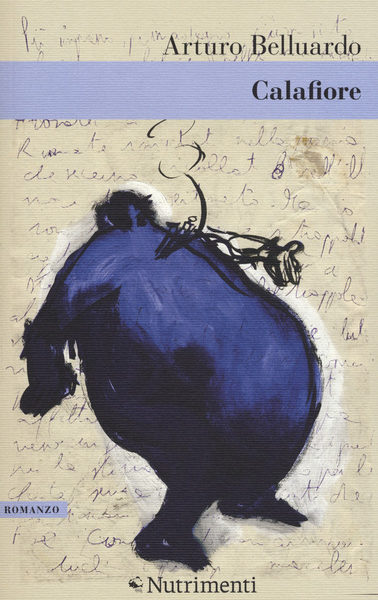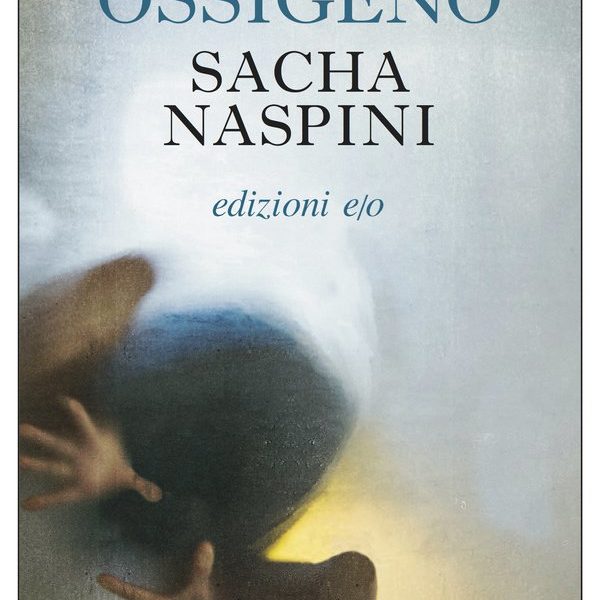Quando ascoltai per la prima volta i Non Voglio Che Clara, avevo circa sedici anni e stavo provando anch’io, come i miei coetanei avevano già fatto, a riscoprire la musica italiana, all’epoca in cui per me la musica parlava soltanto in inglese. Senza restarne mai realmente sedotto, entrai per un breve periodo nel vortice dell’indie, al tempo in cui ancora indie significava qualcosa di concreto, e non tutto e niente, come sarebbe stato di lì a breve.
Scorrendo un po’ a caso in quella lista quasi infinita di artisti dai nomi spesso improbabili che mi appariva su YouTube, mi capitò di ascoltare “La stagione buona“. Aveva un suono così diverso da tutte le altre, un po’ retrò, e si chiudeva con questa frase che non ho più dimenticato: «Dammi il coraggio di sorridere di un sogno / Se non si può esaudire». Anche il timbro della voce che la cantava era diverso, era più adulto e quasi solenne, e mi rimandava a un tempo che potevo ricordare appena, quando le canzoni non si ascoltavano al pc e nemmeno sui dischi, ma sulle cassette.
E poi c’era quel nome così evocativo: Non Voglio Che Clara – e per la prima volta pensai: Clara è un nome molto bello. La troncatura della frase lo rendeva così affascinante. Significava, in realtà, “voglio Clara e nient’altro”, ma poteva significare tante altre cose: non voglio che Clara si sposi (in origine era così, scoprii più tardi), non voglio che Clara se ne vada, non voglio che Clara si ammali, e così via. Ma forse, per quanto quella canzone mi avesse effettivamente ammaliato – l’unica fra le tante – i Clara erano troppo impegnativi anche per me, che a sedici anni dedicavo tutto l’impegno alla musica che sapevo fosse impegnativa (i Pink Floyd, i Radiohead) e ritagliavo per quella italiana solo un momento di svago in cui potevo cantare qualcosa indovinando l’esatta pronuncia, sciolto e spedito.
Salvai soltanto due canzoni: “Le paure” («E metterò da parte tutte le paure che ho / perché a trovare scuse sono bravo / Ma tu non fai sconti neanche di fronte al talento»), e poi naturalmente “Gli anni dell’università“, pezzo più famoso del gruppo stesso per ovvie ragioni, che recuperai – come credo moltissimi – il mio primo giorno da matricola, e che si apriva splendidamente in questo modo: «Lo so, tu non hai niente che non va / Eri già molto meglio di me / Molto prima di me / Ma porti con te il tormento di tutte le cose che / A stento / Del tutto capisco/ E che mi rendono stanco.»
Intanto, proprio quell’anno, era uscito L’amore finché dura, terzo disco del gruppo bellunese (dopo Hotel Tivoli e uno omonimo), ma all’epoca di YouTube e degli mp3, io ascoltavo le canzoni senza ancora ricondurle agli album di appartenenza, per cui non ci feci neanche caso. E non ci fece caso quasi nessuno, da quello che avevo modo di notare. Quando più tardi il fenomeno indie esplose definitivamente, io fui costretto – dall’età, dai luoghi e dagli ambienti che frequentavo, dagli amici che ne furono completamente travolti – a subirlo, e quindi ad approfondirlo, mi accorsi che era raro trovare qualcuno che conoscesse i Clara. Eppure, come in quei tempi ebbi modo di scoprire, la critica musicale ha sempre speso buone parole per la loro musica, ne ha lodato la raffinatezza e ha anche avanzato qualche paragone importante.
I Non Voglio Che Clara nacquero all’inizio del secolo, nel 2000, e rilasciarono il primo album ufficiale nel 2004. Da allora, senza mai fare troppo rumore, hanno realizzato alcune fra le più belle canzoni italiane degli ultimi vent’anni. Nonostante da alcuni siano stati inquadrati come “figli di Bianconi”, i Non Voglio Che Clara sono stati molto di più – e anzi laddove i Baustelle hanno mostrato una sorta di “accartocciamento” in sé stessi, con questo tono così caratteristico da risultare alla fine tanto riconoscibile quanto monocorde, i Clara si sono invece caratterizzati per uno sguardo maturo e malinconico, brillantemente disincantato e insieme elegante o elegantemente ironico (come ne “Gli acrobati“, quando la voce di De Min canta «Anna è convinta che nessuno la descriva meglio di me / Tra le lettere scritte a Firenze pensando a te»).
L’approccio alla scrittura di Fabio De Min – che confessa di passare più tempo a leggere di quanto ne passi ad ascoltare musica – è quello di un dosatore, lontano dalla loquacità che ha caratterizzato la musica italiana degli ultimi anni (una musica che si è mostrata logorroica e ridondante, con tante uscite che si somigliano tutte e che parlano tutte della stessa cosa e lo fanno tutte nello stesso modo). Ascoltare “La mareggiata del ’66“, “Lo Zio“, “Gli acrobati“, “Gli Amori di Gioventù“, ad esempio, per averne conferma.
Il 28 febbraio di quest’anno, dopo un lungo silenzio, il gruppo ha pubblicato Superspleen vol.1, quarto album in studio anticipato da due singoli (“La Croazia” e “Superspleen“) e a breve partirà per un tour nazionale. Ho avuto il piacere di fare qualche domanda a Fabio, ed ecco qui riportata l’intervista.
Vorrei iniziare chiedendoti questo: sono passati più di sei anni dalla vostra ultima apparizione (gennaio 2014). Cosa hai notato, nell’evoluzione della musica italiana, da allora a oggi, e come pensi si rapporti al cambiamento – se c’è stato ed è stato evidente – che ha invece affrontato la musica internazionale? Bada bene: so che, così facendo, prendo in considerazione un concetto molto “astratto” (quello cioè della musica internazionale, da intendersi letteralmente come di ogni Paese al di là dell’Italia) senza tener conto dei diversi generi. Ma ecco, mi spiego meglio: se ogni epoca risulta oggi più o meno riconoscibile per un certo tipo di musica, a quale tipo credi verranno ricondotti gli anni Dieci? E quale pensi sia stata, la posizione della scena italiana, in relazione a questo aspetto? Di partecipazione a un movimento più ampio, o invece eccentrica, o (…)?
Temo di non avere uno sguardo così critico sulla musica da permettermi di risponderti in maniera puntuale, e allo stesso tempo credo che ognuno abbia un proprio tempo, una propria età in cui stabilisce con la musica un rapporto speciale. Il mio risale ormai a qualche anno fa, quando ho cominciato a scrivere e suonare, e oggi mi risulta più difficile stabilire quel tipo di coinvolgimento con la musica che sento. Come musicista ho sempre guardato a ciò che arrivava da fuori, ho sempre pensato che rifarsi alla tradizione cantautorale italiana avesse per me poco senso: scrivo e canto in italiano, appartengo già a quella cosa quindi meglio prendere spunto altrove.
Eppure i Non Voglio Che Clara sono da molti indicati come raccoglitori proprio di quella tradizione, e spesso siete stati accostati a nomi importanti della nostra musica. In un articolo più recente, invece, ho letto chi vi considera figli di Bianconi e del baustellismo [personalmente sono poco d’accordo, ma non importa, ndr]. Al di là delle influenze, esistono artisti, non necessariamente italiani né contemporanei, con cui trovate maggiori punti di contatto – in cui, se si può dire, riuscite a “risentire” un po’ del vostro stile?
Non sono d’accordo nemmeno io, però se devo indicare una scrittura a me affine penso proprio a Bianconi. Solo che lui è più bravo. Non mi dispiace l’accostamento ai Baustelle, ai Perturbazione, a gente che in primis prova a fare della musica e non un prodotto usa e getta buono solo per le radio. Rimanendo in Italia mi piacciono da sempre i Bachi da Pietra, ho amato Aurora de I Cani.
Nel brano omonimo della vostra ultima uscita, fate riferimenti a Baudelaire e Whitman, ma non è la prima volta che i tuoi testi rimandano alla letteratura. Penso per esempio a Il complotto, in cui appare il nome di Bukowski; ma, sempre per restare nell’ultimo disco, cantate che “la vita è altrove”, chiara citazione a quel romanzo di Kundera. Che rapporto hai con la letteratura? Quali sono le opere che hanno maggiormente influenzato la tua scrittura e il tuo pensiero?
Ho un rapporto continuo, ancor più che con i dischi. Nei Clara potresti sentire Saul Bellow, Heinrich Boll, Mario Soldati, ma credo che l’influenza non si possa ridurre a pochi nomi. Va detto che con l’ultimo disco ho cercato di cambiare l’approccio ai testi, trovando una via più funzionale alla musica e meno ispirata alla prosa.
Restiamo sui testi, allora. C’è un verso, nella tua produzione, a cui ti senti particolarmente legato?
No, piuttosto ce ne sono almeno un paio che odio e che se potessi vorrei cancellare, momenti di cui non vado fiero. Non ti dirò quali però.
Comprensibilmente. Esiste, invece, qualcosa di cui avresti voluto cantare, ma che non sei riuscito, per un motivo o per l’altro, a mettere in musica?
A livello di temi, intendi? No, non mi pongo mai un obbiettivo, scrivo partendo sempre da suggestioni esterne. Se invece parli di produzione, uno dei miei sogni è di andare in studio con i Clara e registrare tutto “Oh Era Ora” di Pappalardo.
Mi riferivo, magari, a un’immagine che avevi elaborato, o anche a un’esperienza di vita, che però non sei riuscito ad adattare alla musica.
Direi di no. Però il mio approccio è un po’ diverso, non è che mi succede una cosa e decido che devo farci una canzone. Non è un meccanismo che mi appartiene. Ad esempio, non scrivo mai quando sono triste.
Immagino che ne avrai a decine, come tanti di noi. Ma fra tutti, qual è quel testo che più degli altri ti fa pensare: “avrei voluto scriverlo io”? Non necessariamente italiano, s’intende.
Be’, ce ne sono così tante che non saprei da dove cominciare. Le cose che più mi hanno colpito in tempi recenti sono le canzoni firmate da Mike Cooley nei Drive-by Truckers, penso che ad esempio Filthy And Fried, oltre ad essere una canzone meravigliosa, abbia davvero un testo magnifico.
Prima hai detto di aver modificato l’approccio ai testi per questo nuovo album, allontanandoti dalla prosa e provando ad adattarti meglio alla musica. A questo punto ti chiedo: hai mai pensato di scrivere narrativa? Non necessariamente un romanzo, ma anche solo qualche racconto.
È capitato in passato, all’interno di una raccolta di racconti di vari autori pubblicata dalla Minimum Fax e intitolata Cosa Volete Sentire. Sì, ci ho pensato, ma temo di non avere la costanza né la forza di volontà di scrivere sulla lunga distanza. Non credo nemmeno di avere chissà che cosa di interessante da dire. Intendo che per scrivere romanzi uno dovrebbe in prima battuta essere bravo a immaginare storie, avere la capacità di invenzione. Io non ce l’ho.
Ho letto che sei un amante del black metal, genere che consideri – mi pare – il tuo preferito in assoluto. A proposito di quello che ti piacerebbe fare un giorno: pensi mai di produrre qualcosa di quel genere, magari con una formazione diversa da quella dei Clara?
Mi riferivo al death metal, in realtà, anche se amo molte cose del black. No, non credo succederà mai che io mi cimenti con uno dei due generi. Ascoltare death o black mi permette di ascoltare musica senza pensare: “Oh, potrei inserire una cosa simile in quel pezzo”. Mi permette di essere solo un ascoltatore e non un musicista.
Quindi il tuo essere musicista ha cambiato il tuo modo di ascoltare la musica. Ti ha reso più esigente, e quindi selettivo, oppure al contrario ha allargato i tuoi orizzonti perché ti ha permesso di apprezzare qualcosa che, da fuori, non avevi avuto modo di apprezzare appieno?
Credo che le cose siano in gran parte separate. Ho cominciato a scrivere spinto dall’amore che provavo per certi dischi, ma poi ho trovato subito in mio modo personale, direi più intimo, di confrontarmi con la parte creativa. Il processo emulativo non mi è mai appartenuto, mi sono sempre affidato all’istinto. Piuttosto, scrivendo ho finito con l’ascoltare altra musica, è un po’ come praticare uno sport diverso.
Non mi riferivo a un eventuale processo emulativo, che in realtà non prendo mai in considerazione se penso con stima a un artista (semmai, appunto, ci sono le influenze, ma è un discorso diverso).
Intendevo appunto dire: fare musica ha cambiato anche il modo di ascoltarla. Ma questo ti ha allontanato da alcuni artisti, o perfino generi, perché te ne ha svelato le debolezze, oppure ti ha semplicemente “arricchito”, nel senso che ti ha portato ad apprezzare qualcosa che, da semplice ascoltatore, non avevi per così dire compreso appieno (nel processo di realizzazione, per esempio)?
Mi sono spiegato male anch’io. Intendevo dire che le due cose hanno seguito percorsi diversi: da un lato scrivo e mi confronto con la scrittura, dall’altro gli ascolti hanno seguito un proprio percorso scevro da implicazioni tecniche. Cerco di ascoltare musica senza farmi troppe domande di carattere teorico o tecnico, l’ascolto e basta. Poi è probabile che io riesca a riprodurre o trascrivere la maggior parte della musica che ascolto, ma cerco di non pensarci. Questo mi ha sicuramente portato ad ascolti più “esotici”, ma non valuto la musica che ascolto su basi tecniche o teoriche.
Avete già spiegato che il nome del vostro gruppo significa “Voglio Clara e nient’altro”, anche se, leggevo, in origine si riferiva a una frase di un libro di Pennac, cioè “Non voglio che Clara si sposi”, e in questo caso la troncatura della frase mi sembra una trovata capace di rendere il nome molto suggestivo. Ma Clara è esistita davvero per te?
No, era una suggestione e nulla più. In origine era proprio Non voglio che Clara si sposi. Ma era troppo lungo, e così l’abbiamo accorciato.
Abbiamo parlato di letteratura e, ovviamente, di musica. Sei anche un amante di Cinema? Quali sono i tuoi autori?
Sì, mi piace, anche se non lo seguo più molto. Billy Wilder, Woody Allen e Michael Haneke sono i miei monografici, quelli di cui ho cercato di vedere tutto.
Come vivi i giorni successivi all’uscita di un nuovo album? Mi riferisco soprattutto a quest’ultimo, che arriva dopo diversi anni di silenzio e dopo che il vostro nome è cresciuto.
Abbiamo mille cose da fare: la promozione, la preparazione del tour, e poi stiamo lavorando al materiale per il secondo volume e alle ristampe dei lavori fuori catalogo. Insomma, il lavoro non è finito, ci attendono mesi piuttosto impegnativi, ma siamo contenti.
Puoi provare a spiegarci come nascono le vostre canzoni – e se il tuo nuovo approccio alla scrittura ha cambiato anche la costruzione dei pezzi per l’intero collettivo?
Ogni disco ha richiesto un processo diverso. Per Superspleen abbiamo scelto un lotto di canzoni fra quelle che avevo a disposizione, siamo stati in sala per un po’ a provare delle cose, poi ognuno di noi ha lavorato in autonomia sui brani. Alla fine abbiamo messo tutto insieme e affidato il mix a un produttore di fama come Fabio Trentini. Ci serviva uno sguardo esterno e competente, e Fabio è riuscito a cogliere le intenzioni della band mettendo ordine alle nostre sessioni. Il suo è stato un contributo davvero importante.
Hai confessato prima di avere dei momenti di cui non vai fiero, ma immagino si tratti di casi isolati. In generale, da Hotel Tivoli a Superspleen, come valuti il percorso dei Non Voglio Che Clara? Pensi che siate effettivamente giunti a una maturazione, avvicinandovi a una forma “ideale”? O preferisci considerare ognuno dei quattro dischi in autonomia, anziché opera unica all’interno della quale individuare una possibile evoluzione?
Innanzitutto la formazione è cambiata per 3/4 rispetto ai primi due lavori. Dei Cani è lo spartiacque fra la prima formazione dei Non Voglio Che Clara e quella attuale. Se dovessi parlare di un percorso, questo parte da Dei Cani, e dieci anni di musica con l’attuale formazione sono certamente un percorso, sia artistico che umano. Ho sempre scritto canzoni, poi le abbiamo raccolte solo ogni 4 o 5 anni, ma non fa differenza per me, molto semplicemente col passare del tempo cambia l’approccio alla scrittura, si cambia come persone, si migliora (si spera) come musicisti. È questo che fa sì che Hotel Tivoli suoni profondamente diverso da Superspleen.
Chiudiamo con un paio di domande sul futuro.
Hai mai sognato una collaborazione internazionale? Dovendo fantasticare, con quali artisti internazionali, che magari consideri un po’ affini a voi, ti piacerebbe poter realizzare della musica?
Penso più che altro a dei produttori, per esempio a un Dave Fridmann. Sarei davvero curioso di vederlo all’opera.
In un verso di Superspleen dici che non sai quando smetterai di cantare. Mi viene in mente quella celebre frase di Mick Jagger, poi ampiamente smentita. Naturalmente tu sei ancora giovane, ma pensi che gli artisti musicali, più degli altri (scrittori, registi, attori, fotografi, e così via) siano soggetti, tendenzialmente, ad avere una carriera più breve, proprio perché ne risentirebbero le performance?
Non credo. Canto molto meglio oggi di quando ero ventenne, per cui credo che la performance conti poco. Piuttosto magari è la noia a prendere il sopravvento, il fatto di non divertirsi più a fare una certa cosa.