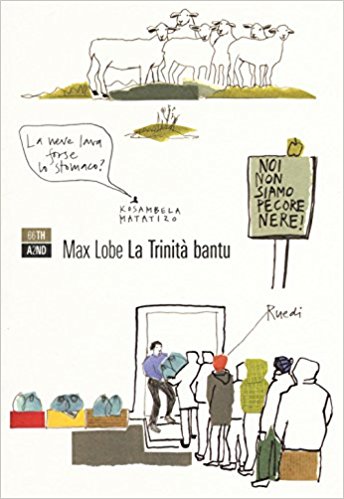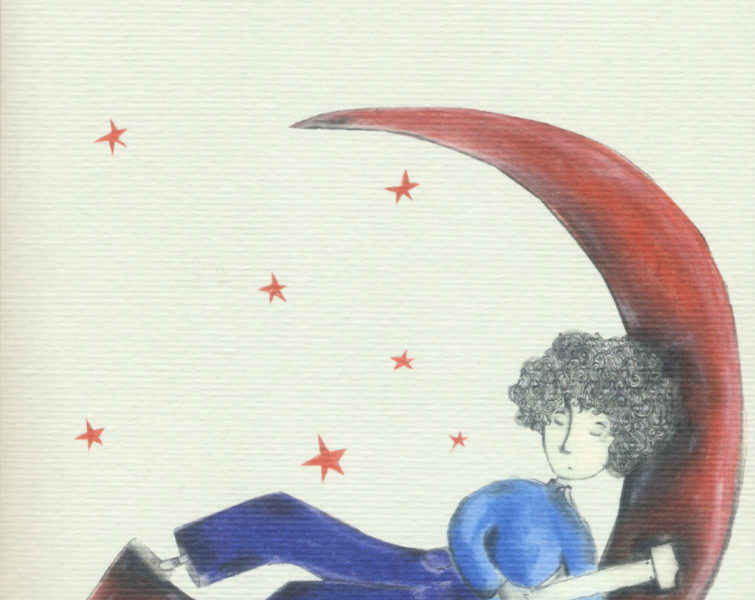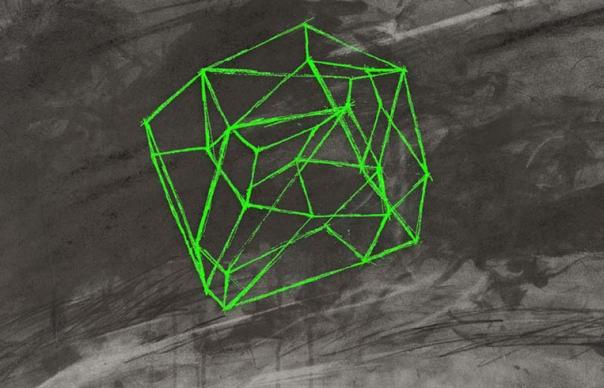È un giorno in cui su Roma incombe un cielo grigio e carico di pioggia e il caldo estivo sembra un miraggio lontano quello in cui mi ritrovo a parlare con Luca Franzoni di Solstizio (AUGH! Edizioni, 2017), il suo terzo romanzo. Perciò è impossibile non cominciare da qui, dall’inizio dell’estate.
Il tuo romanzo si svolge tutto nell’arco di una giornata, durante la quale le vicende di personaggi molto diversi tra loro si incrociano fino a concludersi in un unico epilogo: una festa organizzata sui social network da una star del web, Arturo Cash Calesci. C’è una ragione narrativa, o magari personale per la scelta di una data precisa, il 21 giugno?
È più una ragione simbolica. Volevo scrivere una storia che parlasse di tempo; di tempo che finisce, di tempo che manca. Mi affascinano i simboli, e il solstizio d’estate è il giorno più lungo dell’anno, che segna però l’accorciarsi del giorno. Quindi è un po’ come una nascita che precede la morte. È come un ciclo. L’ho scelto per questo: per un valore simbolico, non personale, e forse neanche narrativo.
Nel tuo romanzo c’è molta vita, allo stesso modo in cui c’è molta morte e sin dall’inizio si avverte una sensazione di mancanza di tempo.
Sì, esatto. Volevo dare proprio quello.
Se proviamo a pensare il romanzo come ad un intreccio di punti di vista diversi, non possiamo non soffermarci sulla molteplicità di prospettive: all’inizio esponi una vicenda così com’è vista da un personaggio, ma poco dopo questo racconto viene smentito da quello di un altro, che ne dà una visione opposta (e ciò è particolarmente evidente nel caso di Vanessa e di suo marito Paolo e, forse in modo ancora più scioccante, dei loro figli, i gemelli Kevin e Maicol).Questo artificio rende la verità difficile da decifrare fino alla fine, ma sottolinea come in fondo non sia importante la storia in sé quanto la percezione propria di ognuno dei tuoi personaggi, così diversi eppure accomunati da alcuni tratti. Mi puoi parlare un po’ di loro? Chi sono? Da dove vengono?
Vengono dal mio interesse per personaggi un po’ squilibrati, imperfetti. Realistici ma grotteschi, esagerati. Nel costruire un personaggio mi piace cercare un difetto ed esagerarlo, in termini magari non realistici, ma che mi permettono di creare un personaggio più tridimensionale e, paradossalmente più vero. In realtà mi interessano i perdenti. Nel caso di Solstizio lo sono tutti: sia i ricchi, coloro che hanno avuto successo, sia i poveri. I due personaggi principali, Federico e Arturo – il protagonista e l’antagonista, i due che stanno morendo – dovrebbero essere il fallito e l’arrivato, eppure sono entrambi due squilibrati che reagiscono in modi diversi al tempo che sta finendo. Mi interessa molto analizzare questi personaggi nella situazione limite, quando vengono fuori certe pulsioni nascoste, animalesche; anche nei gemelli viene fuori una violenza che di solito non si pensa di trovare in un bambino.
Questo minimo comun denominatore mi è sembrato riguardare più gli uomini che le donne, mi sbaglio?
Rappresento gli uomini sempre dal punto di vista della violenza, come se fossero la forza negativa. Le donne invece sono un po’ diverse. Per esempio, Vanessa è volutamente stereotipata: parte come vittima, ma poi si sviluppa in un altro modo. Il mio personaggio femminile preferito però è Maria, la ragazza vampiro: lei si contrappone per vendetta a un mondo maschile violento e prevaricatore ed è come se fosse una vendetta femminile animalesca su questo mondo dominatore, forse non in quanto femmina ma in quanto forza non umana, contro un’umanità che nell’intero romanzo non fa un’ottima figura.
Si sente nella tua scrittura una delicatezza particolare nei confronti di Maria, le parti del romanzo in cui appare sono quelle che colpiscono di più. Il ritratto finale è quello di un personaggio feroce, che riesce a mettere a posto le cose in modo istintivo, senza il bisogno di una razionalità tutta umana che invece non risolve nulla. A questo proposito, vorrei soffermarmi sul filo conduttore di tutto: il sangue. È come una ricorrenza, dà vita a una sorta di pastiche di generi e l’emblema è proprio la vicenda della ragazza vampiro. Da dove nasce l’importanza di questo elemento?
Questa componente di natura verso cultura, o animalesco verso società civilizzata è un tema classico ma è anche un riferimento a Carrie di Stephen King, e al film di Brian de Palma. La vera natura di Carrie, il suo potere, si rivela con le prime mestruazioni, ma ritorna nel finale, con il sangue rovesciato su di lei come scherzo nella scena del ballo, in cui lei dopo si scatena e uccide tutti.
Ritorna in modo esplicito anche nella vicenda di Scimmia Sacra e Cane Kalvo…
Esatto, sì. Questo riferimento è qualcosa che mi è rimasto dentro nella lettura del libro e nella visione del film che dicevamo prima, ed è un elemento simbolico di potere. Il sangue è il potere contro cui questi piccoli uomini che partecipano a una festa senza senso, basata su Facebook – sul nulla – non possono fare niente. È come avere a che fare con un tornado: è una forza della natura contro cui non puoi fare nulla.
Un elemento singolare è la presenza di Facebook: torna più volte e tu lo definisci «il niente». Eppure questo niente appare in realtà come il contenitore di un vuoto di valori avvertito da tutti i personaggi, sebbene in forme diverse. Un vuoto che Arturo – un antagonista in apparenza anche piuttosto scemo, passami il termine – rappresenta attraverso una citazione di Petronio,e soprattutto attraverso l’epilogo della sua festa. Sembra proprio un tratto comune: ognuno ha bisogno di appoggiarsi a degli ideali, a delle ideologie, per sostenersi.
Non vorrei esagerare, il mio è un romanzo piuttosto leggero e di genere, pur giocando con la contaminazione, però si tratta di una rappresentazione piuttosto pessimistica del mondo e dell’umanità. Non c’è un giudizio morale esplicito, e quelli messi in scena sono certamente personaggi vuoti, ma non vorrei che fossero percepiti come annoiati dal vuoto esistenziale, quanto piuttosto colpiti dalla mancanza di qualcosa cui aggrapparsi, che pure cercano. Tutti (anche Arturo, che è l’antagonista ed è in un certo una macchietta, un cattivo dei film di James Bond) tendono verso qualcosa, cercano, anche se non si sa cosa: non si fermano, non si arrendono, anche in modo crudele, terribile e molto istintivo. Tutti, sia i personaggi positivi che quelli negativi – se è davvero possibile fare questa distinzione –, cercano in modo istintivo l’amore, la possibilità di uscire da una solitudine che non riescono più a sostenere.
Quindi per uscire dalla solitudine è necessario superare un certo individualismo?
Sì. Per questo è interessante che tutto trovi sfogo in un’esperienza comunitaria com’è la festa del solstizio d’estate.
Una festa molto realistica, molto attuale, potrebbe succedere domani…
Sì, molto realistica, molto à la Sorrentino. È una festa che guardo con occhi benevoli, rappresenta un desiderio disperato dei protagonisti di stare insieme.
La festa di Arturo Calesci ci porta inevitabilmente a parlare di uno dei temi più presenti in Solstizio: il nazismo. Neonazisti tra i personaggi, ragazzi che si sono incollati addosso un’ideologia, svastiche tatuate a cui ciascuno ha attribuito significati molto diversi, chiari riferimenti ai campi di concentramento e soprattutto alla razionalità dello sterminio. Come mai?
Ecco, queste cose che vengono fuori mentre scrivi,non hanno nulla di programmato. Ho inserito il personaggio di Mirco e in un momento in cui non esisteva né lui né il suo gruppo di amici. Che sono dei nazisti, ma da narratore non sono interessato al giudizio su questo: è scontato che siano cattivi. Però questi personaggi sono nati con una funzione: volevo rappresentare questo male attraverso giovani che ne sono attratti e plagiati. Volevo raccontare questo male, assoluto, inutile e immotivato, un male contro cui non puoi fare nulla, umanizzando i piccoli personaggi che lo rappresentano. All’inizio è facile esserne respinti, ma poi si finisce per seguirli nella loro avventura e soprattutto nella loro disperazione, perché agiscono da disperati, senza ragione. In parallelo con quello che sta facendo Arturo, tra l’altro: è per questo che ci sono i dottori, la metodologia con cui comincia questa specie di allegro sterminio, di allegro suicidio, il quale in modo grottesco ricalca i campi di concentramento. È un modo per rappresentare l’assurdità, la banalità del male, ancora più banale se si pensa che è banalizzata dai social, dall’idea di condividere tutto ciò che si fa. Quindi persino questo male ne esce ancora più svuotato.
Intendevo questo quando ti ho detto che potrebbe succedere domani. È proprio la ragione di fondo di questa banalità: tutti vanno con assoluta leggerezza a questa festa, a questo allegro suicidio e tu ad un certo punto dici che è come se questa fosse organizzata da un ingegnere – lo stesso principio alla base dei campi di sterminio. La razionalità e, al contempo, la leggerezza con cui tutto avviene fa spavento. Non trovi?
Sì, è senza responsabilità. Tutto viene fatto senza considerare le conseguenze, è slegato dai valori.
I neonazisti che parlano di Eva Braun si ricoprono di simboli svuotati di senso per dare voce a un male tutto loro e non sembrano neppure immaginare cosa sia davvero il male. Non sono loro, è Arturo il vero male.
Quello che fa Arturo è il male, sì, e loro sono in un certo modo moralmente superiori: in fondo cercano qualcosa. Questo gruppo di personaggi secondari grotteschi e non realistici è solo alla ricerca di qualcosa per riempire un vuoto. Lo trova nel nazismo.
Non sono in fondo così diversi Scimmia Sacra e Cane Kalvo, i due “neo post punk neo romantici’’ – quest’ultima una definizione bellissima per due adolescenti che cercano a ogni costo un modo per darsi un’identità.
Da questo punto di vista sono uguali, ma loro due hanno un’unicità che mi piace molto. La loro contrapposizione, il loro essere in due contro il mondo è una cosa molto adolescenziale. È l’elemento romantico che ho voluto inserire nel libro: mi fanno molta tenerezza questi due adolescenti che, come in Natural Born Killers, sono soli contro il mondo e hanno solo il loro amore, talmente acerbo che forse non può neanche essere definito amore. Qualcosa però di assoluto.
Il loro amore così assoluto si contrappone a quello che Federico prova per Eva, un amore adulto venato però di ossessione, inquietudine e follia.
È vero, mi ci fai pensare adesso, ma è così, l’amore di Federico ed Eva è contrapposto a quello dei due ragazzi perché non è assoluto: è adulto. E al di là della follia di Federico, che lo rende un rapporto deviato, è un rapporto complicato, in cui c’è l’amore, il desiderio, la vendetta e poi dalla vendetta si torna ad un’apertura, che non trova soluzione nel finale.
E quello tra Vanessa e Paolo che tipo di rapporto è, dove si può collocare?
Vanessa è piuttosto stereotipata, e anche Paolo. Ho preso il loro caso come un esempio quasi da cronaca el’ho sviluppato come tale ma deviando poi per approfondire i due personaggi. Il loro è un altro tipo di rapporto d’amore, sempre adulto: è un rapporto di potere, assai diffuso, prevaricatore, in cui l’uomo possiede la donna e la donna, fino a un certo punto, non è in grado di reagire.
Almeno fino a quando il rapporto non si rovescia: perché sì, Vanessa è stereotipata, ma si rivela in fondo molto più forte di lui.
È un rapporto di potere sul piano culturale: Paolo possiede Vanessa e crede di essere più intelligente, di avere più cultura. Quando poi entra in scena è anche lui un poveretto, un fallito, uno che voleva arrivare ma non ce l’ha fatta e ha sposato questa ragazza bellissima per poter sfogare le sue frustrazioni. Quando infine tutto accade, viene fuori la sua natura perversa e lui stesso si rivela una vittima.
Quindi un altro modo per dire che la razionalità e la cultura sono importanti, ma di fatto è l’istinto a entrare in gioco?
All’atto della sopravvivenza è una questione di sangue.
Ripensando più tardi alla nostra conversazione, mi viene in mente che Solstizio ha qualcosa di un puzzle: le figure che lo compongono si mostrano un pezzo alla volta, man mano che nuovi elementi si aggiungono a rendere il quadro più nitido, più leggibile.
Parlare singolarmente delle figure che ne fanno parte, dei pezzi di vite così diverse che rappresentano, mi era forse necessario per cogliere appieno questo quadro, per restituirgli un senso e riuscire a raccontarlo.
È forse questo a rimanere più di tutto del romanzo: non troppo le vicende, le singole scelte che i personaggi di Franzoni compiono, quanto i loro volti, le loro espressioni, le follie e inquietudini che li muovono e che li portano ai gesti più estremi.
La sensazione che ciò che vale per loro valga in fondo per tutti: che all’atto pratico sia tutto solo una questione di istinto.
(Luca Franzoni, Solstizio, AUGH! Edizioni, 2017, pp. 182, 13.00€)